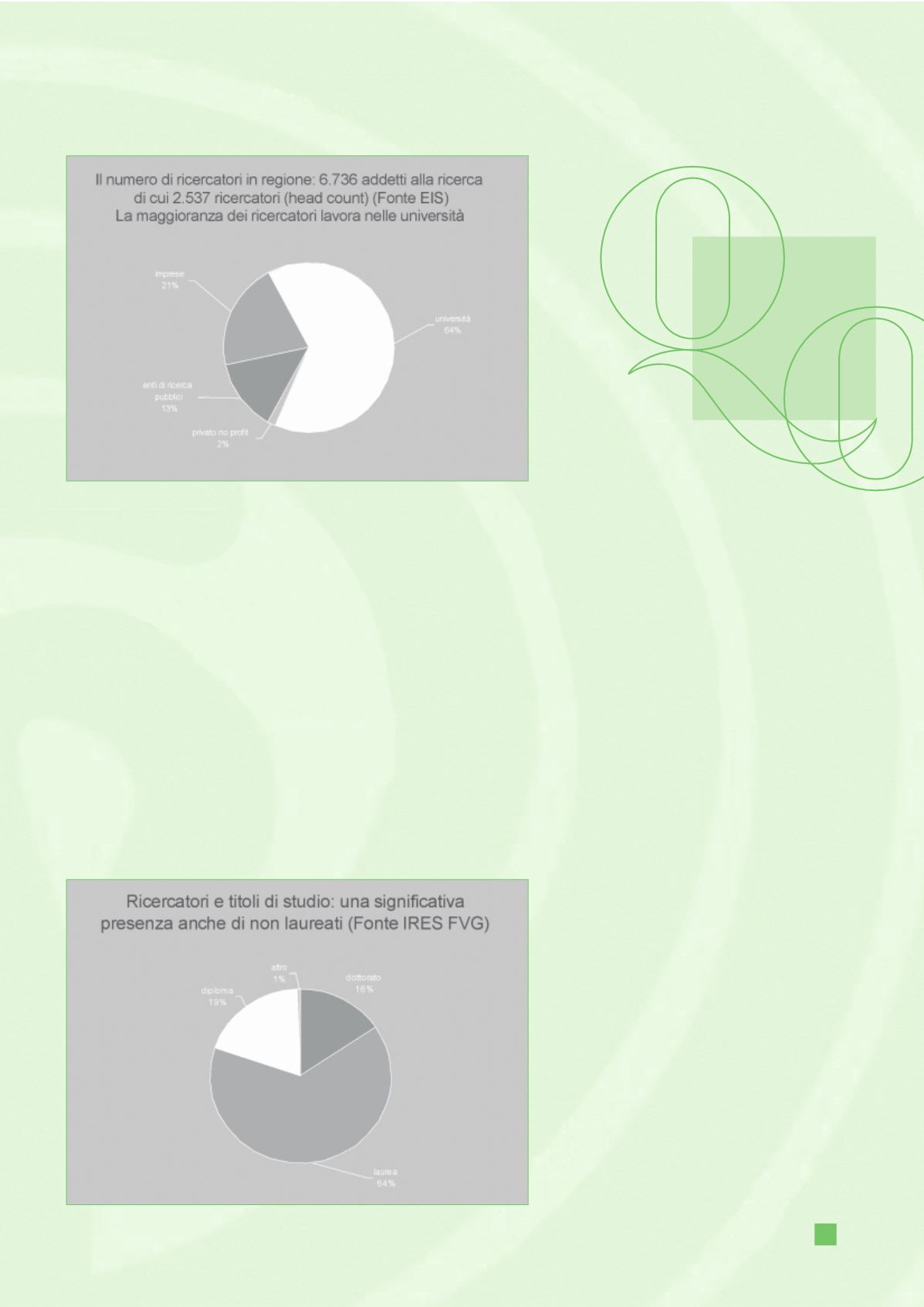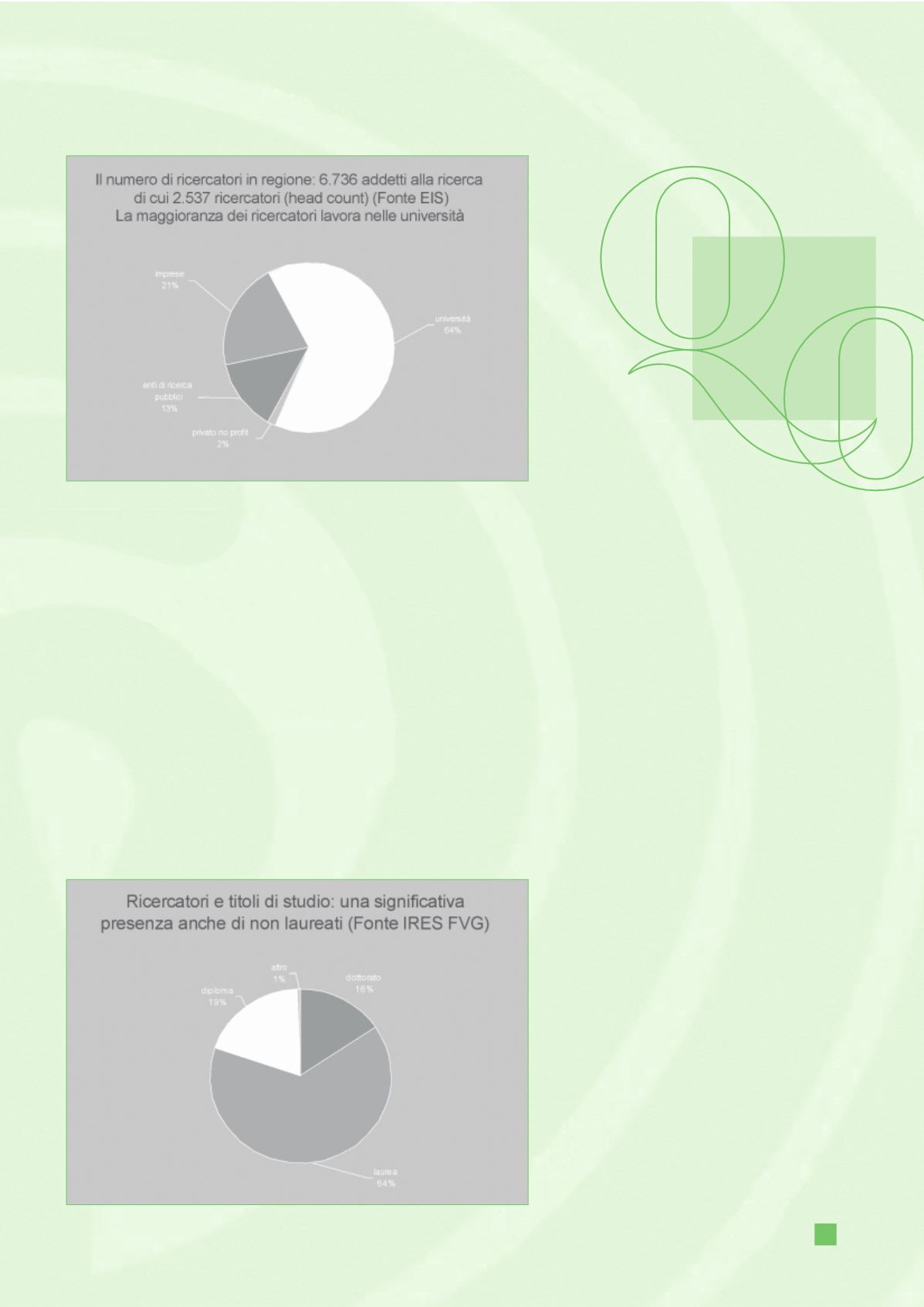
17
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
28
presa e il mondo degli enti di ricerca.
Vedete che, per quanto riguarda le
piccole imprese, la peculiarità è che
si tratta di imprese che hanno il loro
core-business proprio nell’attività di
ricerca. Queste sono principalmente
le imprese insediate nei parchi tecno-
logici o spin-off universitari. Per
quanto riguarda le medie e le grandi
imprese, queste riproducono quella
che è la struttura industriale regiona-
le e quindi i settori della meccanica,
della metallurgia. Per quanto riguar-
da gli enti di ricerca, invece, vedete
come la fanno da padrone le attività
nel campo delle scienze naturali e
delle scienze sociali.
Passiamo ad analizzare lo stock di
ricercatori. Anche qui è necessaria
una premessa. Non è sempre facile,
a livello statistico, andare a indivi-
duare il numero di ricercatori,
innanzitutto perchè è già difficile
definire con precisione cos’è un’atti-
vità di ricerca. Inoltre spesso, specie
nel mondo delle imprese, tale attivi-
tà è percepita in maniera distorta.
Un altro problema è che la profes-
sione del ricercatore è una professio-
ne che dà adito anche a molte colla-
borazioni tra i vari sistemi; pensiamo
al caso di un professore universitario
che può essere un consulente per
un’impresa, può svolgere la propria
attività di ricerca nell’ambito dell’u-
niversità e magari essere socio di
un’altra impresa come ad esempio
uno spin-off universitario.
A grandi linee, utilizzando la misura
di unità equivalente a tempo pieno,
possiamo dire che in regione ci sono
circa 1.500 ricercatori. In Italia sono
stimati attorno a 70.000. Come si
può vedere dal grafico (Fig. 6), la
maggioranza di questi è occupato
nelle università regionali. Se contas-
simo invece per teste il numero sali-
rebbe ovviamente, possiamo parlare
di circa 2.500 ricercatori. Utilizzan-
do questo dato in termini di compa-
rabilità europea, esistono statistiche
che forniscono numeri anche supe-
riori. Come vedete il ruolo predomi-
nante dell’università è ancora più
evidente da questo grafico (Fig. 7).
Per quanto riguarda invece le impre-
se, siamo andati a valutare quelli che
sono i titoli di studio dei ricercatori.
Potete vedere che il 64% sono lau-
reati e il 16% ha un dottorato di
ricerca. Esiste anche un 20% di
diplomati che, specie nelle medie
imprese, svolgono attività prevalen-
temente di sviluppo tecnologico
(Fig. 8).
Passiamo a quelle che sono le con-
clusioni forse più interessanti e origi-
nali dei dati derivanti da quell’anali-
si: qual è il trend occupazionale?
Abbiamo potuto valutare, suddivi-
dendo le imprese intervistate in
impresa a bassa, media e alta inten-
sità di ricerca e sviluppo, le tenden-
ze occupazionali del biennio 2004-
2005. Guardando questo dato (Fig.
9) si può già rapidamente osservare
come di fatto la ricerca paga in ter-
mini occupazionali, nel senso che,
ben ricordando che questo è un
campione che riguarda solo gli enti e
le imprese che fanno ricerca, potete
osservare come a fronte di una situa-
zione di mercato del lavoro che vede
sempre più frequenti le crisi occupa-
zionali, le difficoltà di occuparsi, le
imprese che invece fanno ricerca
denunciano il mantenimento dello
stock occupazionale o addirittura
una sua crescita.
L’altro elemento interessante ed
abbastanza evidente è l’esistenza di
una proporzione diretta tra quella
che è l’intensità di ricerca e le pro-
spettive occupazionali. Vedete che
le imprese che sono classificabili
come imprese con un’alta intensità
di ricerca prevedono, o meglio,
hanno realizzato un incremento
anche rilevante degli occupati.
Quali sono però le problematiche
del mercato del lavoro? Anche in
Fig. 7
Fig. 8