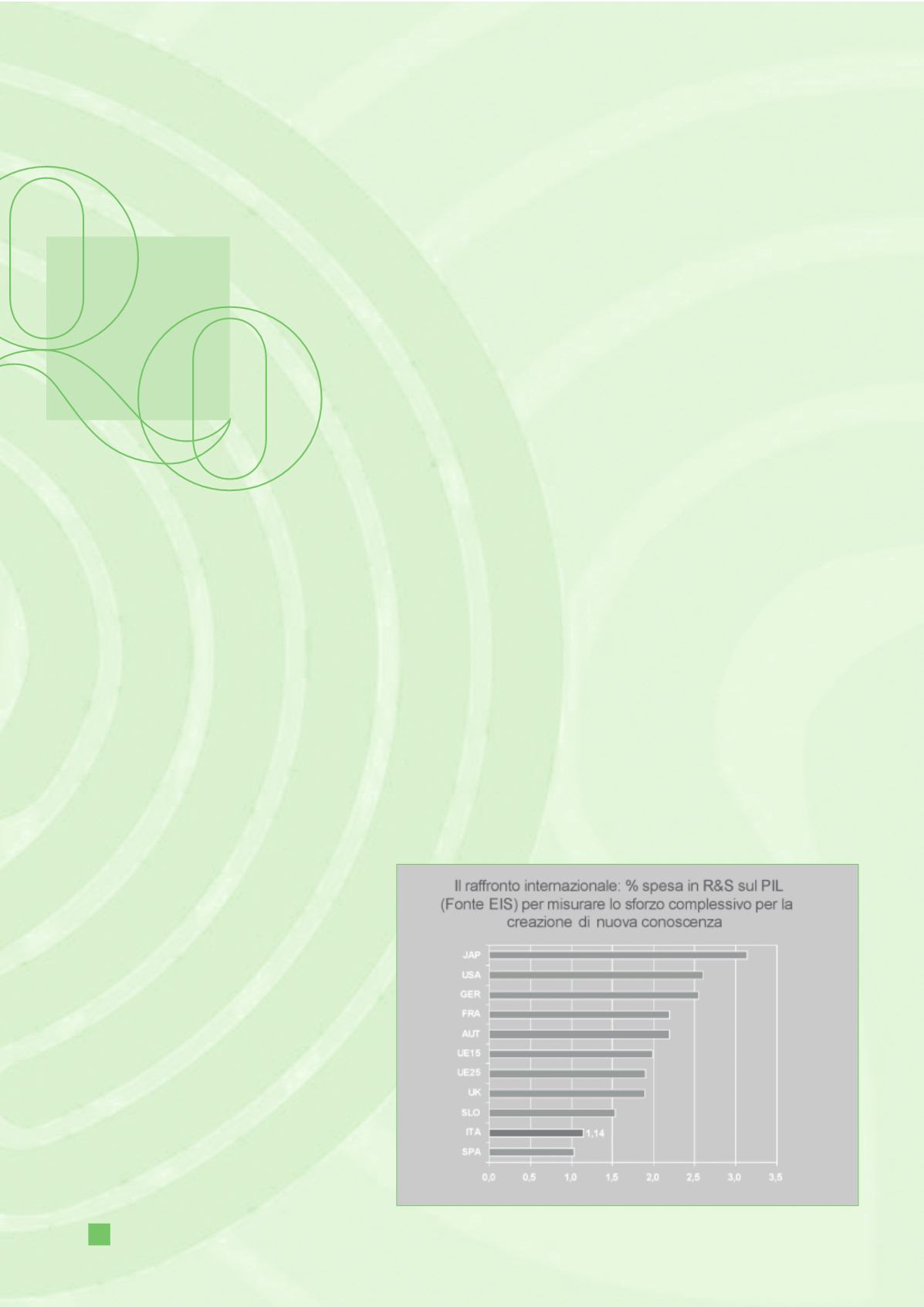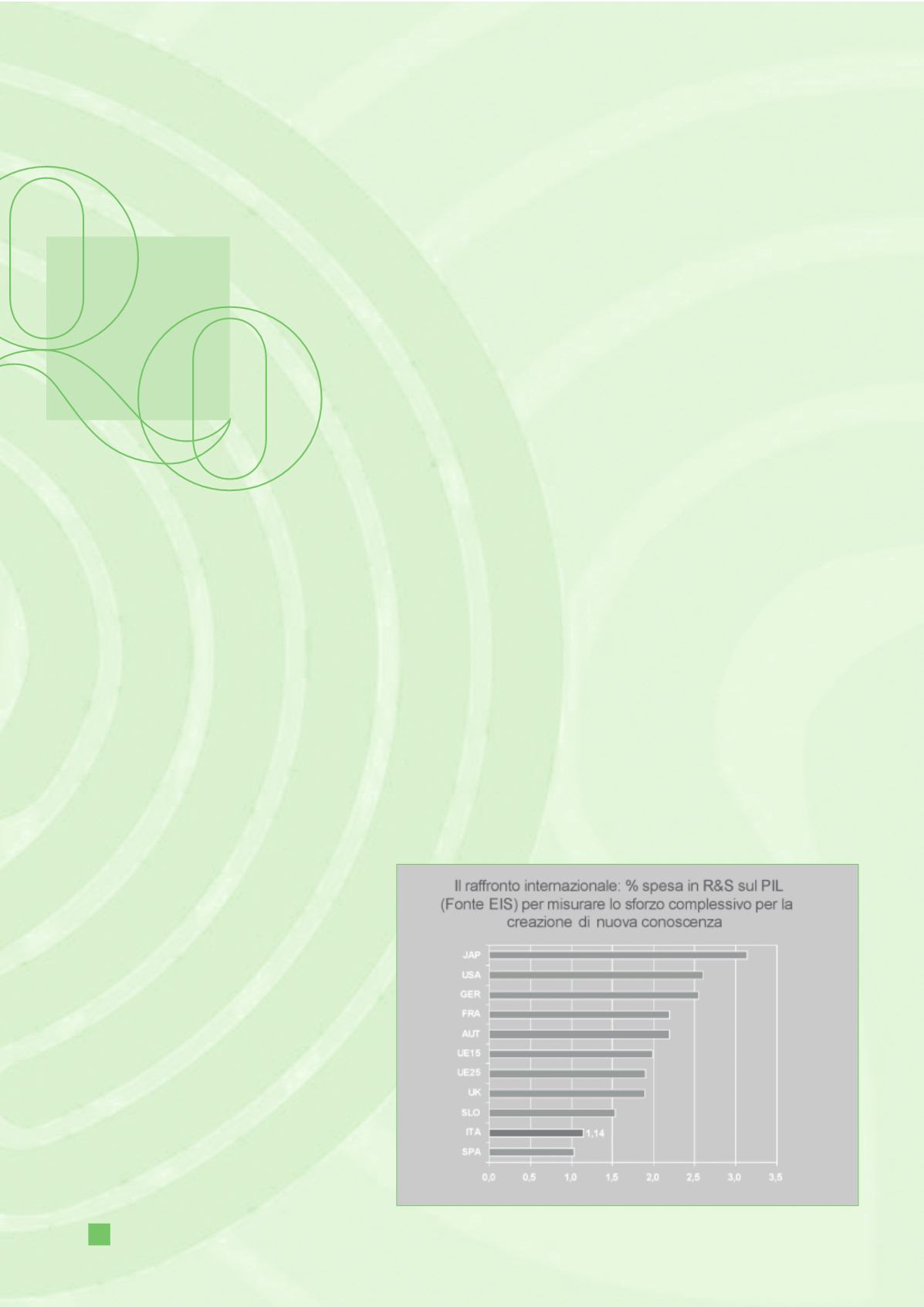
14
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
28
Una cosa fondamentale, che è stata
sottolineata più volte oggi: mai da
soli!
Ho imparato la logica del lavorare in
gruppo. La prima cosa che dovrebbe
essere insegnata a un ricercatore
ancora quand’è veramente alle ele-
mentari, è che lavorare in modo
individuale non premia assoluta-
mente e che non si può sapere tutto.
Altra cosa parallela al fare ricerca,
quella di gestire un gruppo. Ed ecco
che, allora, in questi anni sono
diventato il coordinatore di questo,
qualche volta qualcuno lo chiama
“carrozzone”, a me piace chiamarlo
“gruppo di amici”; in realtà ci occu-
piamo di promozione, essenzial-
mente, di marketing e di bench mar-
king; sono 12 aziende, il gruppo
ambiente dell’Area di cui io sono
coordinatore. Questo gruppo riesce
con questa massa critica a usare gli
strumenti, che prima sono stati
molto ben elencati da Area Science
Park; sono strumenti che proiettano,
nel nostro caso, le aziende, ma tutte
aziende con ricercatori al loro inter-
no; qui ci sono tutti i laboratori di
ricerca e sviluppo anche di aziende
che hanno altre sedi, ma qui c’è la
parte di ricerca e sviluppo, i cui set-
tori ve li ho mostrati prima (laborato-
ri e progettazioni, non solo, anche
consulenze). E Area, quindi, attraver-
so tutto quello che sentivamo prima
di movimentazione e di frequenta-
zione di luoghi europei, una massa
critica come quella permette di inse-
rire il gruppo ambiente in grossi pro-
getti comunitari come Innovation,
legarsi alla rete dell’Innovation
Relais Centre ma non solo, al net-
work come Innovation Network, e
partecipare come gruppo al trasferi-
mento proprio di questa conoscen-
za. E, parliamo, ripeto, di aziende
con ricercatori.
Tornando alla domanda iniziale: “Il
ricercatore è in azienda o l’azienda
stessa è il ricercatore?” Avendo utiliz-
zato questa storia un po’ fumettara e
spero non troppo noiosa, io direi che
è più spesso possibile la seconda.
Quindi, se dovete dare un messaggio
positivo a chi si orienta verso il
mondo della scienza, è che portando
avanti degli argomenti di proprio
interesse si può anche sviluppare e
avere un proprio reddito; si può
riuscire a costruirsi il contesto lavora-
tivo intorno, ciò è possibile. Quindi,
per chi orienta, per chi insegna, per i
docenti è importante recuperare,
come dicevo prima, tutti i tasselli
della vita di ognuno e aiutarlo un
poco a fargli capire che comunque
sono patrimonio importante per lo
sviluppo della ricerca professionale o
della professione di ricercatore.
Marco Francese
Shoreline s.c.r.l.
IL MERCATO
DEL LAVORO REGIONALE
NELLA RICERCA
DOTT. MARCO PASCOLINI
RICERCATORE IRES FVG
Buon giorno a tutti. Io sono un po’
sfortunato perché parlo per ultimo e
quindi già questo generalmente non è
molto apprezzato dalla platea dopo
una lunga mattinata; in più intervengo
dopo due interventi brillanti mentre io
dovrò parlare sostanzialmente di dati,
perché l’obiettivo della mia relazione
è quello di fornire un quadro quanti-
tativo di molte delle cose di cui si è
parlato oggi. Proporrò quindi una
visione di quello che è il mercato del
lavoro regionale della ricerca. Ho cer-
cato di recuperare i dati maggiormen-
te rilevanti, ovvero quelli classici
dell’Istat e quelli dell’European
Innovation score board che costitui-
sce il punto di riferimento per il con-
fronto internazionale. Ho potuto poi
utilizzare in particolare i dati di una
ricerca sviluppata nell’ambito del
progetto D4, che è stato precedente-
mente citato, e che ci consente di
avere un quadro più approfondito di
quella che è la situazione regionale.
Una premessa è necessaria, però.
Diciamo che parlare di mercato
regionale dei ricercatori è quantome-
no riduttivo nel senso che, come tutti
gli interventi di questa mattinata
hanno dimostrato, la professione di
ricercatore è in assoluto una di quelle
a più alta mobilità. Quindi, la doman-
da e l’offerta di ricercatori si sviluppa-
no su quello che è di fatto un merca-
to planetario. Ridurle a un confronto
su un territorio piccolo come quello
del Friuli Venezia Giulia, è dunque
parzialmente improprio. Cerchiamo
comunque di affrontare anche questo
ragionamento.
Proprio per questo motivo parto
mostrandovi alcuni dati relativamente
a quello che è uno dei problemi prin-
cipali, più volte citato nell’incontro
odierno, ovvero, al di là della volontà
e delle parole su cui tutti di fatto con-
cordano relativamente all’importanza
di investire in ricerca e sviluppo, la
realtà di tale situazione.
Come vedete, questo grafico (Fig. 1)
mostra quello che è lo stato degli
investimenti in ricerca e sviluppo
proporzionati al PIL, per quanto
riguarda il nostro paese rispetto a
quelli che sono i paesi di riferimento
con cui dobbiamo confrontarci.
Vedete che al di là di quelle che sono
Fig. 1