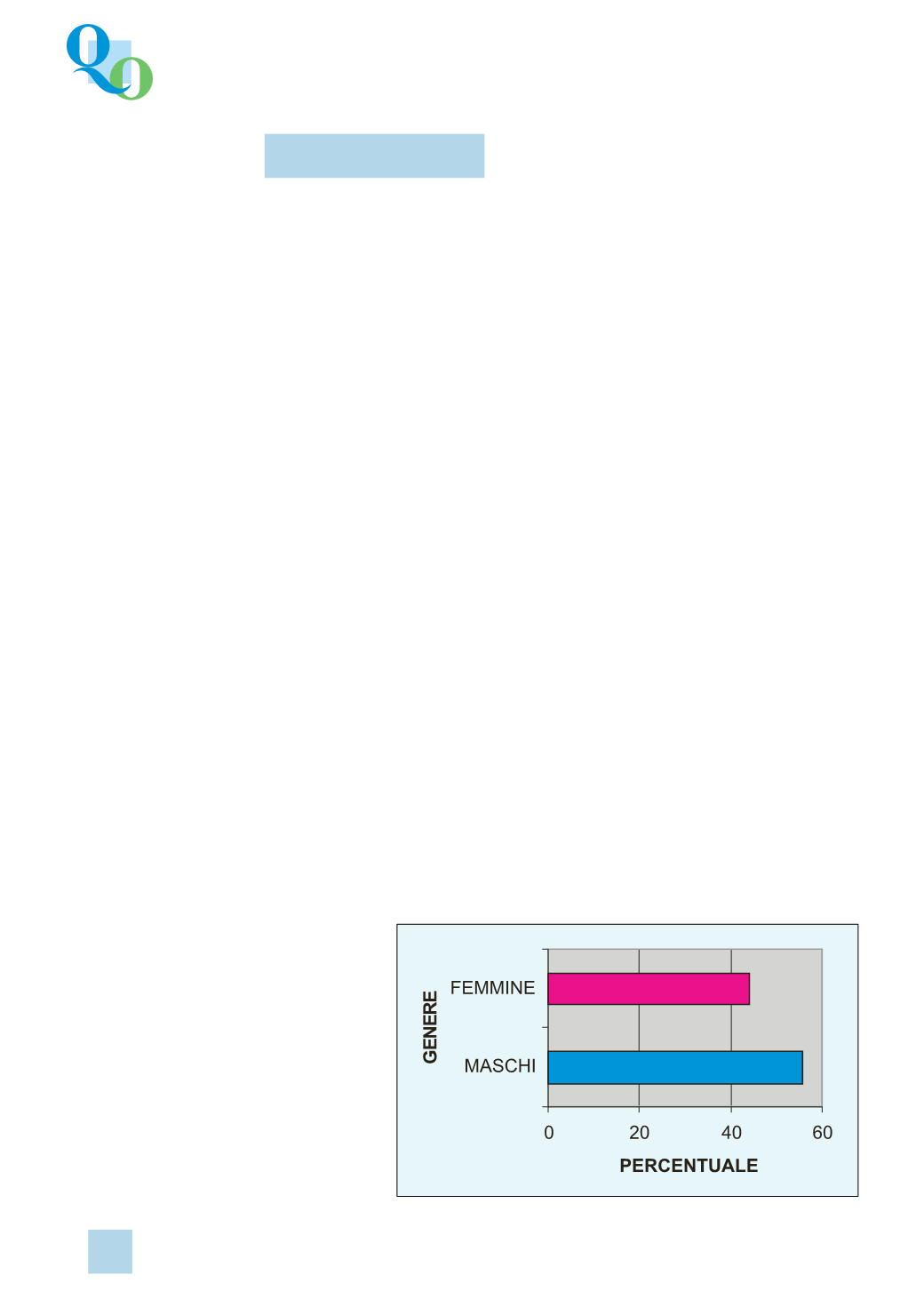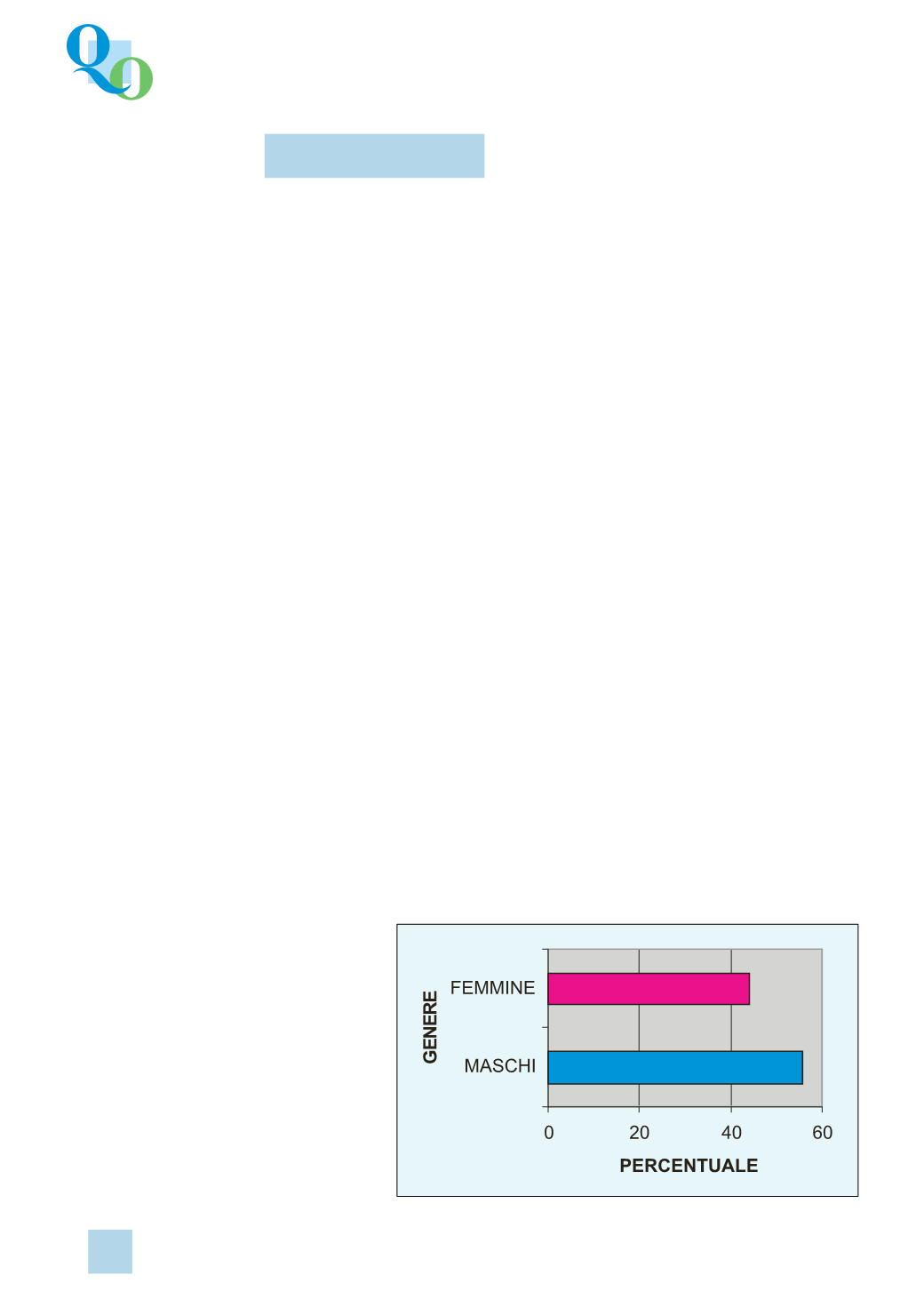
te il consueto orario di lezione; nella
maggior parte dei casi, il professore
rimaneva all’interno dell’aula.
Il questionario, nelle due versioni in
cui era stato predisposto, andava ad
indagare quattro principali ambiti,
quali:
aspetti socio-anagrafici
,
espe-
rienza formativa e lavorativa
,
risorse
applicate nella vita quotidiana
e
atteg-
giamenti verso il futuro
. Gli item che
compongono il questionario, in en-
trambe le versioni, possono essere
raggruppati in tre aree:
- Area competenze orientative di base
.
Sono competenze generali, trami-
te le quali ciascuno si crea una
cultura e un metodo orientativo.
La scuola e la famiglia sono le
principali agenzie formative di ti-
po spontaneo in cui tali compe-
tenze vengono sviluppate; queste
costituiscono un patrimonio im-
plicito e perciò sono di difficile
valutazione. Tali competenze,
inoltre, sono necessarie per lo svi-
luppo di competenze orientative
specifiche.
In quest’area si ritrovano le ri-
sorse che il soggetto impiega al
momento di superare una situa-
zione difficile e le strategie mes-
se in pratica; queste competenze
sono state indagate mediante
l’utilizzo delle scale ‘sostegno
sociale’, ‘coping attivo’, ‘diagno-
sticare’.
- Area competenze orientative di mo-
nitoraggio
. Sono competenze spe-
cifiche relative all’esperienza for-
mativa e lavorativa. Riguardano
la capacità di “tenere sotto con-
trollo” la situazione nel suo veri-
ficarsi con l’intento di prevenire
gli ostacoli e i fallimenti. Queste
competenze sono state analizzate
sia nella rilettura della storia per-
sonale e formativa, sia nel modo
in cui il soggetto si pone rispetto
al futuro, mettendo a fuoco le dif-
ficoltà e le speranze che egli
esprime. Si sono utilizzate scale
diverse per le due versioni del
questionario; versione F/F: scala
‘organizzazione pianificata’, ‘au-
tocritica costruttiva’ e ‘ricerca di
feedback’; versione F/L: scala ‘ri-
cerca attiva del lavoro’.
- Area competenze orientative di svi-
luppo
. Così come quelle di moni-
toraggio, le competenze di svi-
luppo sono competenze orientati-
ve specifiche, relative all’espe-
rienza personale e lavorativa; ri-
guardano la capacità del soggetto
di progettare l’evoluzione della
propria esperienza rimanendo
sempre fedeli ai propri valori, in-
teressi e motivazioni. Queste
competenze emergono sia dall’a-
nalisi della storia lavorativa indi-
viduale sia dal modo in cui il sog-
getto immagina il suo futuro.
Gli item di quest’area indagano
da un lato il peso che il soggetto
attribuisce al lavoro e dall’altro
gli atteggiamenti che egli esprime
verso il futuro. Queste competen-
ze sono state rilevate mediante
l’utilizzo di scale quali ‘aspetti
importanti del lavoro’, ‘rapporto
famiglia/lavoro/tempo libero’ e
‘centralità assoluta del lavoro’.
Inoltre, si è fatto ricorso ad altri ti-
pi di scale per indagare l’atteggia-
mento verso il futuro (scale ‘inde-
cisione e conflitto’, ‘rappresenta-
zione formazione’, ‘autoefficacia’
e ‘ansia della prestazione’).
Il campione della ricerca, eteroge-
neo per genere (maschi 55.8% e
femmine 44.2% -
cfr.gr.1
), conta 310
studenti dell’ultimo anno delle
scuole superiori, divisi, come rap-
presentato nel grafico che segue (
cfr.
gr.2
), in tre indirizzi di studio: licea-
le (44.5%), tecnico (11.3%) e profes-
sionale (44.2%).
Si è somministrato, sulla base di un
processo di autovalutazione opera-
to da ogni ragazzo, il medesimo
questionario in due versioni diffe-
renti in relazione al tipo di transi-
zione: versione F/F per coloro che
erano orientati a proseguire gli stu-
di; versione F/L per coloro che era-
no orientati a inserirsi nel mondo
del lavoro; questo allo scopo di ve-
dere se vi fosse una differenza di
approccio e di risultato, rispetto a
variabili quali ‘tipo di transizione’
TRANSIZIONE POST-DIPLOMA
48
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
27
Grafico 1
: Distribuzione del campione in base al genere