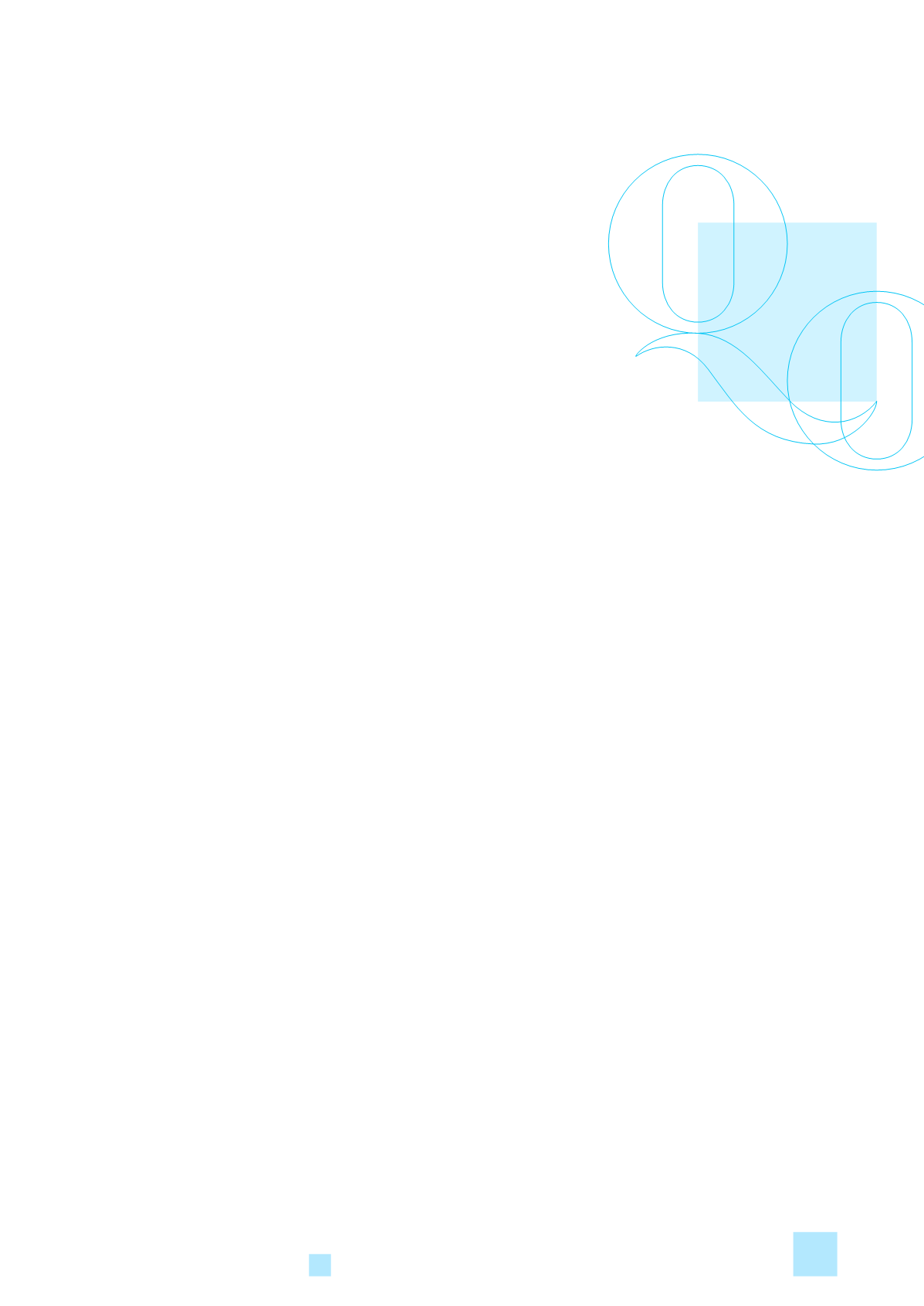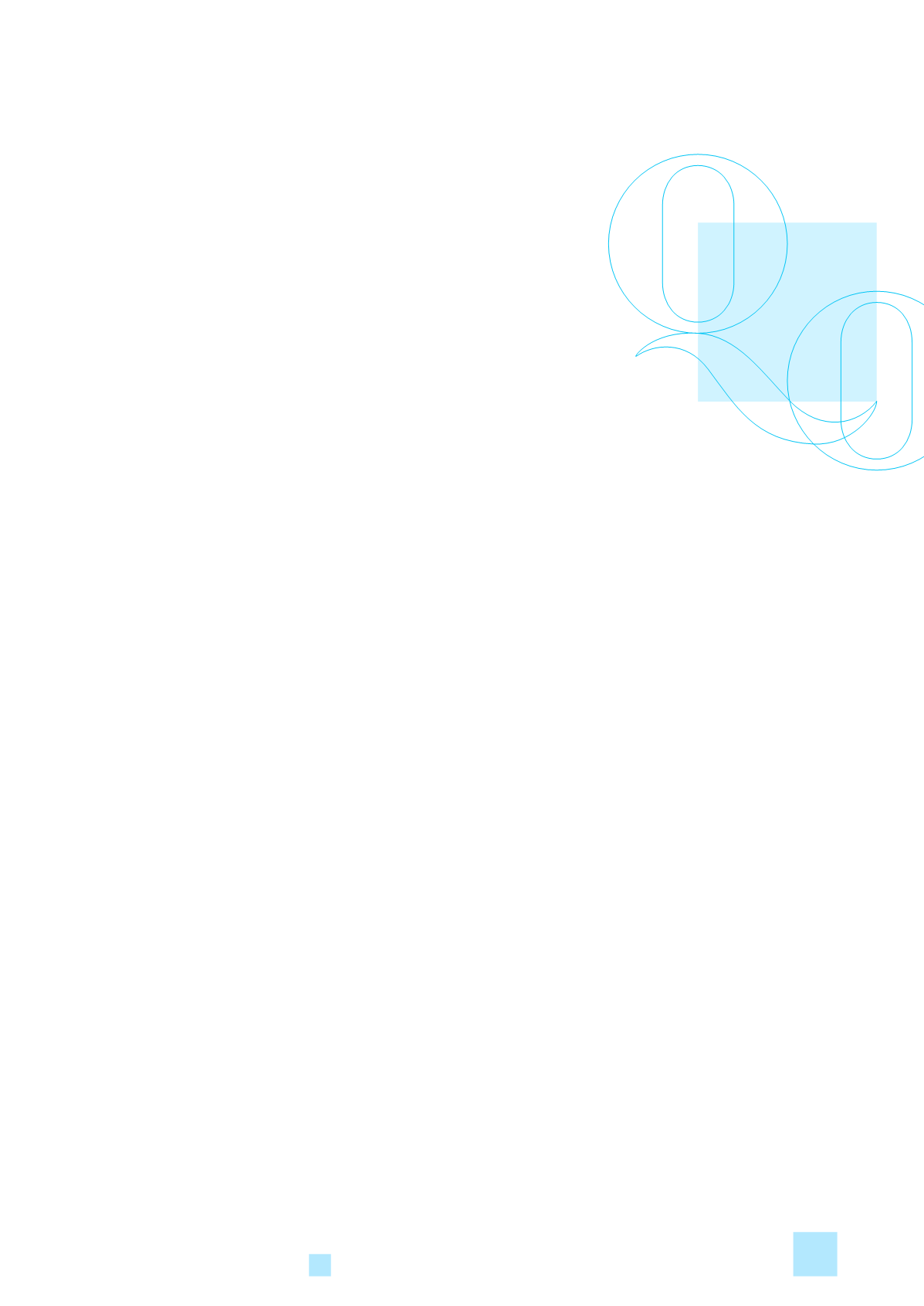
dattamento scolastico e la demotiva-
zione allo studio sono causati anche
dalle frustrazioni derivate dal non
padroneggiare o dall’essere del tutto
estranei a richieste poste dagli inse-
gnanti nelle modalità “altre”, diverse
dalla propria. Ecco allora la neces-
sità di proporre i contenuti discipli-
nari in modo diversificato, in lin-
guaggi diversi, in modo che ciascu-
no degli allievi possa trovare tra le
modalità offerte, quella più conge-
niale per il suo apprendimento. Altro
punto fondamentale, accanto a que-
sto, è che di solito gli insegnanti si
lamentano perché gli alunni manca-
no di metodo, non prestano atten-
zione, non si concentrano sul com-
pito, non.... Ma, al di là di questo,
non forniscono ai loro allievi le stra-
tegie cognitive da mettere in atto in
ciascun caso. Non è da questo che si
dovrebbe partire? Ed è spesso vero
che quegli stessi alunni che magari
non sono in grado di avere dei risul-
tati scolastici positivi (“blocco” emo-
tivo a scuola? incapacità di prestare
attenzione? di riflettere? di applica-
re”) sono poi perfettamente in grado
di compiere quegli stessi gesti men-
tali quando, fuori dalla scuola, devo-
no occuparsi dei loro hobby, o di
attività che li interessano particolar-
mente. Ma è ben difficile che qual-
cuno proponga loro di utilizzare
quelle stesse procedure di elabora-
zione del sapere, sviluppate da loro
autonomamente, come base per
ampliare il loro repertorio cognitivo
e metacognitivo.
La proposta di Antoine De La
Garanderie è solo in apparenza sem-
plice. In realtà la vita della classe
cambia profondamente, nei rapporti
tra insegnanti e alunni, tra i quali c’è
uno scambio maggiore e più ricco,
dal momento che coinvolge la presa
di coscienza delle proprie evocazio-
ni e dei propri processi di apprendi-
mento; nei rapporti tra alunni, nel
confronto tra i loro modi di studiare,
nella loro capacità di parlarne e dei
risultati dei loro sforzi; nelle moda-
lità di presentazione dei contenuti,
nell’organizzazione del tempo delle
lezioni... Ecco, il tempo: già soltanto
questo potrebbe essere fattore di
novità e di cambiamento, occasione
di insegnamento di abitudini che si
stanno perdendo: Canevaro nota che
i ragazzi (ma anche gli adulti) sono
sempre più in difficoltà a vivere la
durata, a “sopportare” le attese e
anche questo è un fattore di disagio.
Nella strada indicata da De La
Garanderie, la sospensione, l’attesa,
il “guardarsi dentro” sono continui. E
rappresentano forse un antidoto a
vivere istante per istante, ad essere
sempre alla ricerca di una soddisfa-
zione immediata dei propri bisogni.
LA FORMAZIONE PER GENITORI E
DOCENTI
Non potevamo trascurare l’altro
aspetto, ugualmente di ordine squisi-
tamente pedagogico, cioè l’ap-
profondimento sulle caratteristiche
che assumono i nostri ragazzi nel-
l’età più difficile, cioè l’adolescenza,
e la riflessione sulla funzione genito-
riale, cioè la funzione educativa che
un adulto si propone di svolgere nei
confronti di una persona in pieno
sviluppo di cui si sta occupando.
L’argomento interessa da vicino
genitori e insegnanti, entrambi impe-
gnati ad aiutare a crescere questi
ragazzi, entrambi spesso affaticati da
questa esperienza e desiderosi di
capire come agire per il meglio ma
spiazzati dalla profondità e dalla
velocità del cambiamento, dagli
scarti generazionali sempre più
ristretti.
E’ stato importante che voci rese
esperte dalla vicinanza alle realtà
più difficili, ai casi limite, si rivolges-
sero a chi ha la possibilità di agire in
tempo, di prevenire l’insorgere di
situazioni critiche, per spartire le
proprie cognizioni e le proprie com-
petenze.
La presentazione e la riflessione
sulle differenze tra modelli, tra con-
cezioni del mondo e del futuro, tra
modi di manifestare affettività e sen-
timenti da parte degli adulti e dei
ragazzi hanno colpito molto perché
hanno dato parole a intuizioni e per-
cezioni già provate. La soggettività
esasperata da parte dei ragazzi, l’as-
senza di un progetto (“non vanno
oltre all’estate”), la difficoltà di forni-
re parole ai sentimenti, l’utilizzo di
codici di comunicazione poveri, la
centralità del proprio benessere sono
tutti elementi presentati come distin-
tivi del mondo giovanile, che appar-
tengono poco a quelli delle genera-
zioni precedenti, cresciuti secondo
altri principi. Ma la funzione che gli
adulti devono comunque esercitare,
in quanto a loro ne è demandata la
responsabilità, richiede di venire
incontro a questi ragazzi, di ricono-
scerli nella loro identità, di affronta-
re il conflitto inevitabile in modo
costruttivo per entrambi perché, se
adeguatamente accettato, può avvi-
cinare e rafforzare i legami invece
che allontanare e distruggere.
L’importanza allora del sapersi met-
tere in condizione di comunicare, di
instaurare relazioni positive, appare
centrale una volta di più. La relazio-
ne di tipo empatico e l’ascolto sono
risposte al bisogno di significato: le
modalità attuali saranno magari
diverse, ma i bisogni fondamentali
restano uguli a quelli di tutti gli esse-
ri umani di tutti i tempi.
Le considerazioni sul significato del-
l’ascoltare (come messaggio di rela-
zione, come dono, come sospensio-
ne del giudizio) portano a riflettere
sugli obiettivi che attraverso ad esso
si possono ottenere, per esempio su
quanto per un essere umano possa
voler dire che il suo punto di vista
può essere accettato, che qualcuno
gli è accanto nella sua sofferenza (la
fatica della crescita, la difficoltà di
accettarsi...), che per qualcuno lui
“vale”. Per ottenere ciò è necessario
rispettare anche alcune condizioni
più favorevoli per rendere efficace la
comunicazione, per stabilire e man-
tenere una relazione - la scelta del
contesto, dello spazio e del tempo,
del tipo di linguaggio, verbale e non
verbale, più adatto, le competenze
di riformulazione del messaggio.
IL MONITORAGGIO
Quale percezione potevano aver
avuto le famiglie della ricaduta nella
normale azione didattica della rifles-
sione collettiva dei docenti e delle
azioni di formazione intraprese? Per
capirlo e per portare ulteriori corret-
tivi nel caso in cui ci si trovasse di
fronte ad incomprensioni, è stata
avviata un’altra iniziativa di monito-
raggio che si svolge per le classi di
passaggio (dalla scuola dell’infanzia
alla scuola primaria e dalla scuola
primaria alla scuola secondaria di
primo grado) con la proposta di que-
stionari in tre momenti dell’anno
scolastico: il primo per sondare le
aspettative dei genitori che assieme
ai loro figli devono affrontare il pas-
saggio nell’anno successivo, il secon-
do ad anno scolastico avviato per
esaminare le reazioni al primo
impatto e perché la scuola possa
apportare i correttivi necessari, il
terzo alla fine dell’anno scolastico.
Una commissione mista di genitori e
25
41
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO