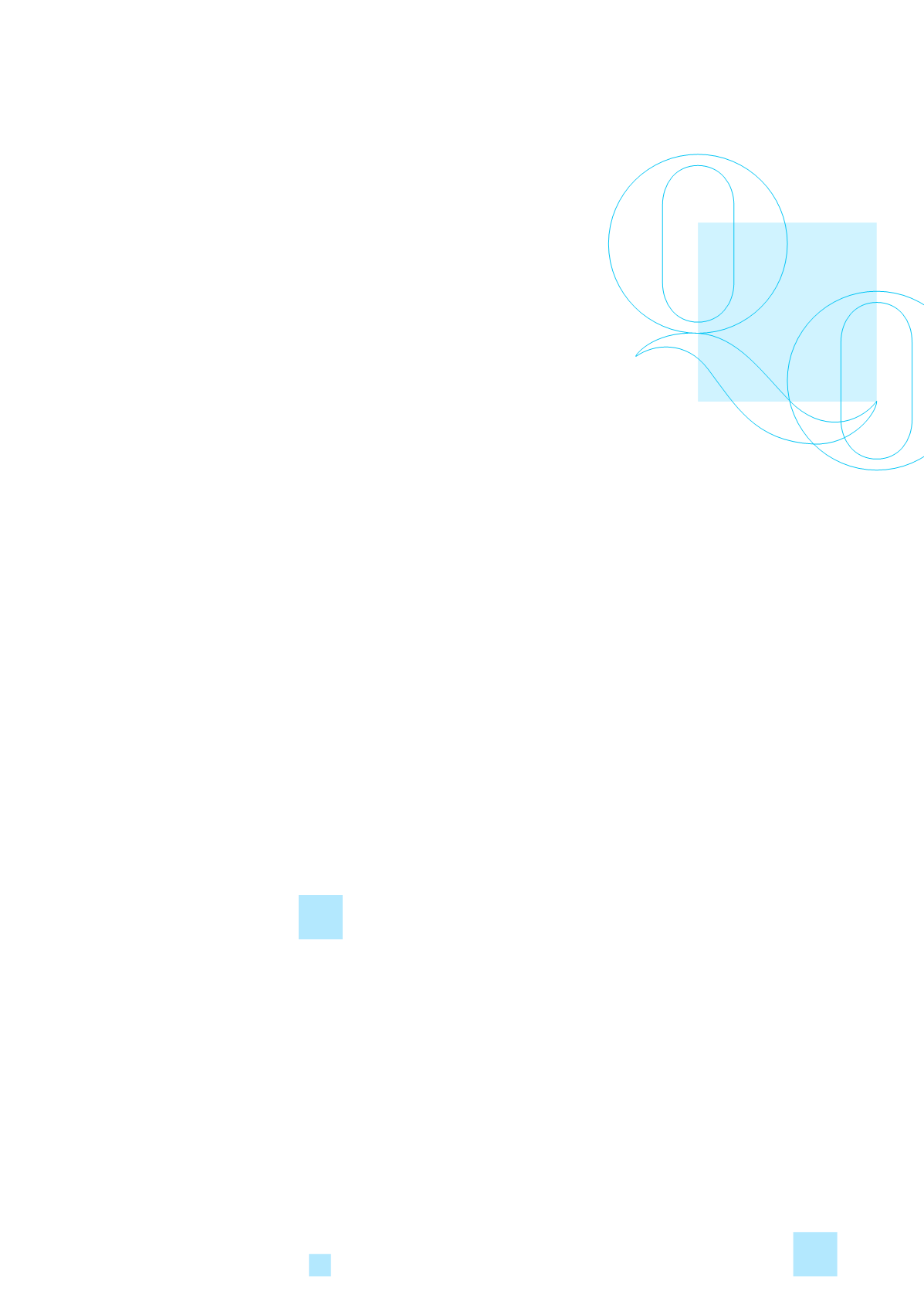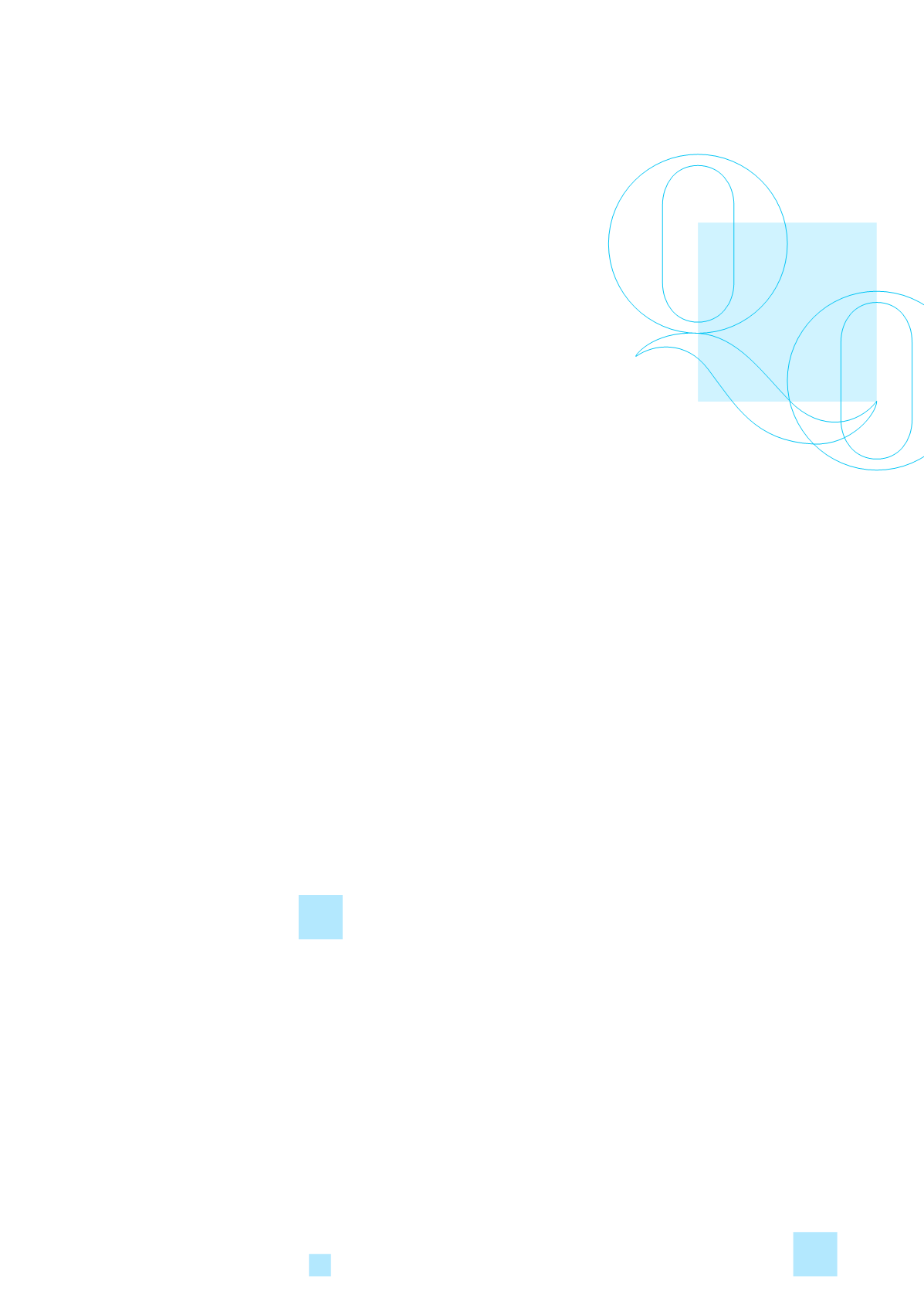
quello relazionale, di negoziazione
dei saperi; se non posso più dare
ordini e devo mettere a punto altre
modalità che possiamo riassumere
così “la scuola riuscirà ad essere
agente di cambiamento con i
ragazzi, che vuol dire motivarli,
riconquistarli, se saprà fare, ed è
quello che ho intravisto nei vostri
progetti nel corso della giornata,
anche se non li chiamavate così,
autocambiamenti. “
Nel sentire alcuni di voi che parla-
vano di problema dentro il ragaz-
zo, mancanza di autocontrollo, di
autostima, demotivazione, addirit-
tura nevrosi, tutte contenute nel
contenitore ragazzo.
Fortunatamente, davanti a queste
letture del problema che vedevano
il ragazzo come se ne fosse la sca-
tola contenitrice si rispondeva
proponendo autocambiamenti. I
laboratori sono autocambiamenti
della scuola, vogliono dire “ti con-
sento di parlare, di fare delle cose,
cose proibite anni fa”; l’apprendi-
mento cooperativo è un’apertura
al ragazzo, è un ascolto diverso
del ragazzo; attenzione che se non
si coglie l’aspetto innovativo e si
trasforma questa cosa in tecnica
non funziona più.
Allora forse ci renderebbe più coe-
renti ricordare che il ragazzo non
è il contenitore dei problemi, che
per esempio lo psicologo della
scuola non ha il diritto di essere il
curatore, lo psicoterapeuta dei
ragazzi, è lì per dare una mano
alla scuola. I ragazzi sono sani,
hanno buone ragioni per mostrare
il disagio, per mostrarsi scontenti,
distaccati, abulici, sofferenti e,
aggiungo un pezzo provocatorio “
se smettiamo di comandare cam-
biamenti e facciamo cambiamenti,
il ragazzo cambierà”.
Gran parte di queste scuole ha
fatto un lavoro su progetti già
avviati, il che vuol dire che si può
non buttare via tutto e fare il
nuovo, si può fare tutto ancora
con le vecchie cose purché si
aggiunga anche quest’altra luce,
cioè il riconoscimento che l’altro
è fatto di noi, che occorre anche
fare autocambiamenti.
L’autonomia scolastica è un altro
nome di quel passaggio al quale
abbiamo accennato, cioè il pas-
saggio dal fatto che la scuola era
scatola rigida e chiusa a cui occor-
reva che tu studente ti adattassi, a
una cosa molto più elastica e
capace di cogliere differenze indi-
viduali. Questa è l’autonomia.
L’altro chiede che le sue caratteri-
stiche prima respinte, indicate
come difetto, gli vengano ricono-
sciute come diritto: ho diritto alla
mia diversa intelligenza, stile
diverso di pensiero, apprendimen-
to. Se c’è un’ipotesi di futuro del-
l’insegnamento quella che pare
più calzante oggi è che ci stiamo
avvicinando a diventare insegnan-
ti negoziatori, anziché passatori
del sapere.
Il succo del negoziare è questo
“affinché ti venga facile fare que-
sta cosa, cosa vuoi che cambi in
me insegnante, in me scuola, in
me strumento, in me cultura che
sta intorno a te”; non venire a patti
banalmente ma chiedere all’altro
che tipo di cambiamento occorre
che io faccia perché lui stia meglio
e se posso farlo, lo farò. Chiedere
questo vuol dire già che ritengo
l’altro capace di volere, pensare,
intuire; ritengo il ragazzo apparen-
temente incapace, intelligente,
creativo, sensibile anche lui.
Non è loro il problema, il ragazzo
apatico o che non sa controllarsi è
questione nostra, è comunicando-
lo a noi che non sa controllarsi,
che trova utile il non saper con-
trollarsi, questo va capito per non
stare a quel gioco, per aiutarlo a
cambiare accettandolo, comuni-
candogli che va bene così come
ora è, perché solo così, penso,
cambierà.
COSTRUIRE IL SUCCESSO
FORMATIVO
NELLA SCUOLA DELL’AUTO-
NOMIA
Bruno Forte
Consulente Assessorato regionale
Desidero assumere il ruolo di
“amico critico
” nei confronti delle
validissime proposte presentate nel
corso dei lavori. L’amicalità costitu-
isce una dimensione essenziale che
deve intonare tutti coloro che si
occupano di educazione; si esprime
nella complicità e nel coinvolgimen-
to attivo, segnati dall’apprezzamento
e dalla stima per poter cogliere i fer-
menti positivi. In altri termini oc-
corre sempre guardare al “bicchiere
mezzo pieno” per sviluppare un
pensare positivo che si diffonde dagli
operatori ai ragazzi.
La criticità è altra valenza essenziale
perché interpreta i fermenti, gli snodi
e le problematicità degli interventi
messi in atto, al fine di promuovere
una generatività nel segno dello
sviluppo e della crescita dell’inno-
vazione.
I punti di debolezza, anche gli errori,
vanno interpretati in chiave positiva
e contestualizzati all’interno di una
promettente “pedagogia dell’errore”.
Il tutto in una visione di ricerca inno-
vativa che assume i tratti della speri-
mentalità, ossia della verificabilità e
della continua “messa alla prova”
dei fatti con i fatti e con le idee, in
una dinamica di “ricercazione”, di
falsificabilità e di circolarità pratica-
teoria-pratica.
Occorre liberarci dall
’ossessione
,
che diventa una sorta di sindrome,
dell’oggettività
, che si traduce in un
vero e proprio “abuso verificatorio e
valutativo”. La valutazione si iscrive
all’interno di una dinamica di
processo che vuole da un lato cosci-
entizzare i soggetti circa la qualità
delle azioni didattico-formative, dal-
l’altro, rendere “pubblico” il lavoro
educativo attivando un’interazione
partecipe, sempre nella logica della
riprogettazione. Piuttosto che cur-
varsi ad anguste visioni giudicative,
le azioni valutative puntano a “dar
valore” alle attività in vista di una
rilettura critica.
E’ opportuno rivisitare un impor-
tante contributo di Gunnar Myrdal
“L’obiettività delle scienze sociali”
edito da Einaudi 1973: “L’unico
modo in cui possiamo sforzarci di
raggiungere una certa ‘oggettività’ è,
a livello di analisi teoretica, quello di
portare innanzitutto le valutazioni in
piena luce, di renderle consce,
esplicite e precise e di lasciare che
siano esse a guidare l’impostazione
della ricerca”.
Con questi “occhiali culturali” mi
sono rapportato con le proposte pre-
sentate.
Va sottolineata, anzitutto,
la positi-
vità di azioni “a prova di scuola”,
nate cioè all’interno di interazioni
progettuali iscritte nei precisi conte-
sti formativi che intendono eviden-
ziare la praticabilità di certi percorsi,
le possibilità di estrapolarne criteri
generalizzabili e la costruzione nel
contesto di “
saperi di scuola
”.
Vi ho colto, nel contempo, un limite
che va problematizzato: gli itinerari
25
49
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO