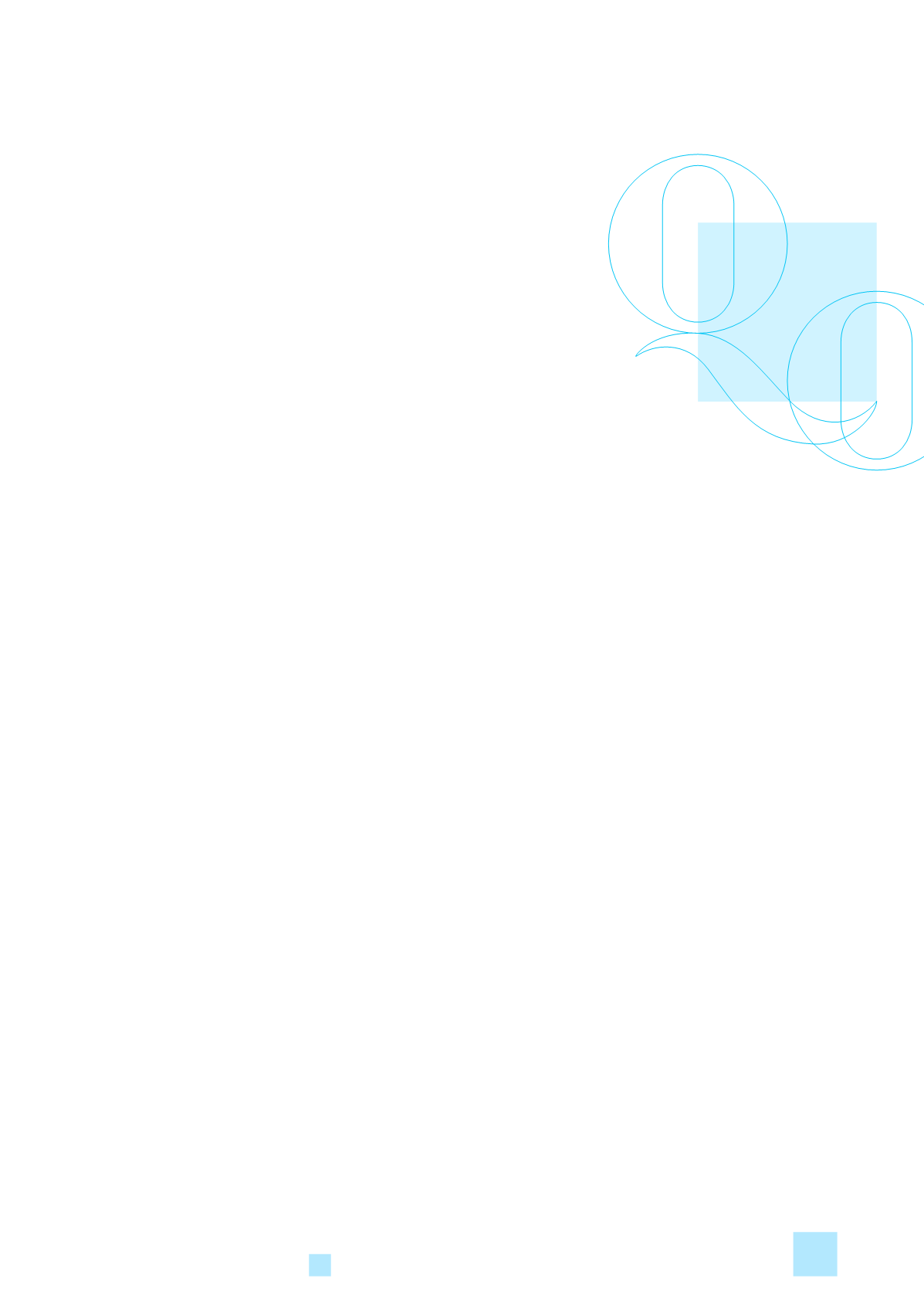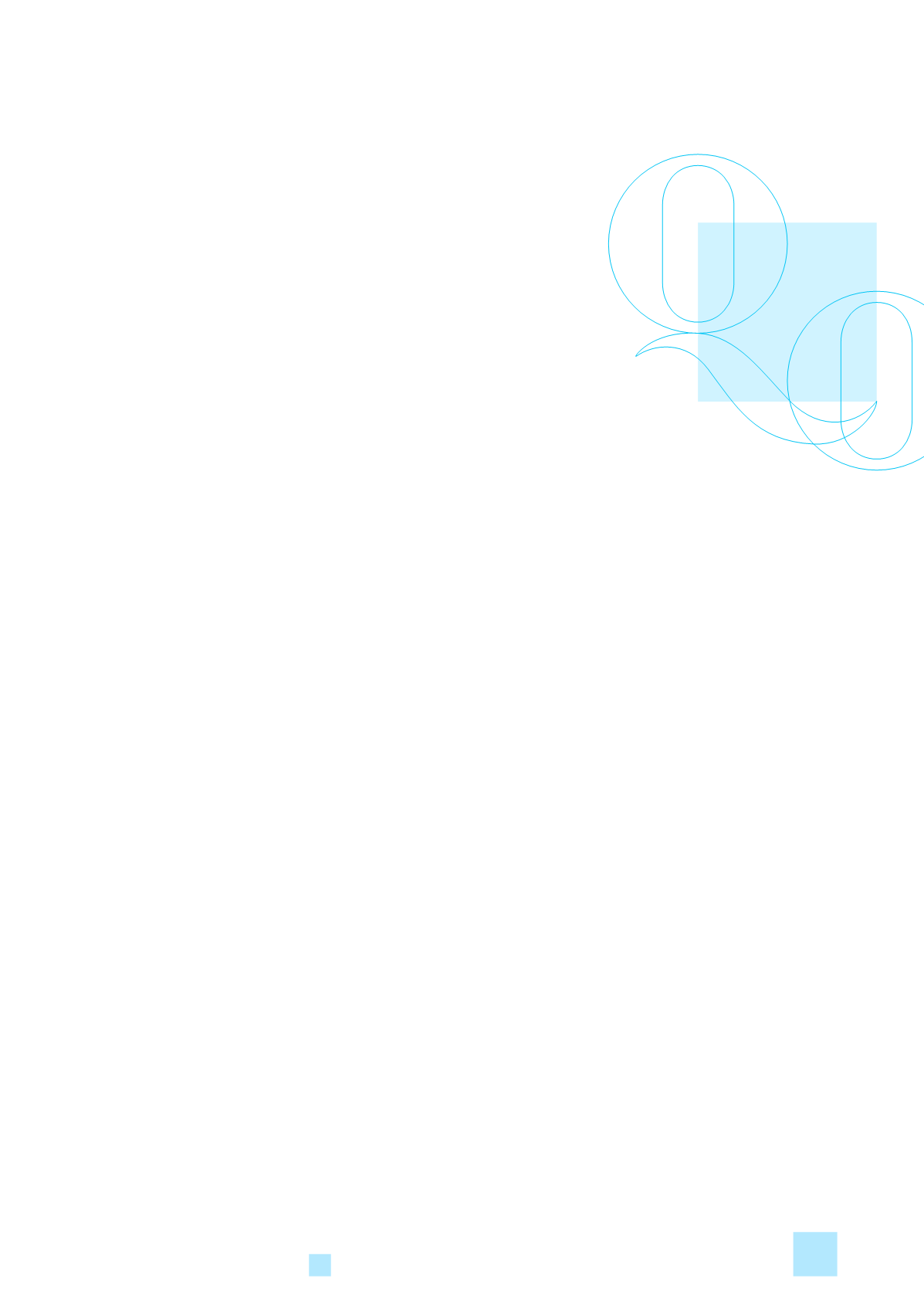
quanto conosce già e nel proiettare
il tutto in un quadro nuovo: a riela-
borare, a riorganizzare e a progetta-
re, insomma. E si sa bene ormai che
un individuo, posto in una situazio-
ne di insuccesso ripetuto, arriva ad
evitare le situazioni di apprendimen-
to che causano tale insuccesso, che
questo comporta la messa in atto di
comportamenti “incompatibili” con
la normale vita scolastica, devianti e
dissonanti rispetto al gruppo classe.
L’errore consiste nel considerare il
gruppo classe come gruppo omoge-
neo: è composto da individui ciascu-
no con caratteristiche e reazioni pro-
prie, che non reagiscono allo stesso
modo ai vari aspetti dell’apprendi-
mento scolastico.
Un’ultima osservazione: non è più
vero (o forse non lo è mai stato) che
gli allievi apprendono con la sempli-
ce trasmissione delle conoscenze.
Gli insegnanti devono quindi rimet-
tersi in discussione, devono sapere
come gli alunni “funzionano”, devo-
no mettere il loro sapere al servizio
dei giovani e, anche di fronte a rea-
zioni o a comportamenti poco
“appropriati”, devono mantenere la
lucidità mentale e pedagogica e pro-
porre loro modalità adatte, aiutarli a
responsabilizzarsi, dare loro i mezzi
per comprendere l’obiettivo.
LE AZIONI DEL PROGETTO “STAR
BENE STUDIANDO BENE”
Nel confronto e nella discussione
intervenuta tra i rappresentanti delle
tre scuole della provincia di Trieste
(due Istituti Comprensivi, il
“Giovanni Lucio” e l’”Italo Svevo” e
l’Istituto Tecnico-Professionale “da
Vinci-de Sandrinelli”) su come
impostare il progetto dello “Stare
bene studiando bene”, è emersa
allora anche l’insoddisfazione degli
adulti sul modo complessivo di vive-
re a scuola: dal momento che cam-
biano le funzioni dell’insegnamento
e i ruoli, è stato necessario priorita-
riamente rivedere il modo con cui ci
si pone nei confronti dei ragazzi.
Bisognava formare dei gruppi di
lavoro all’interno delle scuole su
compiti molto “pratici”, in modo da
far fronte alle situazioni reali che si
incontrano in classe, in riferimento
sia alle relazioni sia all’insegnamen-
to. Si è imposta perciò la ricerca di
una strada che tenesse conto del
benessere di entrambe le compo-
nenti, ed anche del punto di vista e
dei bisogni del terzo lato del triango-
lo, i genitori, anch’essi spesso spae-
sati e dubbiosi su come agire con
adolescenti che vivono la loro età
sovente in modo così diverso da
loro. Possibili risposte per la forma-
zione degli insegnanti sono state
tratte dalla riflessione di un altro
gruppo di insegnanti che continua
ad interrogarsi e a confrontarsi sul
proprio lavoro, sulla base delle indi-
cazioni ricevute dall’analisi della
sua esperienza con i ragazzi in clas-
se. Il gruppo, che si richiama alla
Pedagogia Istituzionale per l’Ap-
prendimento, è un gruppo aperto di
ricerca/azione educativa che fa della
eterogeneità e della confrontabilità
delle esperienze la sua risorsa e la
sua ricchezza. La riflessione sulle
problematiche adolescenziali, com-
piuta assieme alle operatrici della
Comunità di San Martino al Campo,
ha avuto lo scopo di offrire alle fami-
glie momenti costruttivi di dialogo
per affrontare e approfondire diversi
aspetti legati alla relazione con i
figli, dare strumenti per affrontare le
tematiche relative alla crescita dei
figli nell’ottica della prevenzione e,
non ultimo, per costruire percorsi
significativi comuni tra genitori e
insegnanti nella conoscenza del
mondo giovanile.
Si è ritenuto poi indispensabile, nelle
tre realtà scolastiche, mantenere e
potenziare (dove già esistevano) ed
aprire (dove mancava) un punto di
ascolto per studenti, genitori ed
anche docenti per rispondere a quel
bisogno di relazione e di confronto
di cui si diceva pocanzi.
Infine, un’azione di monitoraggio
compiuta con e per i genitori su
come verificare inizialmente quali
informazioni abbiano ricevuto sulla
scuola e da quali fonti, utili a com-
prendere le aspettative e le valuta-
zioni delle famiglie al fine di arriva-
re ad un percorso di miglioramento.
IL PUNTO DI ASCOLTO
L’aula d’ascolto è lo spazio della
cura. È uno spazio di relazioni
“autentiche” tra soggetti umani.
Diventa un luogo significativo per un
soggetto in quanto questi viene
attratto sulla base della relazione
educativa che in quel luogo si dà.
L’essere insieme è contraddistinto
dall’intenzione da parte dell’adulto
di aver cura del più giovane.
L’ascolto presuppone che si presti
attenzione all’altro, per definizione:
chi ascolta deve aspettare i tempi e i
modi con cui l’altro intende mettersi
in comunicazione.
La relazione si basa sulla comunica-
zione e la comunicazione a sua
volta si basa più sull’ascoltare che
sul parlare. Chi parla può quindi non
essere certo che il suo messaggio sia
capito e sia interpretato secondo le
sue intenzioni, può in realtà non
essere ascoltato. Ma chi ascolta pre-
sta per definizione attenzione all’al-
tro ed è capace di aspettare i tempi e
i modi con cui l’altro intende metter-
si in comunicazione. Ciò presuppo-
ne la capacità di ascoltare prima di
tutto se stesso. Chi ascolta sa aspet-
tare e rispettare i silenzi, limita l’uti-
lizzo di parole impoverite, che
hanno perso il loro senso originario,
parole divenute opache, è capace di
comprendere autenticamente le
parole dell’altro e il loro senso, di
mettere tra parentesi ciò che è scon-
tato ed ovvio.
Il dare e il ricevere tra queste due
parti in causa sono relativi. Forse è la
persona che si pone in condizione di
dare quella che riceve di più.
Secondo gli insegnanti che lo hanno
praticato, infatti, il centro di ascolto
è stata un’esperienza fortissima.
Preoccupati all’inizio poiché teme-
vano di non essere all’altezza, di
non saper dare risposte adeguate a
situazioni complesse, si sono accorti
che quello che i ragazzi apprezzava-
no soprattutto era la possibilità di
parlare con un adulto che dimostra-
va attenzione e disponibilità.
Le tre scuole hanno dato, comun-
que, risposte diverse allo stesso biso-
gno, ciascuna ovviamente secondo
le caratteristiche dell’utenza e della
“storia” dell’istituto. Le differenze
riguardavano la possibilità di apertu-
ra settimanale, dipendente dal bud-
get a disposizione, le persone incari-
cate della gestione dell’aula, a
seconda della disponibilità interna,
l’età dei fruitori. Per quanto riguarda
il secondo punto, bisogna dire che in
tutte le situazioni si è usufruito
anche della collaborazione di una
psicologa, in modo che fosse garan-
tita la possibilità di intervenire in
modo corretto e “professionale” di
fronte a problematiche più severe.
Ma anche gli insegnanti privi di
esperienze specifiche nel settore
sono stati “formati” in un certo
numero di incontri in cui venivano
loro richiamate le modalità migliori
25
39
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO