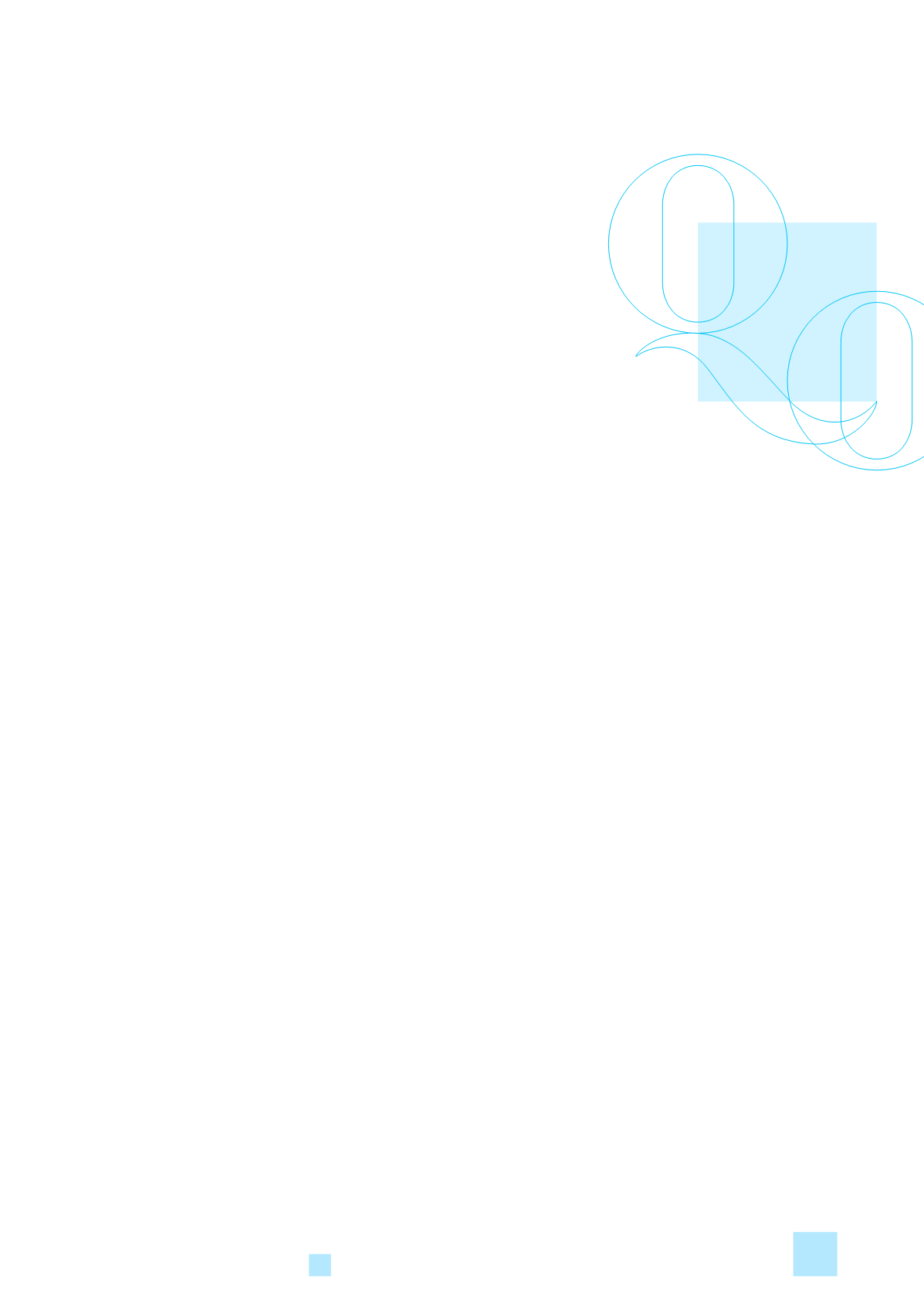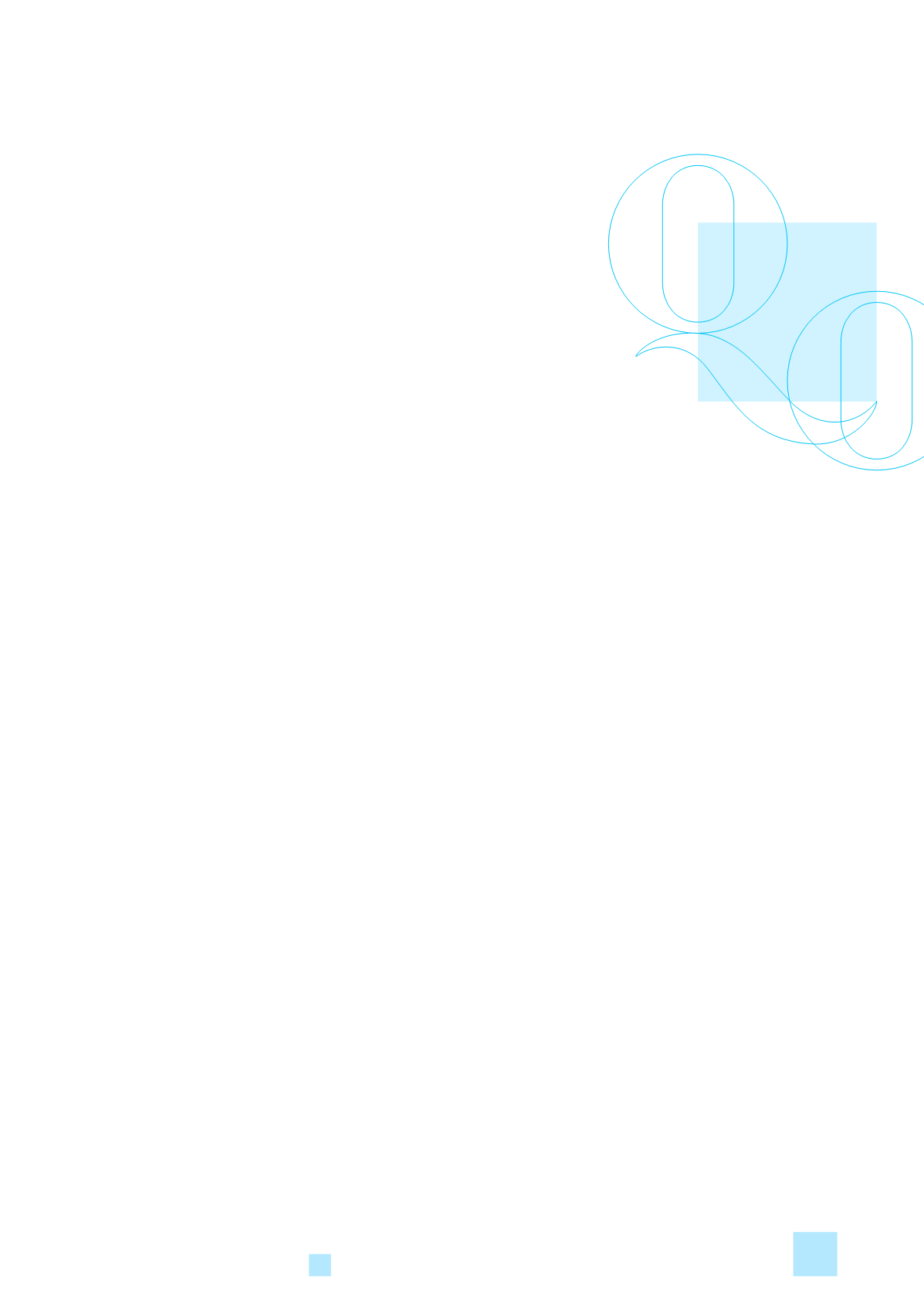
Risultano illuminanti e stimolanti, a
tal proposito, le riflessioni di Thomas
Sergiovanni: ”Le comunità sono orga-
nizzate attorno a relazioni e a inter-
dipendenze sentite che le nutrono.
Esse creano strutture sociali che unis-
cono le persone e le vincolano a val-
ori e a idee condivisi. Sono definite
dai centri di valore, dai loro senti-
menti e dalle loro credenze che for-
niscono le condizioni necessarie per
promuovere un senso di ‘NOI’ a par-
tire da un ‘IO’.” (Dirigere la scuola
come comunità che apprende, LAS
Roma 2002).
La riflessione intorno alla scuola come
comunità rende necessario un itine-
rario di ricerca riguardo alla
dimen-
sione organizzativa
che l’autonomia
ricontestualizza in maniera promet-
tente. Ho la sensazione che i processi
organizzativi vengano interpretati
come dati statici, sganciati da una cor-
relazione con la didattica, secondo
una lettura “segmentata” dell’articolo
21 della legge 59/97 che correla
opportunamente atunomia organizza-
tiva e didattica.
La nozione di “sistema informale”
implica la presa in carico degli aspetti
nascosti addirittura repressi della vita
organizzativa: atteggiamenti, senti-
menti, valori, interazioni informali,
norme di gruppo. Si tratta di analizzare
le strategie dell’adesione che supera la
via coercitiva, come pure quella mec-
canicamente remunerativa o normati-
va. Lo snodo è costituito dalle dina-
miche dell’
empowerment
ossia del
superamento di condizioni di dipen-
denza per orientarsi verso una
diffu-
sione del potere
che punta a “rendere
potenti” tutti i soggetti protagonisti del
quadro organizzativo.
La centratura sul dirigente scolastico
del dibattito sull’autonomia può aver
ingenerato alcune visioni riduttive e
limitato la ricerca nella linea di una
“dirigenza diffusa” proprio nella
prospettiva di una corresponsabilità e
cooperatività nell’autogestione peda-
gogica, altro nome dell’autonomia di
una scuola che si organizza, come
“organismo vivente” nell’ambito di
vincoli istituzionali, gli obiettivi da
perseguire, e di concrete situazioni,
ossia la struttura disponibile.
Lo
sviluppo organizzativo
è processo
che appartiene alla scuola che fun-
ziona come “unità sociale” mediante
la mobilitazione delle “
energie co-
struttive
” proprie e di contesto
:
●
le persone sviluppano la condivi-
sione degli scopi dell’organizzazione
e sentono di poter dare contributi sig-
nificativi al loro raggiungimento;
●
le persone hanno aspettative realis-
tiche nella percezione che l’organiz-
zazione è un “crescere verso”;
●
le persone desiderano dare un con-
tributo al raggiungimento degli scopi
dell’organizzazione in un ambiente
favorevole e stimolante.
Optiamo, evidentemente per un orien-
tamento umanistico e vitalistico del-
l’organizzazione che vuole evitare il
rischio del burocratismo, del formali-
smo e del dirigismo che fanno dell’
”inadeguatezza appresa” il proprio
cavallo di battaglia. L’
inadeguatezza
appresa
è il risultato, più o meno con-
sapevolmente perseguito, di una serie
sistematica e ripetuta di segnali e mes-
saggi svalutanti le persone che deter-
minano una percezione che si mani-
festa in comportamenti di estraneità, di
apatia e di rinuncia. Nelle persone,
docenti , dirigenti, studenti, genitori, si
viene a consolidare una sorta di “auto-
censura preventiva” che spegne le
originarie intenzione di disponibilità al
coinvolgimento e di proposività all’in-
novazione L’esito atteso, solitamente
perseguito non in maniera dichiarata,
ma per via implicita e per questo mag-
giormente espropriante, si è così con-
fermato e la passività, il gregariato, la
perdita di qualsivoglia potere sono
state ampiamente raggiunte. La “de-
pressione” che si sta annidando nelle
scuole risulta particolarmente ri-
schiosa in concomitanza con lo
sviluppo dell’autonomia e con la real-
izzazione della riforma. Il combinato
disposto tra una “distrazione” presente
nei contesti di diverse scuole che sono
cadute nella trappola della colti-
vazione di immagini spesso vuote a
fini pubblicitari e una concezione
meccanico-applicativa della riforma
che non ha visto i soggetti in campo
effettivamente protagonisti, comporta
il radicarsi di un malessere strisciante.
Su quali basi riprendere un’elabo-
razione che sia in grado di invertire la
direzione di deriva?
Anzitutto prendere coscienza del
problema socializzandolo, liberando-
lo cioè dalla prigione individualistico-
privatistica; assumere una
visione di
segno costruzionistico
, recuperando
un positivo orgoglio, nella consape-
volezza che i Lillipuziani possono
avere la meglio sul gigante Gulliver,
sicuramente innesca un processo di
segno diverso.
Situare gli interventi
può diventare un
criterio strategico di sviluppo contestu-
alizzato utilizzando modalità autova-
lutative in grado di rivisitare la “memo-
ria pedagogica ed organizzativa” rela-
tiva a diverse dimensioni; si tratta di
leggere in profondità le microstorie
delle unità scolastiche riguardo alla
partecipazione e alla gestione sociale,
alle tematiche delle diversità, al patri-
monio metodologico-didattico, al-
l’impianto curricolare, alla costruzione
del Piano dell’offerta formativa, all’in-
dividuazione di strategie per la for-
mazione in servizio dei docenti, ecc.
L’opzione si indirizza verso compo-
nenti operative:
●
componente diagnostica, che for-
nisce una continua raccolta di dati
focalizzati sul sistema totale, ma, in
maniera puntuale sul sottosistema e
sui relativi processi;
●
componente di azione, che consid-
era in tutte le attività che vengono
progettate per migliorare il funziona-
mento dell’organizzazione;
●
componente di mantenimento, relati-
va alle attività orientate alla “manuten-
zione” (tenere in mano) e gestire il
processo di sviluppo organizzativo.
Le tre componenti possono essere se-
parate soltanto artificialmente perché,
in realtà, risultano compresenti in ogni
strategia di intervento.
E’ necessario che nei diversi contesti
scolastici si individuino e si rafforzino
quelle che Rogers definisce “
persona-
criterio
” che è tale nella misura in cui
viene percepita come persona au-
torevole, in grado di diventare punto di
riferimento, leva e “norma”, nell’espe-
rienza di crescita degli individui e dei
gruppi. Essa svolge una funzione
importante dentro le situazioni di rap-
porto che si vivono nei contesti forma-
tivi; se è persona capace di “facilitare”
la comunicazione e lo scambio
cooperativo, di promuovere auten-
tiche relazioni umane, di aiutare i
soggetti a “dirigersi da soli” per risol-
vere i problemi e per realizzare al
meglio le proprie capacità, la sua fun-
zione è determinante per la qualità
della situazione, per il suo cambia-
mento e per il suo sviluppo.
La “persona-criterio” è, secondo
Rogers, quella capace di una fonda-
mentale fiducia negli esseri umani,
nonostante tutto, nel senso della con-
vinzione profonda che ogni individuo
ha in sé enormi possibilità di com-
prendersi e di comprendere per
imparare ad affrontare e a risolvere
problemi, a livello personale e sociale.
“Persona-criterio” può essere un inse-
gnante, il dirigente scolastico, uno stu-
dente, un testimone privilegiato della
comunità, oppure questa funzione
può essere svolta da un gruppo,
motore e catalizzatore.
“Una concentrazione di
persone che
‘sentono il loro potere’,
potremmo
dire che hanno sviluppato la coscien-
za della propria autonomia, può
muoversi creativamente in aree nuove
25
51
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO