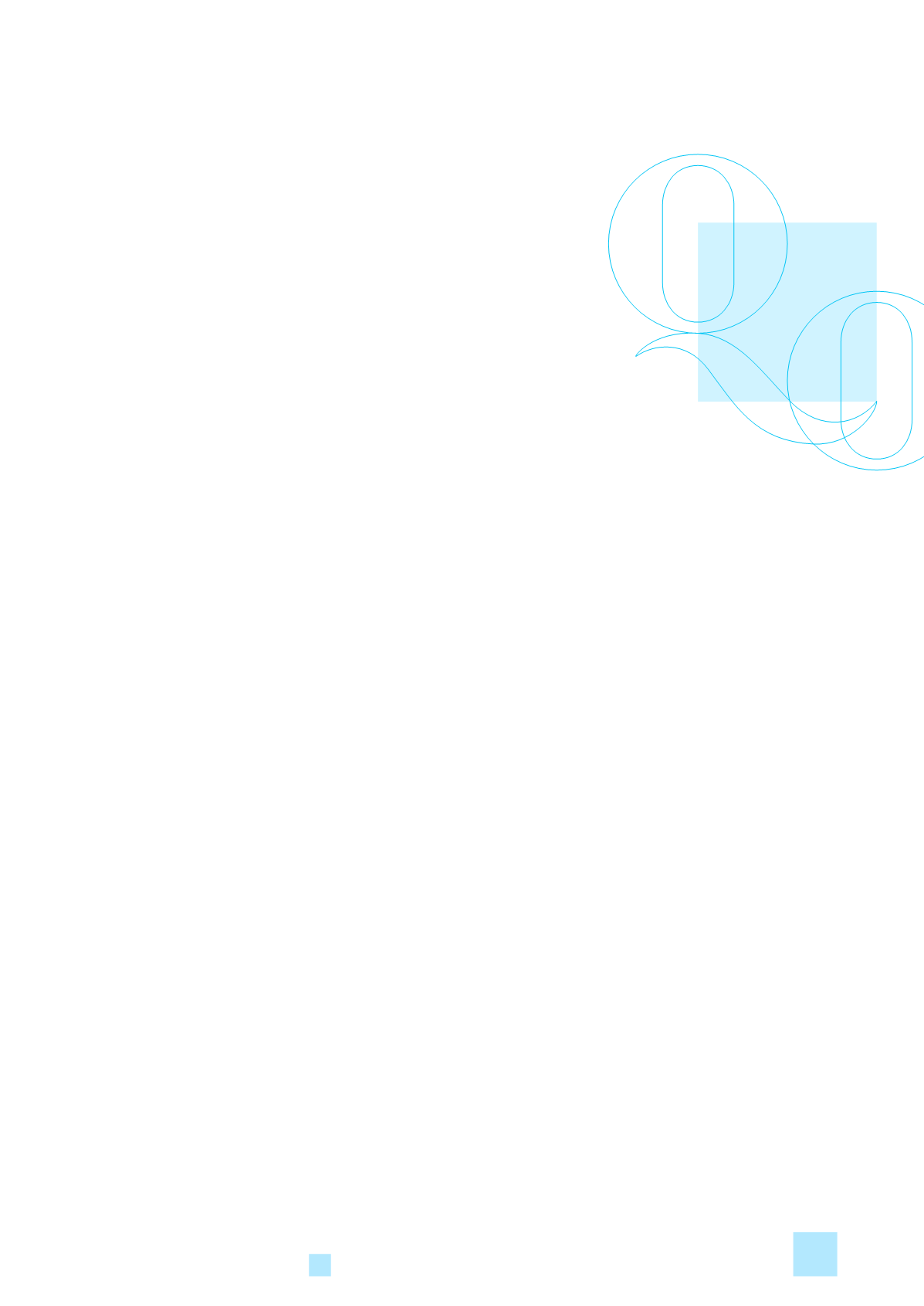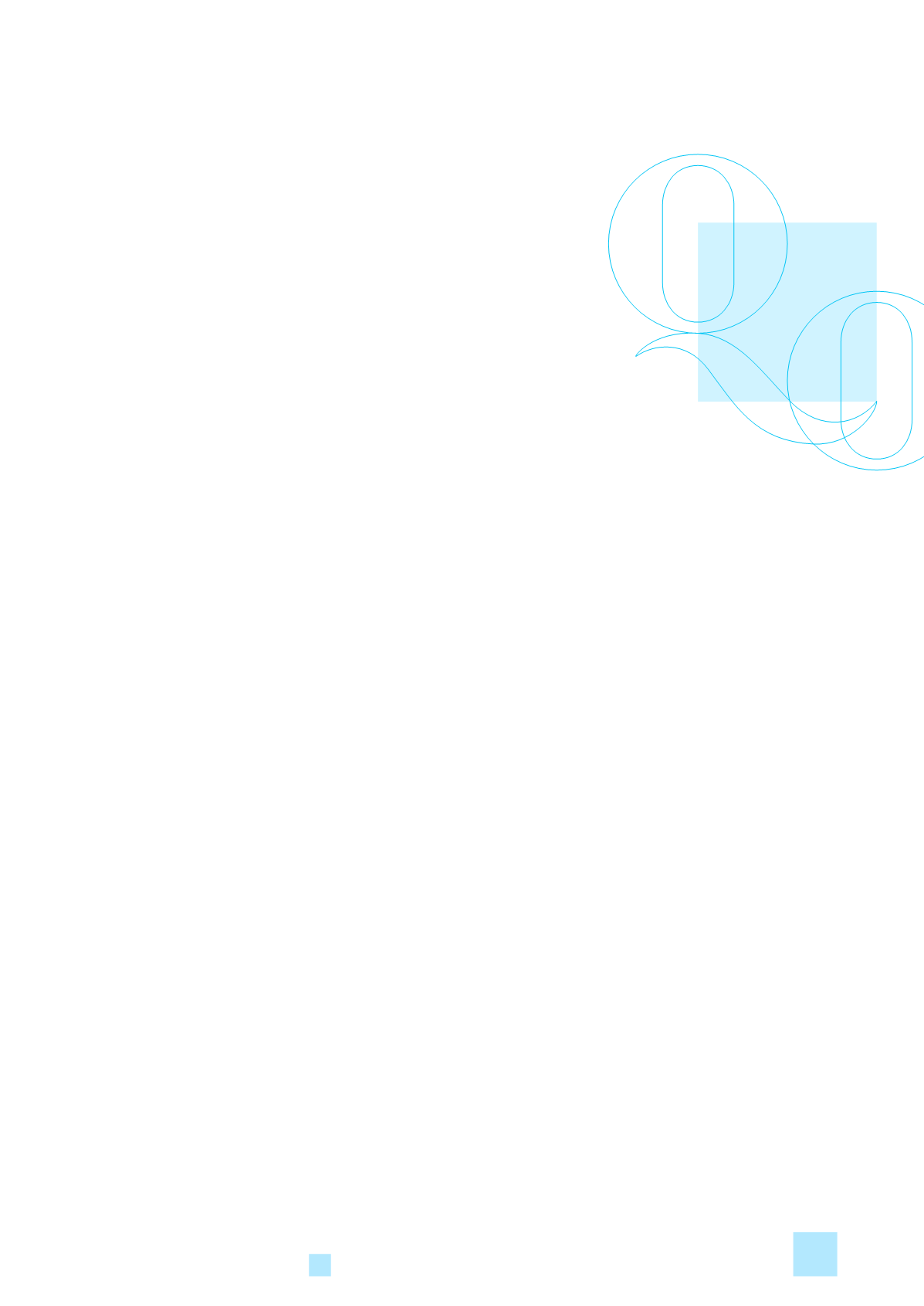
25
23
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
della teoria metacognitiva e si è pun-
tualizzato il fatto che l’insegnante
dovrebbe avere il ruolo di “esperto,
di mediatore, di accensione del pro-
cesso conoscitivo e di guida attraver-
so i differenti livelli di competenza”.
Inoltre si è osservato che la didattica
metacognitiva impone una continua
interazione tra docente e alunno, che
deve sapere per quale obiettivo lavo-
ra e deve trovare, opportunamente
motivato, le strategie più idonee a sé
e al compito da svolgere. Di seguito
sono stati analizzati il concetto di
stile cognitivo e le sue due possibili
modalità che Witkin definisce “indi-
pendenza dal campo e dipendenza
dal campo”. Si sono, infine illustrate
le caratteristiche cognitive di ciascu-
no stile, legate alle differenti qualità
del singolo individuo, da quello ver-
bale a quello visuale, riflessivo,
impulsivo, analitico, globale, siste-
matico, intuitivo e gli aspetti fonda-
mentali del pensiero convergente e
divergente. Nel secondo incontro si
sono esaminati dei questionari sugli
stili di apprendimento e sull’intelli-
genza. Specie per quanto riguarda
quest’ultimo è emerso che molto del
modo di porsi dell’alunno verso la
scuola e del docente verso l’alunno
dipende dal concetto che si ha di
intelligenza. Se essa è vista in un’ot-
tica entitaria, ci si può modificare
poco e scarso risultato si attribuisce
all’impegno, se essa è vista, invece,
in un’ottica incrementale, è possibile
modificare le situazioni.
Nel terzo incontro si sono esaminati
dei casi concreti. In particolare, men-
tre per la teoria entitaria “l’impoten-
za appresa” è definitiva, la teoria
incrementale non consente di abbas-
sare i livelli di aspettativa per l’alun-
no che sostiene di “non farcela”, al
contrario prevede di sostenere la
motivazione e di insegnare le strate-
gie per affrontare il compito assegna-
to. I risultati sono legati alla conti-
nuità di una scelta metodologica che
va perseguita dall’inizio alla fine del-
l’anno. Può essere utile in caso di
disistima verso le proprie capacità un
approccio fondato sull’apprendimen-
to cooperativo.
Si è parlato poi delle caratteristiche
degli obiettivi di prestazione e di
padronanza, della teoria dell’attribu-
zione e degli effetti dello stile attribu-
tivo. Si è analizzato un questionario
sulla motivazione che si è deciso di
somministrare agli alunni di prima,
seconda e terza B.
Nell’ultimo incontro si è presa visio-
ne dei risultati emersi dal questiona-
rio sulla motivazione e si è visto che
in generale gli alunni non hanno una
visione univoca di approccio alle atti-
vità didattiche e che spesso la stessa
persona fluttua tra scelte che implica-
no la padronanza o la prestazione.
La parte del sottoprogetto riguardante i
docenti è stata per varie cause la più
problematica, quella che ha messo
maggiormente in evidenza luci e
ombre.
Il gruppo di lavoro, pur apprezzando la
libertà progettuale lasciata dal Centro
di Orientamento regionale, si è sentito
privo di effettivi supporti; ha percepito
il progetto come calato dall’alto ed
eccessivamente dispendioso in termini
di impegno e di energie necessari per
fronteggiare un problema importante
come lo star bene a scuola.
I docenti ritengono che le Istituzioni
in genere e l’utenza richiedano da
loro prestazioni sempre rinnovate ed
efficaci senza avere in cambio stru-
menti idonei e riconoscimenti di tipo
professionale ed economico. Anche
il progetto della Regione prevede un
limitato bilancio e un’ulteriore fatica
che, per le finalità che intende per-
seguire, va spesa con continuità
d’impegno e in tempi lunghi.
Le difficoltà maggiori riguardano
aspetti organizzativi di tipo tempora-
le (il progetto è entrato in fase opera-
tiva ad anno scolastico inoltrato) e di
tipo sostanziale: non si può affidare
a un numero limitato di docenti del
consiglio di classe la cura di portare
avanti un’iniziativa che dovrebbe
incidere sui comportamenti degli
alunni. Obiettivi di tipo relazionale e
socio-affettivi dovrebbero essere
condivisi da tutti gli insegnanti non
solo come enunciazione di princi-
pio, ma come effettiva adesione a
scelte pedagogiche che impegnano
in un processo che dev’essere conti-
nuamente verificato.
I punti di forza del progetto sono
stati individuati nel corso di forma-
zione che ha consentito di ascolta-
re in forma sistematica concetti di
psico-pedagogia in parte noti e di
confrontare esperienze e idee
diverse.
Inoltre, anche le classi hanno rispo-
sto in modo generalmente positivo
all’iniziativa. In particolare, l’attività
svolta in prima durante un’ora di
compresenza (italiano-storia) è stata
occasione per riflettere su comporta-
menti, emozioni e situazioni concre-
te che si andavano creando via via in
classe.
In definitiva, la comunicazione, la
condivisione e il riconoscimento
professionale ed economico appaio-
no come i requisiti fondamentali di
qualsiasi proposta di sperimentazio-
ne che si voglia perseguire. Il refe-
rente da solo, forse, non è un trami-
te sufficiente tra l’istituzione che
propone l’iniziativa e chi poi opera-
tivamente la attua: un coinvolgimen-
to più diretto e collegiale di tutti i
soggetti chiamati alla sperimentazio-
ne creerebbe una condizione di
maggiore consapevolezza e una più
sicura motivazione.
g) ALUNNI
Gli alunni coinvolti nel sottoprogetto
della scuola sono stati in tutto ses-
santanove distribuiti in prima,
seconda e terza. E’ stato loro propo-
sto un questionario sulla motivazio-
ne corredato di materiale idoneo a
stimolare l’autoanalisi e il confronto.
Soprattutto rispetto ad alcune temati-
che contenute in due diverse versio-
ni di un breve racconto dal titolo “
Un bambino prodigio” si è accesa la
discussione tra chi sosteneva, incon-
sapevolmente a livello teorico, l’idea
entitaria o incrementale dell’intelli-
genza. In generale, però, soprattutto
in prima e in seconda, dove è stato
dato più spazio all’attività, il lavoro
svolto ha prodotto dibattito e con-
fronto.
I risultati del questionario, nelle parti
a risposta chiusa, sono stati raccolti,
tabulati e trasferiti in grafici che
danno un quadro del gruppo e con-
sentono un confronto tra le tre clas-
si. Per quanto riguarda la motivazio-
ne allo studio, nel loro insieme, le
tre classi rientrano nel valore medio
previsto da chi ha elaborato il que-
stionario. Dal punto di vista didatti-
co, è più significativa l’analisi dei
dati del singolo allievo poiché con-
sente interventi più mirati. Una clas-
se ha ripetuto due volte il questiona-
rio allo scopo di verificare eventuali
cambiamenti, che non ci sono stati
in quanto il tempo intercorso tra la
prima e la seconda volta è stato piut-
tosto breve.
CONCLUSIONI
Gli esiti del progetto sono comples-
sivamente positivi anche se i risultati