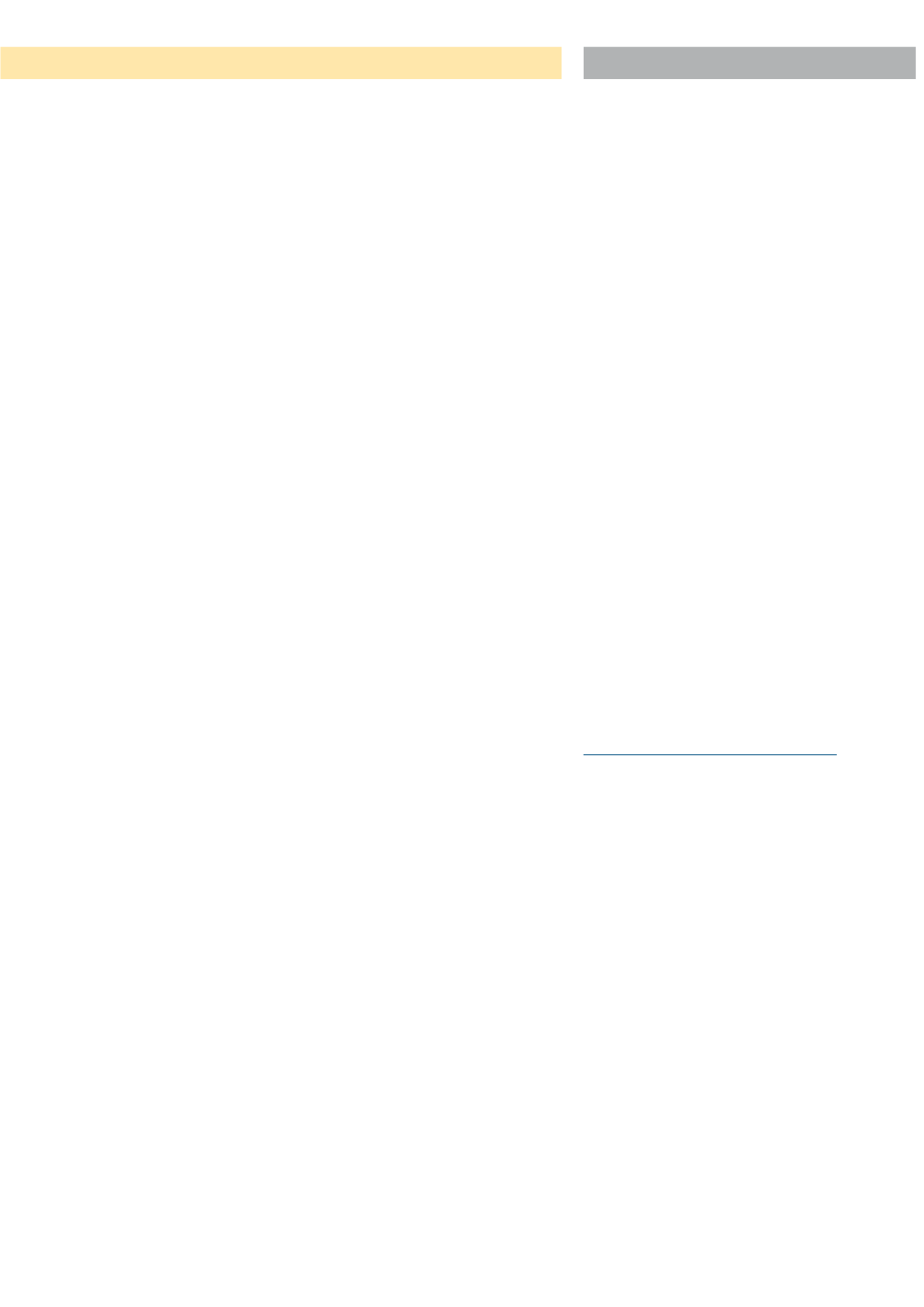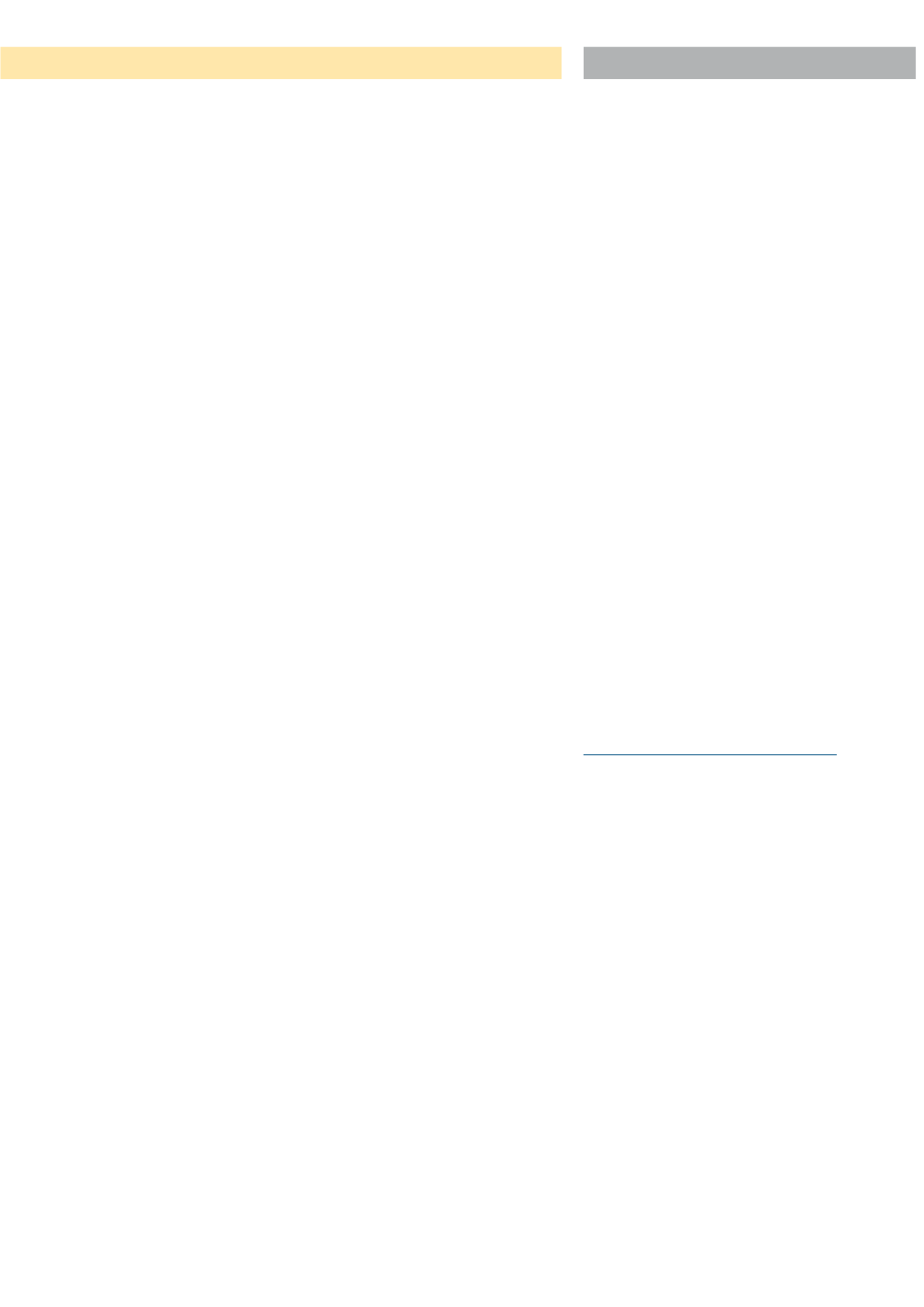
ORIENTAMENTO E SCUOLA
58
richiesta di conoscere il servizio,
gli ho offerto la possibilità di deci-
dere se tornare o meno.
In consultazione si sono pre-
sentate durante l’anno anche si-
tuazioni più critiche di quella ap-
pena descritta: avvenimenti reali
traumatici come separazioni, gravi
malattie, morti, abbandoni, posso-
no creare un eccesso di angoscia
nell’adolescente che non sempre
riesce a tollerare e che a volte lo
inducono a comportamenti a ri-
schio. Per questi casi e per quelli
in cui si evidenziano manifestazio-
ni conclamate come tossicodipen-
denza, anoressia, bulimia, va atti-
vato il collegamento tra la scuola
e servizi del territorio, per avviare
i giovani e le loro famiglie verso
una nuova situazione di aiuto.
CONCLUSIONE
Credo che la consultazione breve
all’interno dell’istituzione scolastica
ha ragione d’essere non nella pre-
sunzione di risolvere la totalità dei
conflitti dell’adolescente, bensì nella
possibilità di un riavvio del processo
di crescita. La situazione di Alessan-
dro ci fa vedere chiaramente come
la ‘crisi evolutiva
’
venga superata nel
momento in cui l’adolescente trova
aiuto nella relazione, che rimette
in funzione la spinta evolutiva. Se
non c’è questo aiuto, ciò che non si
risolve rischia di organizzarsi in una
struttura disfunzionante.
Sempre più si dibatte sulla possi-
bilità di offrire una attività di con-
sulenza psicologica continuativa
all’interno dell’istituzione scolasti-
ca. Una consultazione così intesa
ha, a mio avviso, il significato di
andare incontro davvero alle esi-
genze degli studenti nel difficile
percorso evolutivo. Certamente è
necessario che lo psicologo abbia
ben chiaro la finalità dell’interven-
to volto a favorire nell’adolescente:
●
●
il contenimento delle ansie;
●
●
il riconoscimento dei propri di-
sagi interni;
●
●
il processo di separazione-indi-
viduazione;
●
●
lo sviluppo delle potenzialità che
incoraggiano l’autonomia e l’as-
sunzione delle proprie responsa-
bilità in ciò che gli accade.
L’opportunità di poter scegliere
e utilizzare la consulenza come un
luogo riservato di ascolto, ha rap-
presentato per i giovani un’espe-
rienza di crescita. Attraverso la
relazione sono stati aiutati a dare
parola alle tensioni senza nome e
al dolore a volte indicibile, hanno
trovato nella scuola uno spazio di
accoglienza de l loro essere adole-
scenti, al di là del ruolo di studenti;
un ascolto attento, senza pregiu-
dizi, che li ha guidati nel cammino
di ricerca di sé e di riconoscimento
delle proprie risorse.
Ornella Kratter
Psicologa-Psicoterapeuta
BIBLIOGRAFIA
Bion W.R.
Apprendere dall’esperienza,
Armando, Roma, 1972.
Meltzer D.
Seminari sull’adolescenza,
Quaderni di Psicologia Infantile,
Borla, Roma, 1979.
Meltzer D.
Il ruolo educativo della famiglia,
Centro Scientifico Torinese, Torino,
1990.
Nicolò A.M., Zavattini G.C.
L’adolescente e il suo mondo
relazionale,
La Nuova Italia Scientifica, Roma,
1992.
Senise T., Aliprandi M.T., Pelanda E.
Psicoterapia breve di individuazione,
Feltrinelli, Milano, 1990.
Pietropolli Charmet G.
I nuovi adolescenti,
Raffaello Cortina, Milano, 2000.