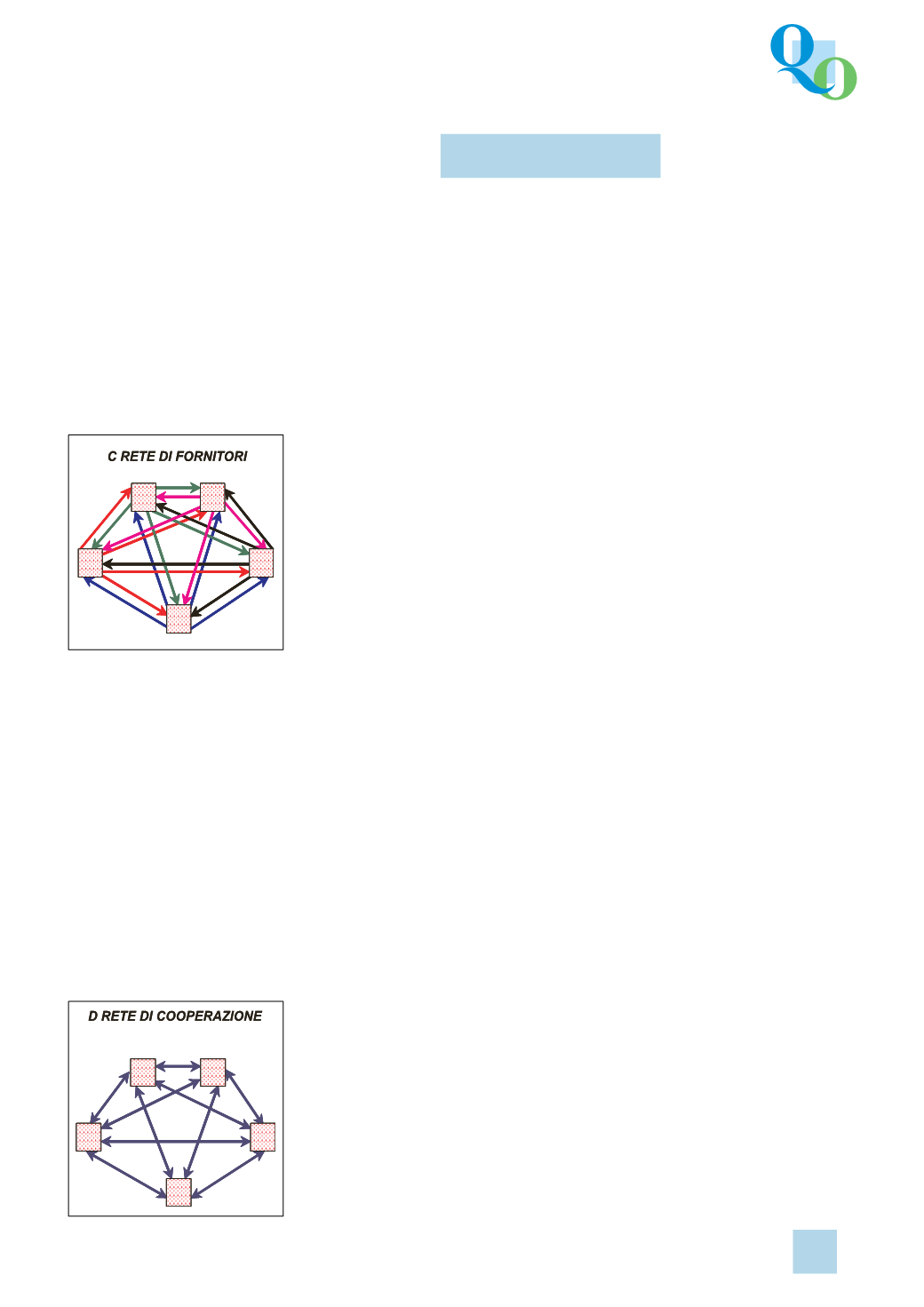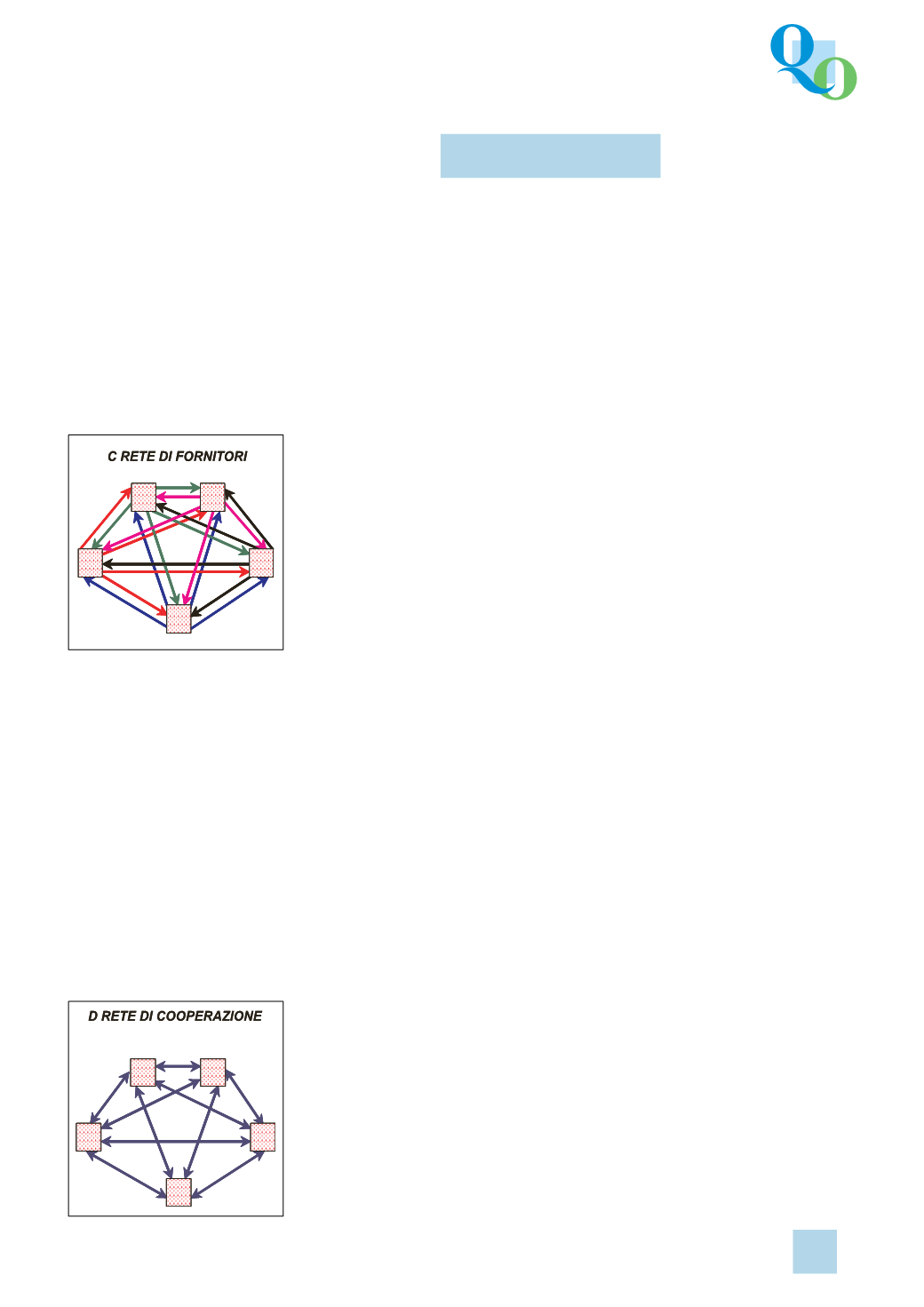
un’acquisizione da parte di altri.
Questo è quanto, ad esempio, av-
viene nell’azione che concerne i
la-
boratori d’orientamento
: tutte le
scuole superiori di una Rete orga-
nizzano autonomamente delle gior-
nate di laboratorio per gli studenti
delle scuole medie e queste ultime
vi indirizzano i propri studenti
(l’organizzazione nel suo comples-
so viene comunque coordinata dal
team di azione
); similmente avviene
per un’azione come la rassegna o
expo per l’orientamento, anche se
in quest’ultimo caso l’erogazione
del servizio ha luogo in un’ unica
sede comune, messa a disposizione
da un nodo (es. sale comunali dei
Centri Servizi).
Infine, per azioni di miglioramento
e di ampliamento, il sistema è di
ti-
po D
.
In queste azioni ogni singola
scuola provvede all’erogazione
del servizio per i propri studenti.
La cooperazione avviene all’inter-
no dei
team di azione
, che in questi
casi sono particolarmente ampi e i
nodi vi sono rappresentati per la
quasi totalità. In questo tipo di
azioni
(percorsi di orientamento ad
una scelta consapevole
nelle scuole
medie, valutazione delle compe-
tenze e portfolio nel passaggio tra
i due ordini di scuola, azioni di ri-
motivazione e di ri-orientamento
per alunni di 15, 16 anni nell’eser-
cizio - assolvimento del diritto -
dovere all’istruzione e alla forma-
zione), è dato particolare rilievo
alla fase di condivisione - tra i no-
di - dei criteri che regolano la de-
finizione e la progettazione dei
percorsi e delle attività (che poi
ciascun nodo attua autonoma-
mente), allo scopo di giungere al
miglioramento e all’ampliamento
del servizio, che ciascuno già ero-
ga. In questo caso, il contesto del-
la Rete fornisce una maggiore arti-
colazione ai percorsi e permette di
puntare l’attenzione più sull’uten-
te finale (studente e famiglie) che
sul soggetto erogatore (la singola
scuola). Nelle fasi di
gestione gene-
rale e consulenza
il sistema è invece
di
tipo A
, cioè acquisizione del
servizio. In queste fasi infatti i sin-
goli nodi divengono utenti di un
servizio che viene offerto dal “la-
boratorio”: essi fruiscono dei pro-
getti, degli strumenti e dei mate-
riali messi a punto dal
team di
coordinamento
ed adottano le pro-
cedure che vengono proposte. Il
sistema si presenta quindi
mono-
centrico
nelle fasi pre e post eroga-
zione del servizio mentre è preva-
lentemente
policentrico
nella fase
di erogazione del servizio.
GLI ELEMENTI
COSTITUTIVI
DELLA RETE
La Rete come insieme di nodi e di rela-
zioni
Dal punto di vista dell’analisi delle
Reti sociali, le Reti formate da soli
Istituti scolastici o le Reti interistitu-
zionali appartengono alla categoria
delle Reti formali, la quale defini-
sce, a sua volta, un tipo di Rete so-
ciale
6
. Questo approccio rappresen-
ta la Rete come una figura costitui-
ta da “un insieme di punti (nodi) e
di linee o frecce di collegamento (re-
lazioni)”, in cui si dà importanza
non tanto alle singole individualità
(ai singoli nodi) bensì ai legami e
agli scambi esistenti tra i nodi di
una Rete. Questo concetto di Rete
implica quindi che l’appartenenza a
una Rete offra una serie di possibi-
lità ma imponga nel contempo alcu-
ni vincoli (ad esempio il rispetto di
una programmazione coordinata).
Le Reti non si definiscono però solo
in base ai vincoli tra i nodi o alla di-
mensione (quantità dei nodi) ma
anche in base allo scopo che si pre-
figgono; un soggetto (un nodo) può
quindi appartenere contempora-
neamente a più Reti, in ognuna del-
le quali può rivestire un ruolo di-
verso a seconda della posizione as-
sunta rispetto agli altri soggetti (da
centrale a periferico).
Scopi per cui una Rete si costituisce e
condizioni di partenza.
Con quale scopo dunque si costitui-
sce una Rete? Quali condizioni di
partenza favoriscono l’adozione di
un sistema piuttosto che di un altro?
In generale, si può dire che tale sco-
po e tali condizioni riguardano la
presenza o l’assenza di servizi e l’op-
portunità di fruirne. In particolare, e
25
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
27
Orientamento e scuola