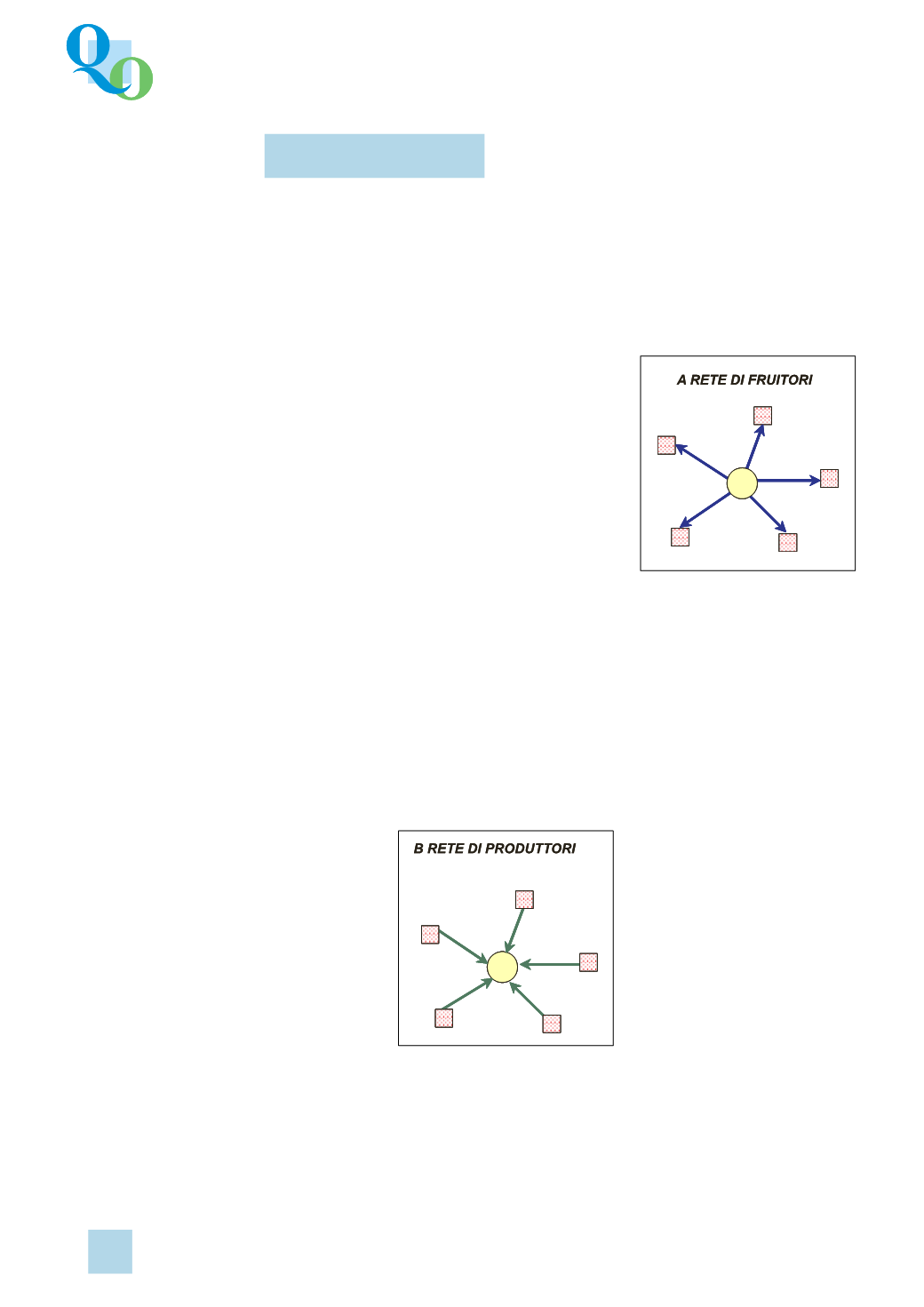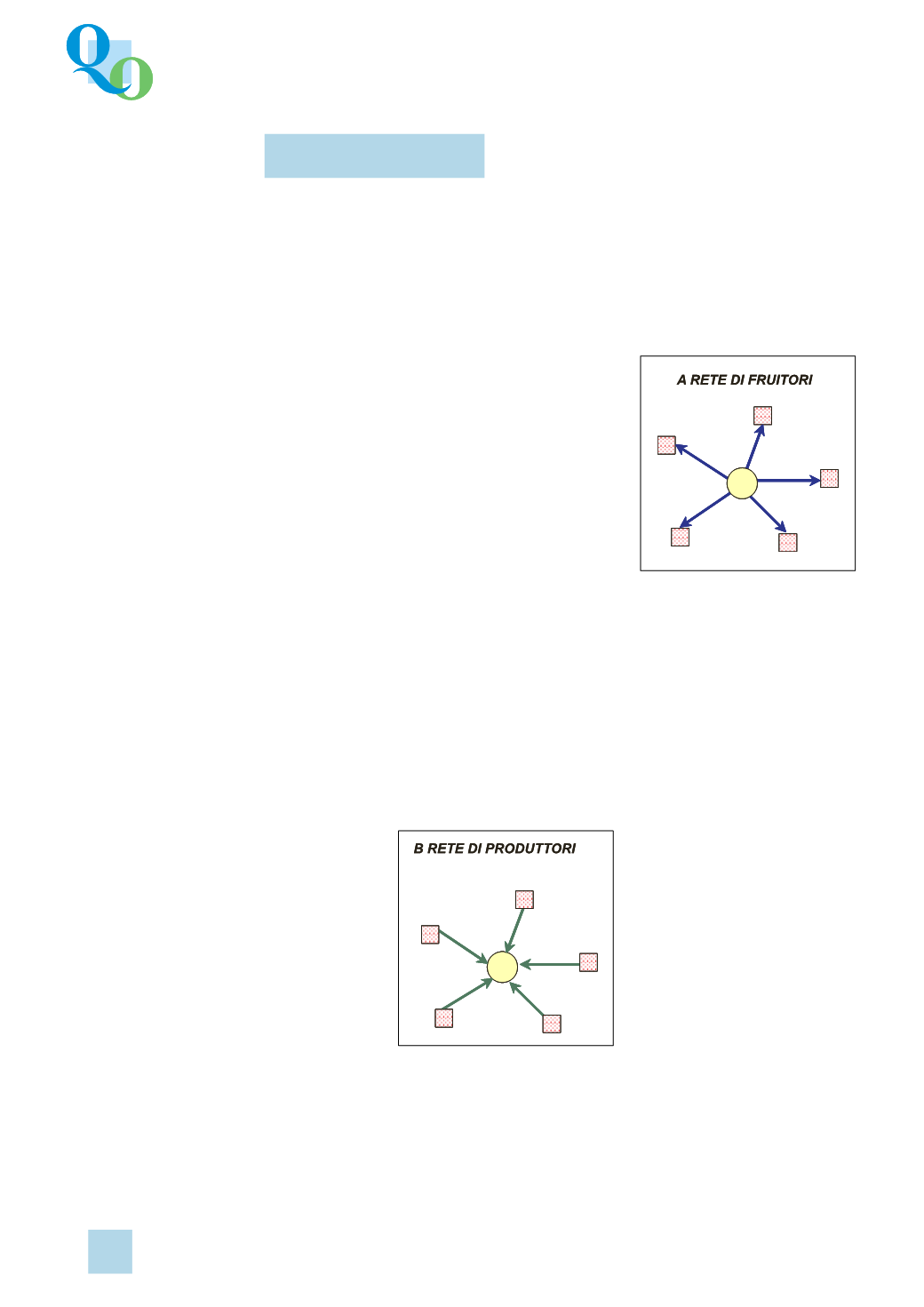
per esempio al sistema A mentre
un’altra attività si conformerà piut-
tosto al sistema D. Questa compre-
senza di sistemi risponde peraltro
ad esigenze spesso complesse delle
Reti reali. Si esemplifica ora questo
concetto in base a quanto osservato
in relazione a reti di orientamento.
RETI DI
ORIENTAMENTO
E SISTEMI DI RETE:
UN ESEMPIO
Nelle fasi di
PROGETTAZIONE
,
cioè di produzione del nuovo servi-
zio, il sistema prevalente è di
tipo
B
; la progettazione si sviluppa in-
fatti nell’ambito di gruppi interisti-
tuzionali in cui sono rappresentati
alcuni nodi della Rete tramite uno o
più operatori. Al fine di costituire
questi gruppi di progettazione e ge-
stione generale, la Rete si struttura
secondo il sistema B: nel “laborato-
rio” (raffigurato dal pallino centra-
le) confluiscono gli operatori, i qua-
li poi si suddividono nei vari grup-
pi o team, che successivamente co-
minciano a lavorare alla organizza-
zione generale delle attività e alla
definizione delle procedure di ero-
gazione / acquisizione del servizio.
Nelle fasi di
EROGAZIONE
il si-
stema varia a seconda delle azioni.
Per alcune azioni il sistema è di
tipo
A,
cioè di acquisizione del servi-
zio: il “laboratorio” (raffigurato
dal pallino centrale) provvede di-
rettamente all’erogazione del ser-
vizio, avvalendosi in qualche caso
di uno o più nodi specializzati che
fungono da “sede” dell’erogazio-
ne di servizio. Può essere il caso di
azioni che consistono in incontri
di formazione per i genitori o in
corsi di alfabetizzazione per stu-
denti stranieri o in attivazione di
sportelli territoriali: gli incontri
per i genitori, ad esempio, sono
interamente gestiti dal
team di
azione
che si avvale di altri nodi in
qualità di sedi fisiche in cui il ser-
vizio viene erogato. L’utente fina-
le di questo servizio è costituito
dalle famiglie degli studenti: i no-
di (scuole) acquisiscono dalla Rete
il servizio per il quale si rendono
tramiti nei confronti dell’utenza
(le famiglie). Il servizio viene cioè
messo a disposizione delle fami-
glie che fanno riferimento a quel
singolo nodo (scuola).
Per le azioni che prevedono scambi,
il sistema è invece di
tipo C
.
Non si osserva però tanto uno
scambio reciproco tra tutti i nodi,
quanto piuttosto una fornitura di
servizio da parte di alcuni nodi e
UN SISTEMA DI RETE PER L’ORIENTAMENTO
24
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
27
compongono concorrono tutti a de-
scriverla.
I
sistemi A e C
sono caratterizzati
da
tendenza alla stabilità:
in questo ti-
po di Reti i “prodotti” (servizi) esi-
stono già ma non sono ancora ero-
gati a tutti in egual modo e quindi il
target servito non è ancora l’intera
Rete; il sistema risulta pertanto in-
stabile e acquisirà stabilità nel mo-
mento in cui il target servito sarà
l’intera Rete, garantendo
acquisizio-
ne di servizi in forma allargata e comu-
nitaria
. La connotazione finale è la
staticità (nel senso della solidità)
del sistema.
I
sistemi B e D
sono invece caratte-
rizzati da
crescita:
in questo tipo di
Reti i “prodotti” (servizi) non esi-
stono (nel sistema B) oppure sono
ritenuti non più sufficientemente
efficaci (nel sistema D). Il sistema
cerca di crescere attraverso il mi-
glioramento e/o la creazione di ser-
vizi. Questi sistemi tendono al mi-
glioramento attraverso il movimen-
to verso nuovi target e lo sposta-
mento dei propri standard qualita-
tivi verso soglie via via più elevate.
La connotazione finale è la dinami-
cità del sistema (e delle proprie
strutture). I quattro sistemi sono tra
loro comparabili mediante una ta-
bella a doppia entrata, che allinea in
una colonna i sistemi monocentrici
e nell’altra quelli policentrici; in
orizzontale, troveremo una fascia
con i sistemi che tendono alla stabi-
lità e una fascia con i sistemi che
tendono a crescere.
Rispetto alle schematizzazioni teo-
riche, raramente si sono osservate
Reti reali in cui fosse rilevabile uno
di questi sistemi in forma “pura”. Si
sono piuttosto notati numerosi casi
in cui più sistemi sono compresenti,
ciascuno funzionale a specifiche at-
tività della Rete. In una Rete una
certa attività o azione si conformerà