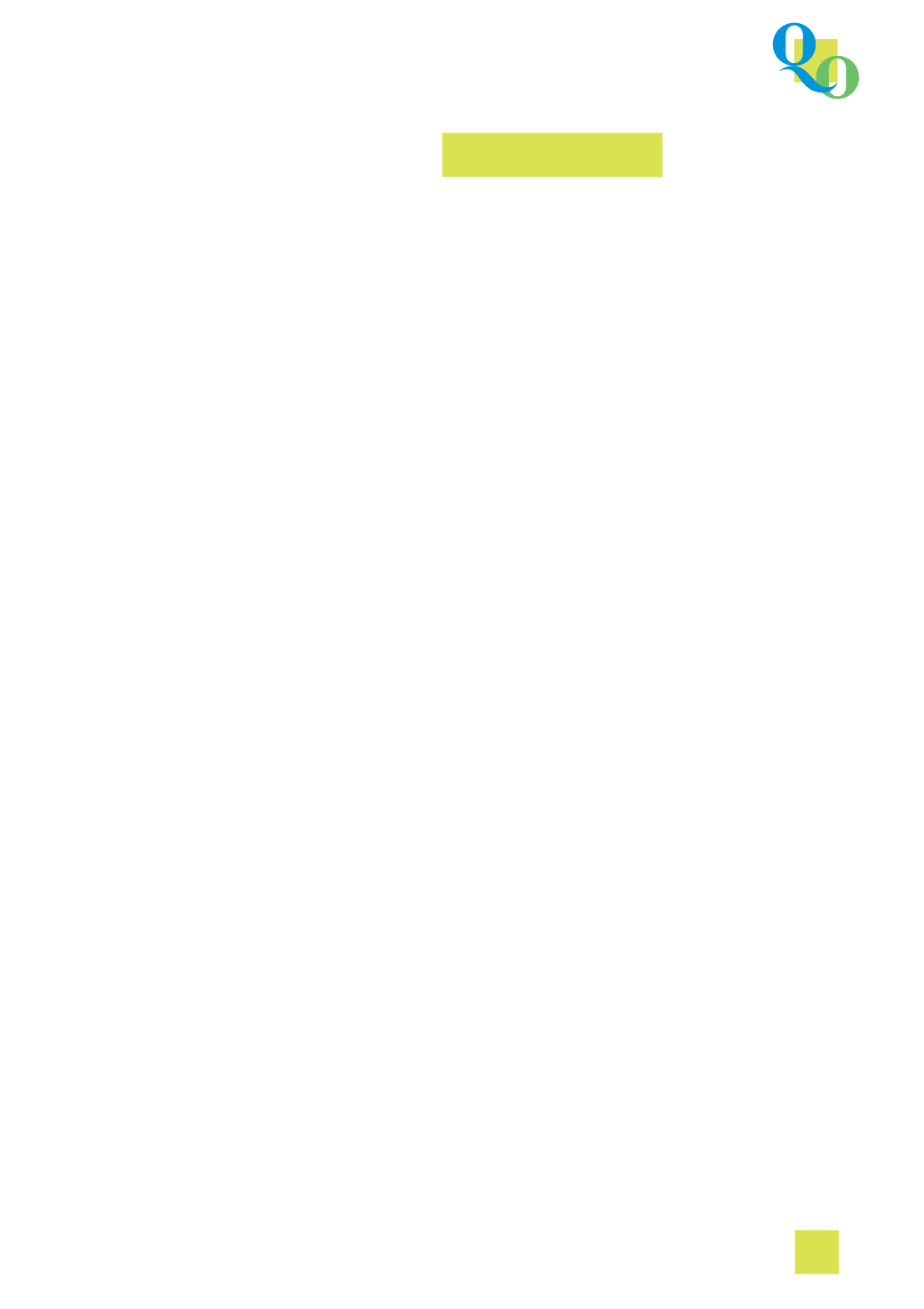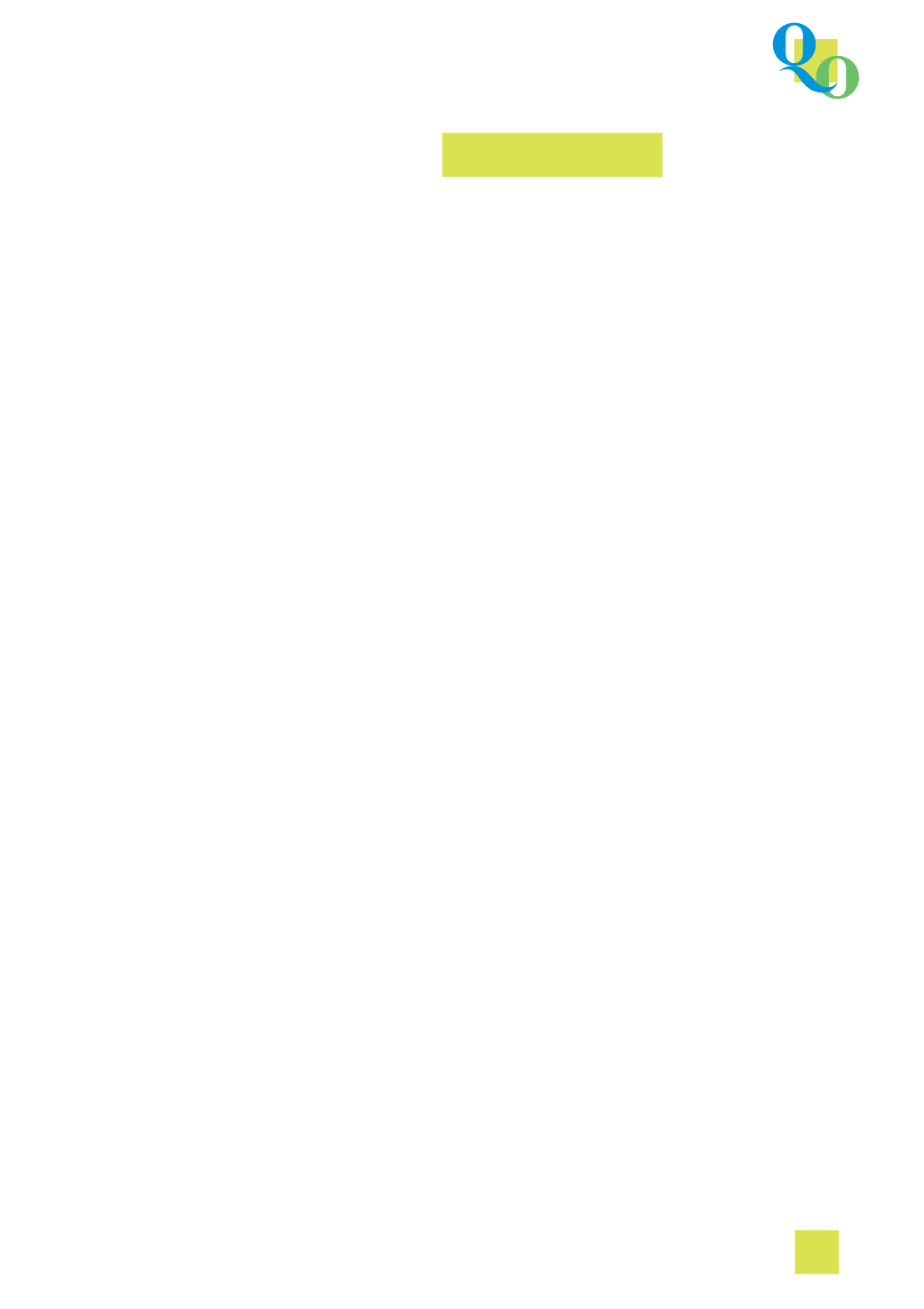
sca una condizione base per la pos-
sibilità di rendere consono e pro-
duttivo un approccio
supply-side
oriented
nella lettura della disoccu-
pazione.
Tale approccio implica il fatto di
riconoscere l’articolazione delle
identità sociali dei disoccupati,
nonché di attribuire ad esse una
certa stabilità (ovvero una certa
resistenza rispetto ai “richiami”
della domanda e, più in generale,
rispetto a scelte di mera conve-
nienza economica indotte dal
MdL). La sensibilità analitica ver-
so l’offerta di lavoro, in primo
luogo, consente di non abbassare
la soglia di attenzione sociale ver-
so la disoccupazione, anche in
presenza di dimensioni contenute
del fenomeno: tale atteggiamento
ci permette, infatti, di ravvisare
appieno la drammaticità della di-
soccupazione, che coinvolge non
solo il singolo individuo disoccu-
pato, ma anche il suo sistema, più
o meno allargato, di appartenenze
sociali. In secondo luogo, questo
taglio analitico rende evidente che
difficilmente, oltre una certa so-
glia, il funzionamento del MdL
garantisce aggiustamenti e riequi-
libri automatici, ma vengono vice-
versa richiesti degli interventi
esterni (attraverso le politiche atti-
ve del lavoro). In terzo luogo,
l’approccio
supply-side oriented
li-
mita il rischio, crescente quando
la disoccupazione si riduce, che
le politiche del lavoro “manchino
il bersaglio”, perché continuano a
“sparare sul mucchio” oppure
perché non conoscono sufficien-
temente il “gruppo-bersaglio”.
Quando i numeri della disoccupa-
zione si riducono, paradossalmen-
te, le politiche del lavoro risultano
più difficili, richiedono maggiore
impegno e sforzo cognitivo, sia
sul piano progettuale, sia sul pia-
no operativo.
Si possono sul punto proporre in-
numerevoli esempi di situazioni,
desumibili dalla realtà, in cui gli
obiettivi delle politiche non ven-
gono colti, perché queste risultano
mal calibrate. Ne citiamo alcuni in
ordine sparso: politiche di svilup-
po occupazionale che generano
posti di lavoro non in linea con le
aspirazioni dell’offerta locale e
che di fatto favoriscono, eventual-
mente, solo l’occupazione di lavo-
ratori immigrati; iniziative per in-
centivare la mobilità dei lavorato-
ri disoccupati del Sud che non tro-
vano adesioni o che coinvolgono
lavoratori del tutto inadeguati ri-
spetto alle esigenze del tessuto
produttivo destinato ad accoglier-
li; azioni di promozione dell’oc-
cupazione giovanile che favori-
scono, di fatto, giovani che trove-
rebbero ugualmente lavoro (per
esempio perché diplomati presso
istituti professionali o tecnici),
sbarrando invece la strada ad al-
tre categorie di offerta giovanile
particolarmente svantaggiate (ad
esempio giovani in possesso delle
cosiddette lauree deboli); azioni
in favore dei “disabili” che, di fat-
to, non articolando gli interventi
in funzione delle diverse forme di
disabilità, finiscono per sostenere
gli atteggiamenti stereotipati e
pregiudiziali delle imprese; istitu-
zione di sistemi di incentivazione
del lavoro femminile, inefficaci
perché non accompagnati da con-
testuali interventi sul fronte delle
politiche alla famiglia; svolgimen-
to di programmi di lavoro social-
mente utile, finalizzati alla riqua-
lificazione dei disoccupati, quan-
do questi concepiscono tali inizia-
tive unicamente in termini risarci-
tori o di sostegno assistenziale;
potenziamento dei servizi dedica-
ti alle attività di diffusione delle
informazioni sulle opportunità di
lavoro, senza integrare le medesi-
me attività con opportune e quali-
ficate azioni di orientamento, per
produrre il necessario grado di al-
lineamento tra la aspettative dei
disoccupati stessi e la struttura
delle opportunità occupazionali;
potenziamento degli strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupa-
ti senza sviluppare contestuali
azioni di sostegno alla ricerca atti-
va del lavoro e finendo per favori-
re atteggiamenti passivi e rinun-
ciatari dei disoccupati stessi
4
; cor-
si di formazione imprenditoriale
frequentati da giovani disoccupa-
ti, estremamente deboli dal punto
di vista della dotazione di risorse
cognitive, motivazionali, espe-
rienziali e relazionali, risorse irri-
nunciabili per il percorso impren-
ditoriale a cui le iniziative forma-
tive mirano.
Passiamo ora a verificare qual è la
situazione in Friuli-Venezia Giulia
ed in che misura le precedenti os-
servazioni possano trovare applica-
zione in tale contesto.
LE DIMENSIONI
COMPLESSIVE DELLA
DISOCCUPAZIONE
IN FVG
Lo stock di disoccupati registrati
complessivamente e mediamente in
Friuli-Venezia Giulia nel corso del
2002 è stato pari a circa 19.000 per-
sone (Fonte: Istat)
5
. Tale valore cor-
risponde ad un tasso di disoccupa-
zione del 3,7%
6
. Si tratta di un valo-
re che può considerarsi in linea con
le soglie di disoccupazione prodot-
Orientamento e società
33
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
23