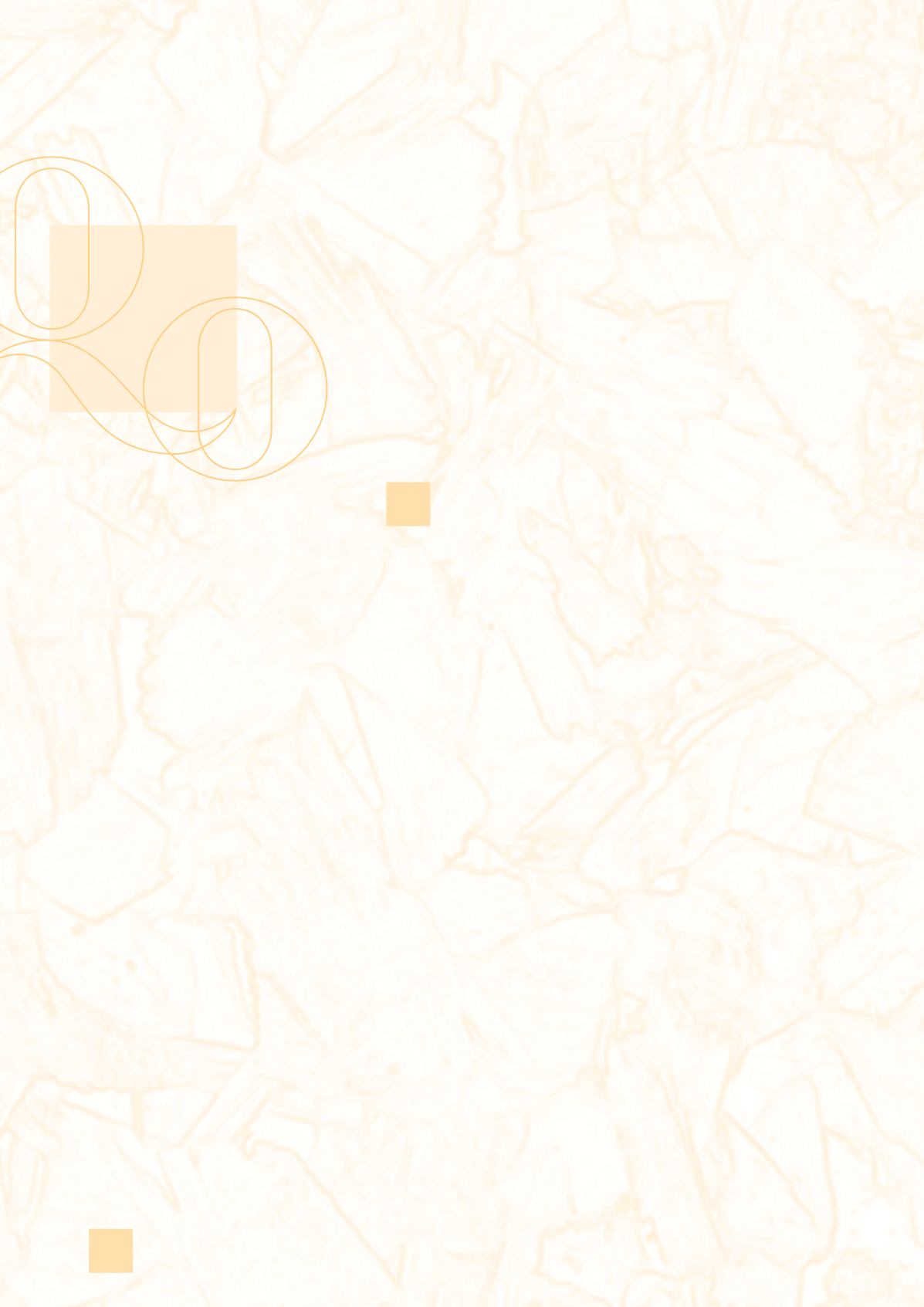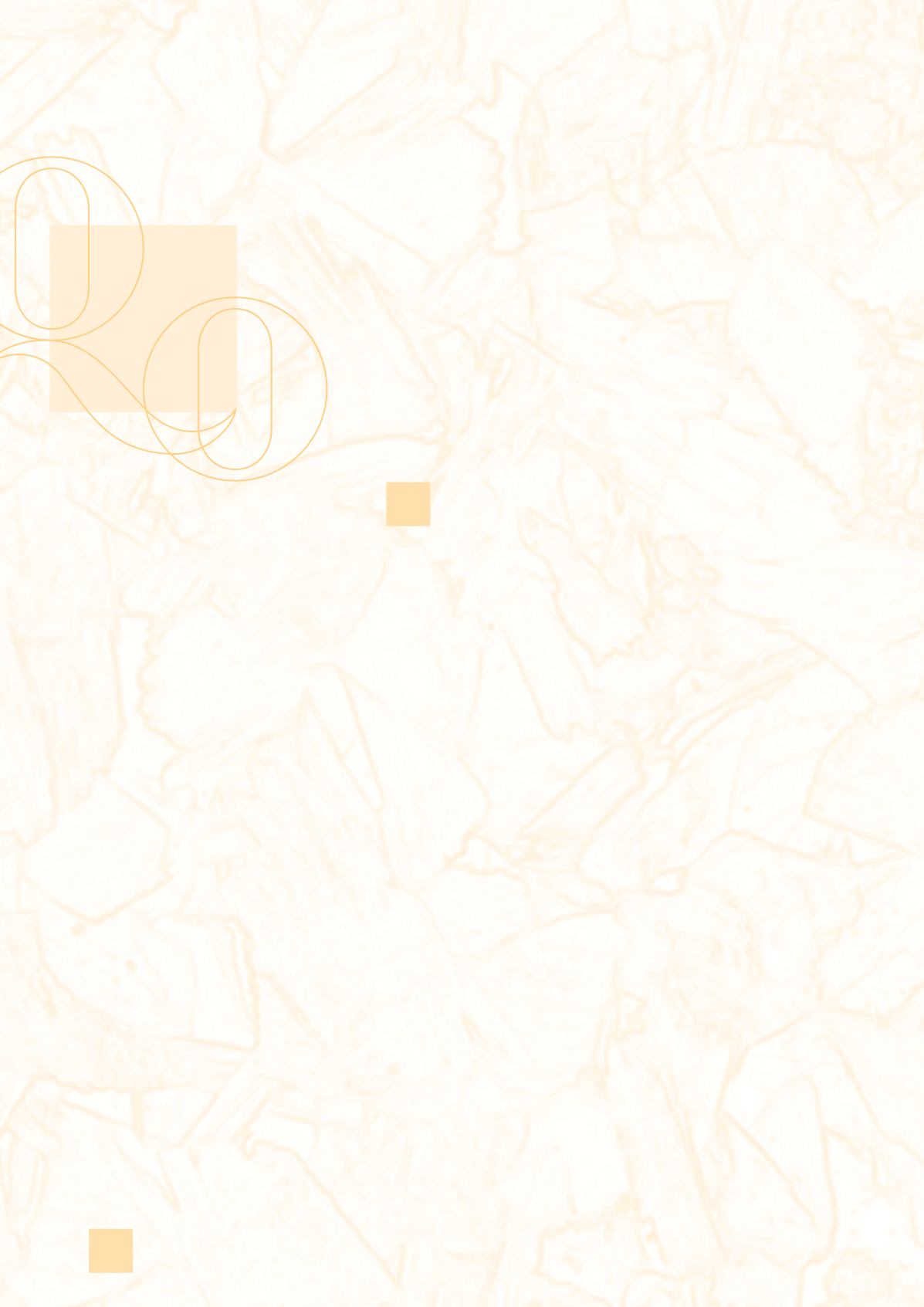
28
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
22
cologico per adolescenti attivato
dalla Clinica Ostetrica e Gineco-
logica dell’Università di Udine.
I maschi sono meno attenti ai se-
gnali del proprio corpo e quasi
mai affrontano l’argomento ses-
sualità a meno che non sia il ge-
nitore a mediare la richiesta so-
prattutto legata alla percezione di
ipotetiche anormalità (sviluppo fi-
sico, sessuale, muscolare) perce-
pite per le diverse fasi della pu-
bertà che possono avere tempi
molto diversi da persona e perso-
na.
La percezione errata del proprio
corpo e della fisicità rappresenta-
no, molto spesso, una causa di
malessere nell’adolescente che
può sfociare in gravi patologie
come l’anoressia nervosa, o più
frequentemente, produrre una fa-
se di malinconia, di depressione
che hanno come conseguenza
l’apatia, la demotivazione, la
noia, la ricerca del futile come
riempitivo. Le famiglie sono total-
mente esposte a questo rischio e
spesso si rivolgono al pediatra
con la richiesta di accertamenti,
mentre la richiesta è di aiuto nel
trovare la chiave di lettura per
aprire un dialogo produttivo e
proiettato verso il futuro con il
proprio figlio. Ancora una volta i
servizi sanitari in collaborazione
con la scuola e la famiglia do-
vranno essere promotori di fasi
d’informazione e di orientamento
sulla salute e sullo sviluppo psi-
co-fisico legato all’adolescenza
che a tutt’oggi rimane un’area
troppo spesso svincolata dalle
competenze di ciascuno di noi
con le potenziali ricadute negati-
ve nelle fasi successive della gio-
vinezza e nell’età adulta.
Il benessere, quindi, anche per il
pediatra attraversa fasi diversifica-
te che si modificano quotidiana-
mente; siamo consci che l’ap-
proccio al paziente è fatto di
competenza e scientificità ma an-
che di ascolto e umiltà, senza la
pretesa del risolvere ogni situa-
zione nella solitudine del rappor-
to privato medico-paziente; sfrut-
tare le risorse umane, la sensibi-
lità di ogni singolo operatore o
struttura permette di attivare la re-
difficoltà incontrate nell’apprendi-
mento della disciplina e, soprattut-
to, i conseguenti risultati negativi.
Sicuramente, nei primi periodi di
insegnamento, svolti per lo più alle
superiori, era molto lontana da me
l’idea che si potessero presentare
problematiche di questo genere.
Tutto cominciò quando mi trovai a
dover lavorare con delle classi che
si mostravano restìe ad imparare
quanto veniva in genere proposto a
scuola. Per instaurare un rapporto
con gli allievi che mi consentisse
di far apprendere loro almeno i
concetti essenziali della disciplina,
dovetti, prima di ogni altra cosa,
capire come si trovavano a scuola,
perché ci venivano, cosa si aspetta-
vano, perché non volevano studia-
re, perché non ricordavano regole
spiegate il giorno prima …. perché
quel senso di sconfitta prima anco-
ra di tentare. Così mi interessai di
orientamento, metodo di studio e
didattica della matematica, soprat-
tutto nella prima e seconda classe
delle superiori. L’obiettivo princi-
pale era, ed è tuttora, eliminare
quella sorta di timore nell’approc-
cio alla disciplina ed evitare che
eventuali insuccessi potessero in-
taccare la fiducia che uno studente
ha sulle proprie capacità.
Decisi, allora, di rivedere tutto il
programma che dovevo svolgere,
cercando di collegare il più possi-
bile logicamente gli argomenti e di
unificare regole e procedimenti
che avevano la stessa struttura. Un
paio di anni dopo scoprii che an-
che altri avevano avuto la mia stes-
sa idea e che la stavano sviluppan-
do in modo sistematico: era il
gruppo del prof. Ciampolini, allora
Presidente dell’IRRSAE dell’Emilia
Romagna, con” la Ricerca Metodo-
logica Disciplinare”.
Presi spunto dal loro modo di ope-
rare e dalle loro esperienze e tra-
dussi il tutto a mio uso e consumo:
un po’ alla volta feci la “distillazio-
ne” del programma, intesa come”
elenco di tutti gli argomenti che
compongono il corso, sequenzial-
mente disposti in modo che cia-
scuno di essi dipenda razional-
mente solo da argomenti che lo
precedono”, e, su piccole parti del-
la disciplina, fecero altrettanto gli
studenti, ponendone in evidenza la
te assistenziale, senza ruoli se-
condari oppure prevaricanti, of-
frendo un approccio globale al si-
stema salute.
Il benessere del giovane e della
sua famiglia passa attraverso ope-
ratori consci del loro ruolo e de
propri limiti nell’ottica di produr-
re salute non solo come assenza
di malattia ma come star bene
con gli altri, in armonia con l’am-
biente in cui si vive, protagonista
di se stesso e del proprio benesse-
re. Potremo, allora sì, dire di aver
compiuto, tutti insieme, “cose
buone”.
APPRENDIMENTO
DELLA MATEMATICA:
TENTATIVI PER RENDERLO
POSSIBILE E PIACEVOLE
Rita Pravisani
I.T.I. “J. F. Kennedy”
Pordenone
Quando mi viene chiesto che lavo-
ro faccio, di solito dico soltanto:
«insegnante», sperando che non si
voglia indagare sulla materia. Il più
delle volte, però, interessa anche
ciò che insegno e, ovviamente, ag-
giungo: «matematica». Al che le
reazioni non mancano mai e sono
del tipo: «ah!» seguito da uno
sguardo sospettoso con immediato
cambiamento di discorso, oppure
« ho sempre avuto problemi con i
calcoli», cercando di giustificare in
qualche modo tale lacuna e con-
cludendo che, comunque, nella vi-
ta sono riusciti lo stesso, o, ancora,
«avevo una paura del prof. di ma-
tematica! Non mi capiva, però in
tutte le altre materie riuscivo bene»
; solo raramente mi sono stati rife-
riti ricordi positivi. In ogni caso,
nel bene e nel male, tutto ciò che
nel periodo scolastico si collega a
tale materia, ha lasciato un segno.
Per me, come senz’altro per i miei
colleghi, matematica è, insieme, ri-
flessione, rigore, creatività, pensie-
ro, gioco e non solo calcolo, rego-
le e teoremi; per questo, a volte,
non ci accorgiamo del disagio che
possono creare in un ragazzo le