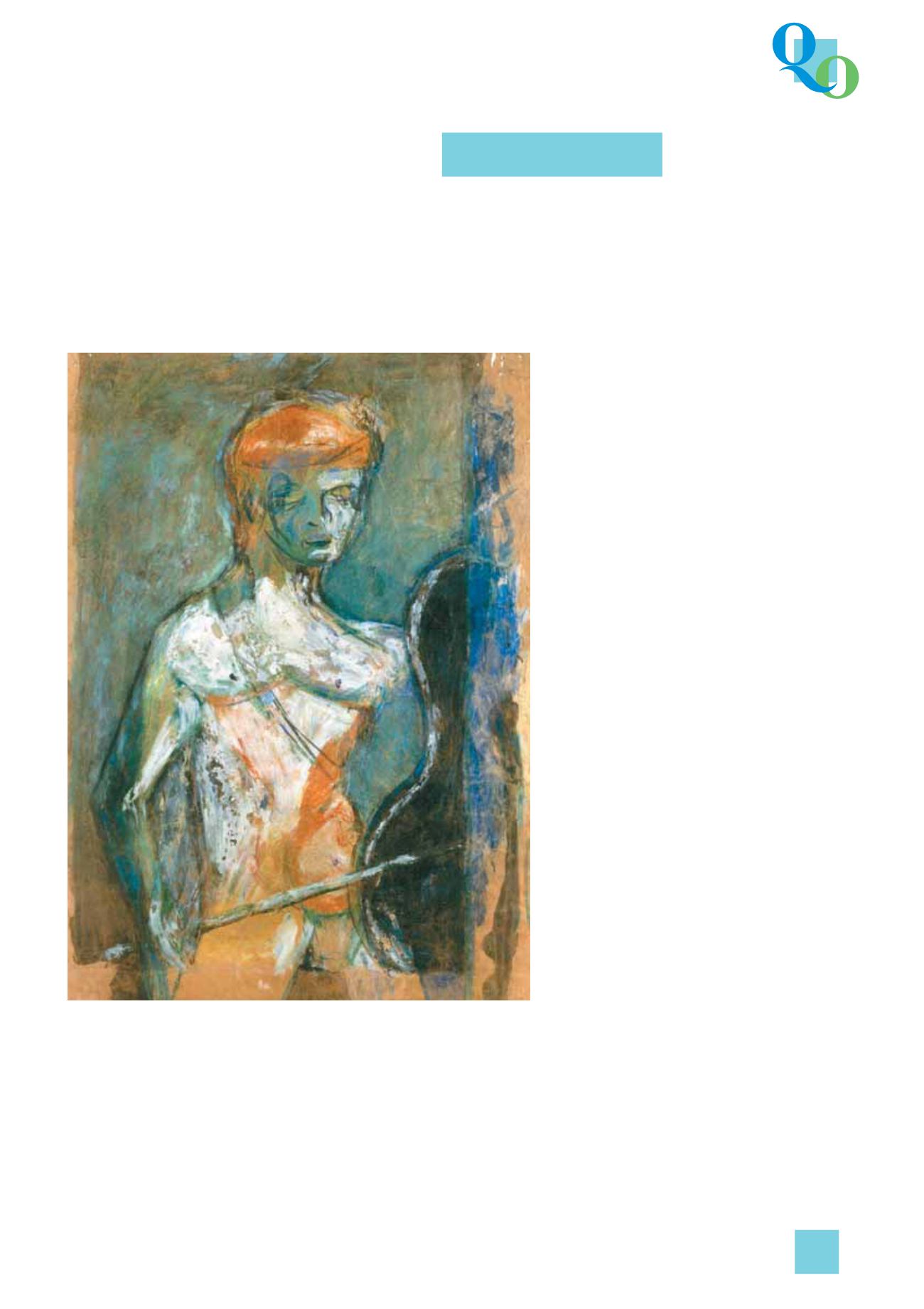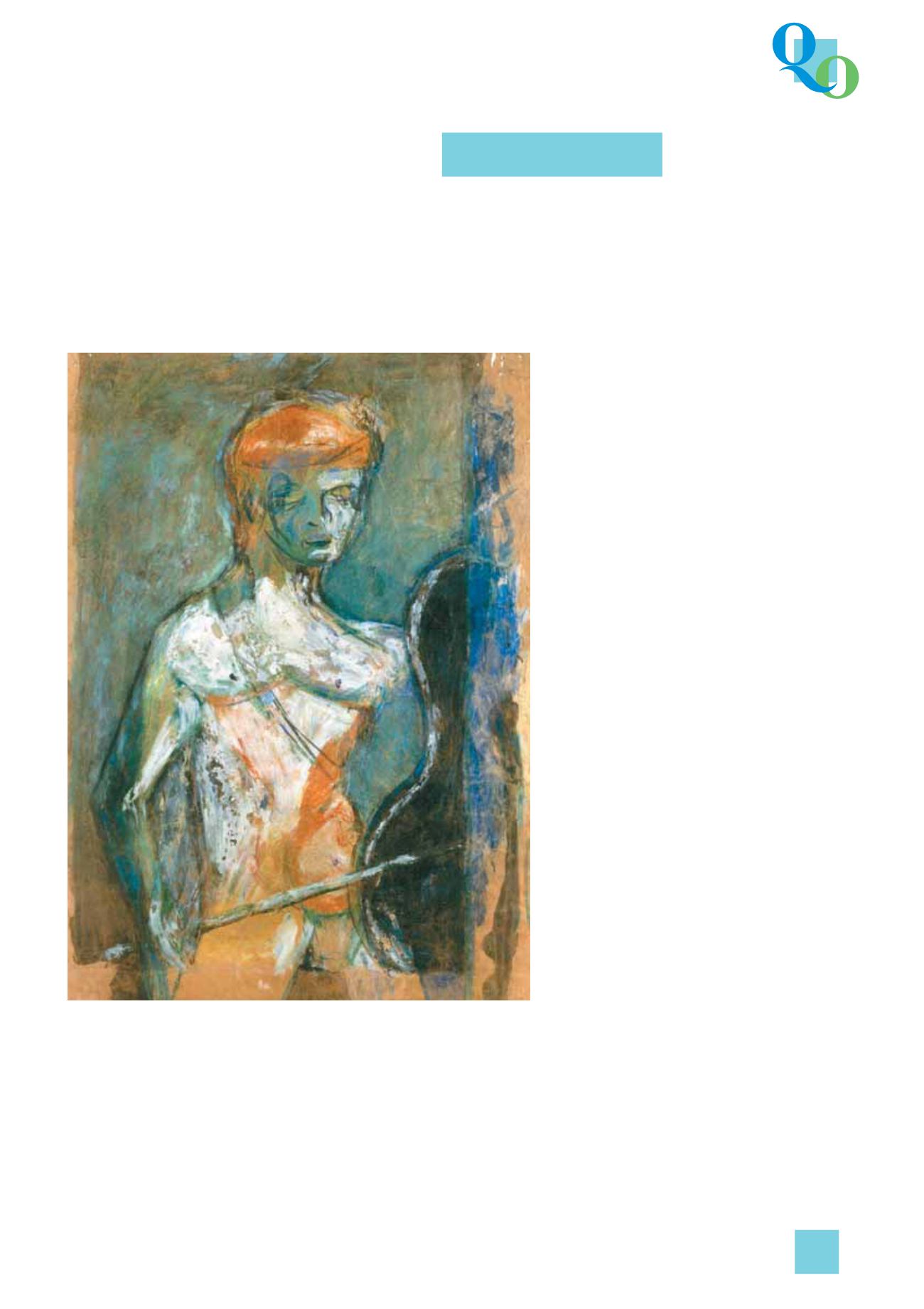
elemento su cui si basano oggigior-
no le rivendicazioni della nostra spe-
cialità (beninteso nell’ambito dello
stato italiano).
Ma, se vogliamo, possiamo risalire
più indietro nel tempo. Basti un solo
esempio: la dichiarazione dei rap-
presentanti delle popolazioni alpine
(le montagne costituiscono, infatti,
di solito riserve di diversità etnologi-
ca e antropologico-culturale), scrit-
ta nel 1943. Riportiamo, per econo-
mia di spazio, solo la parte che ri-
guarda le autonomie culturali e sco-
lastiche. “Per la loro posizione geo-
grafica di intermediarie tra diverse
culture, per il rispetto delle loro tradi-
zioni e della loro personalità etnica,
e per i vantaggi derivanti dalla co-
noscenza di diverse lingue, nelle val-
li alpine deve essere pienamente ri-
spettata e garantita una particolare
autonomia culturale-linguistica con-
sistente nel:
• diritto di usare la lingua locale,
laddove esiste, accanto a quel-
la italiana, in tutti gli atti pubblici
e nella stampa locale;
• diritto all’insegnamento della lin-
gua locale nelle scuole di ogni
ordine e grado con le necessarie
garanzie nei concorsi perché gli
insegnanti risultino idonei a tale
insegnamento. L’insegnamento
in genere sarà sottoposto al con-
trollo o alla direzione di un consi-
glio locale;
• ripristino immediato di tutti i nomi
locali.”
Anche se il discorso potrebbe conti-
nuare a lungo riportando altri esem-
pi, torniamo alla legge 15 dicembre
1999, n. 482 (“Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche
storiche”). In attuazione dell’ art. 6
della Costituzione Italiana (“La Re-
pubblica tutela con apposite nor-
me le minoranze linguistiche”) e in
armonia con i principi generali sta-
biliti dagli organismi europei e inter-
nazionali, “la Repubblica…promuo-
ve… la valorizzazione delle lingue
Spazio aperto
cui in ambito sociologico si parla al-
meno da più di venti anni, è caratte-
rizzata dalla utilizzazione di modelli
culturali che non intendono essere
omologati a quelli moderni. Da tem-
po è in atto un “revival” di grandi e
piccole religioni, una rinascita delle
grandi e piccole culture nazionali,
delle tradizioni etniche, delle identità
locali e regionali. E’ ormai pacifico,
almeno in sociologia, che ci sia un
“nesso dialettico” tra globalizzazione
e localismi. È stato coniato anche il
neologismo “glocalismo” (cioè: glo-
balismo più localismo). D’altra parte
queste peculiarità e in particolare la
presenza di minoranze etnico-lingui-
stiche, oltre a costituire una risorsa da
spendere nei confronti delle regioni
contermini, sono anche il principale
41
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
22
Pier Paolo Pasolini,
Figura con violino
, tempera su carta, 1943-1949