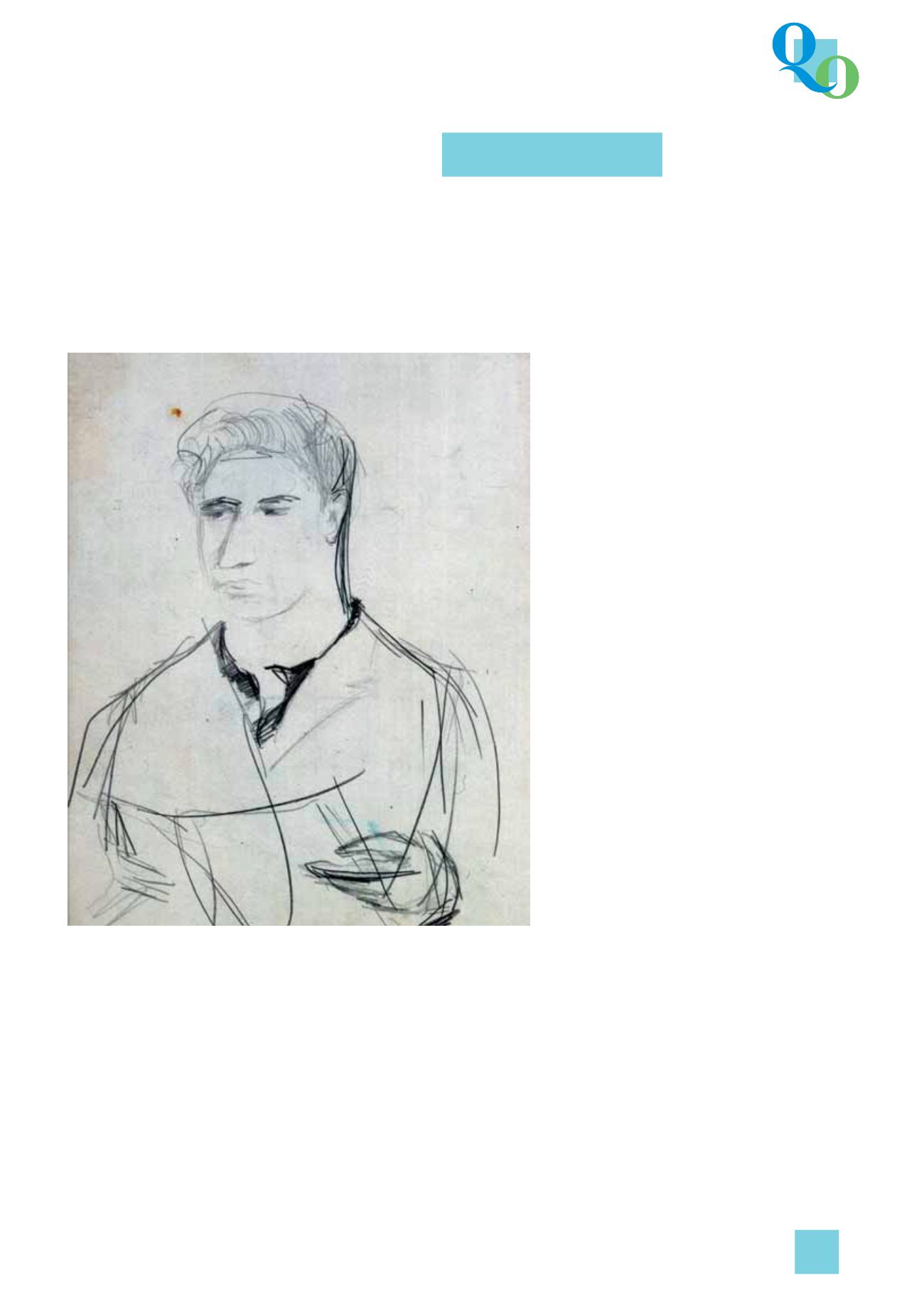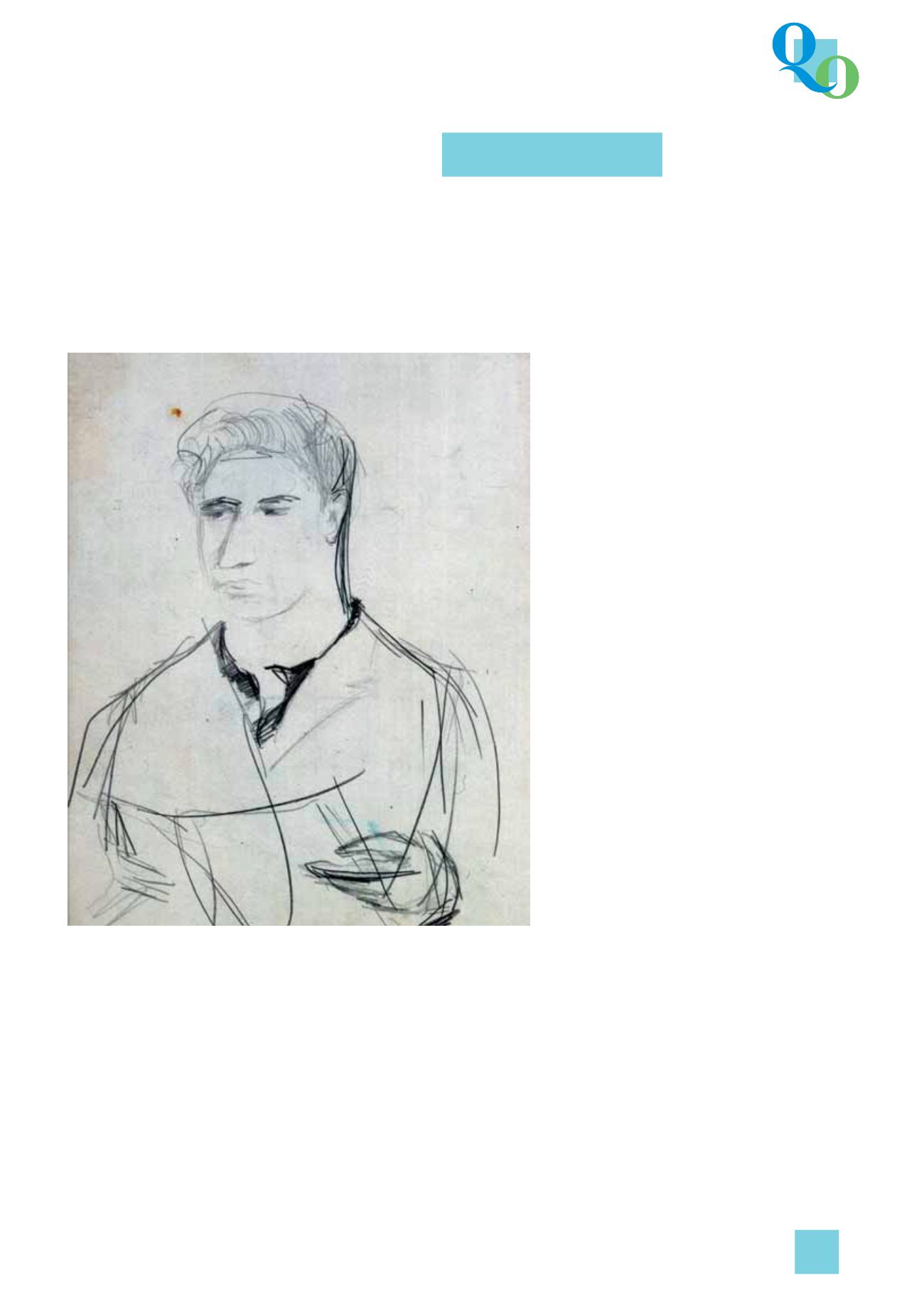
una capacità di sintesi e di focalizza-
zione dei punti nodali, oltre che il
raccordo con altri ambiti (Serafini,
1989). E’ importante che lo studente
tenga in considerazione le sue capa-
cità di resistenza alla fatica, di accet-
tazione degli insuccessi e di un one-
re di lavoro sicuramente superiore a
quello richiesto in precedenza.
Le attitudini
Le attitudini sono “le capacità misu-
rabili e disponibili a livello potenzia-
le, di svolgere una determinata atti-
vità sia fisica che mentale” (Di Fabio,
1998). Se l’
abilità
è la capacità poten-
ziale di fare qualcosa, il concetto di
“
attitudine
” fa riferimento agli aspet-
ti misurabili di questa capacità men-
tre il rendimento è la misura effetti-
va della prestazione. La capacità, a
sua volta, è definibile come “la pos-
sibilità effettiva che un soggetto ha
di realizzare con successo una deter-
minata attività, sia che implichi com-
piti motori, sia che implichi processi
di pensiero, e può consentire l’e-
spressione sia di tendenze innate che
scaturire da processi di apprendi-
mento” (Di Fabio, 1998). Queste de-
finizioni permettono di porre un po’
di chiarezza tra concetti spesso con-
fusi: gli esiti scolastici sono ricondu-
cibili al “rendimento” e non sono
una valutazione delle attitudini, per
le quali esistono materiali e proce-
dure oggettive di rilevazione.
Gli interessi professionali
Di Fabio (1998) definisce gli interes-
si come “l’area delle preferenze e
dei rifiuti in relazione a determina-
te attività professionali, accademi-
che, di tempo libero del soggetto”.
L’interesse ha un forte valore moti-
vante, perché fa sì che venga perce-
pita come desiderabile e soddisfa-
cente l’attività che ne è oggetto.
I valori
Ricorriamo ancora a Di Fabio per
una definizione di questa dimen-
sione psicologica. “ Per valori si in-
tendono preferenze o rifiuti per de-
terminate finalità o stili di vita, da
parte del soggetto”. Super (1968,
1970) categorizza i valori professio-
nali in due ambiti: i valori intrinse-
ci quali riuscita, altruismo, creati-
vità, ecc.; e i valori estrinseci tra cui
27
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
22
frontato dal suo corso superiore (l’ac-
quisizione di un lessico economico
per i maturi del liceo classico, per es.).
Il metodo
Oltre al “cosa” è importante fare una
ricognizione sul “come”. L’univer-
sità richiede allo studente di appron-
tare delle strategie di studio comple-
tamente diverse da quelle della di-
dattica superiore. L’approccio ai
contenuti è spesso autonomo, viene
richiesta un’elaborazione personale,
Orientamento e scuola
Pier Paolo Pasolini,
Ritratto maschile,
matita su carta, 1943-1949