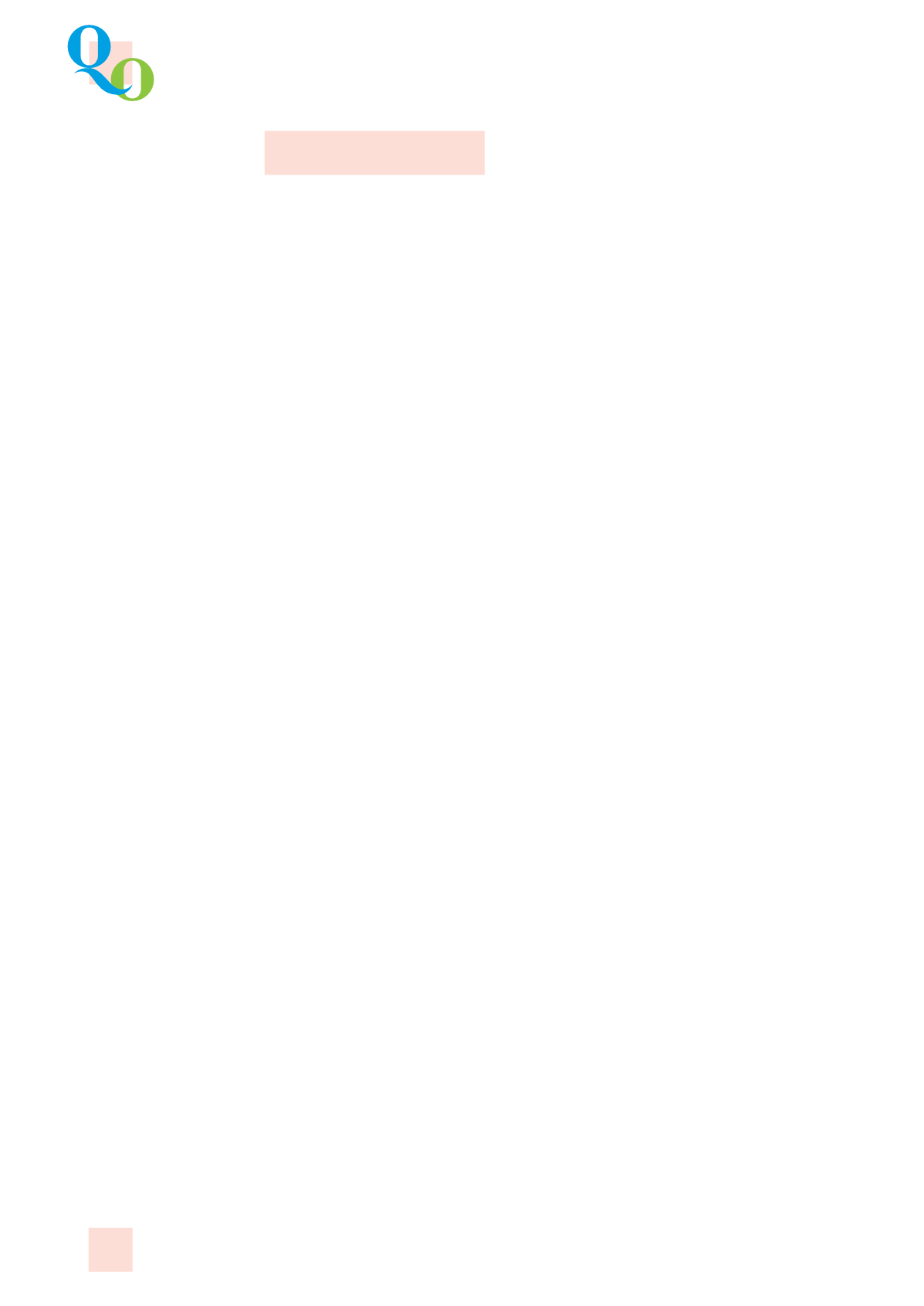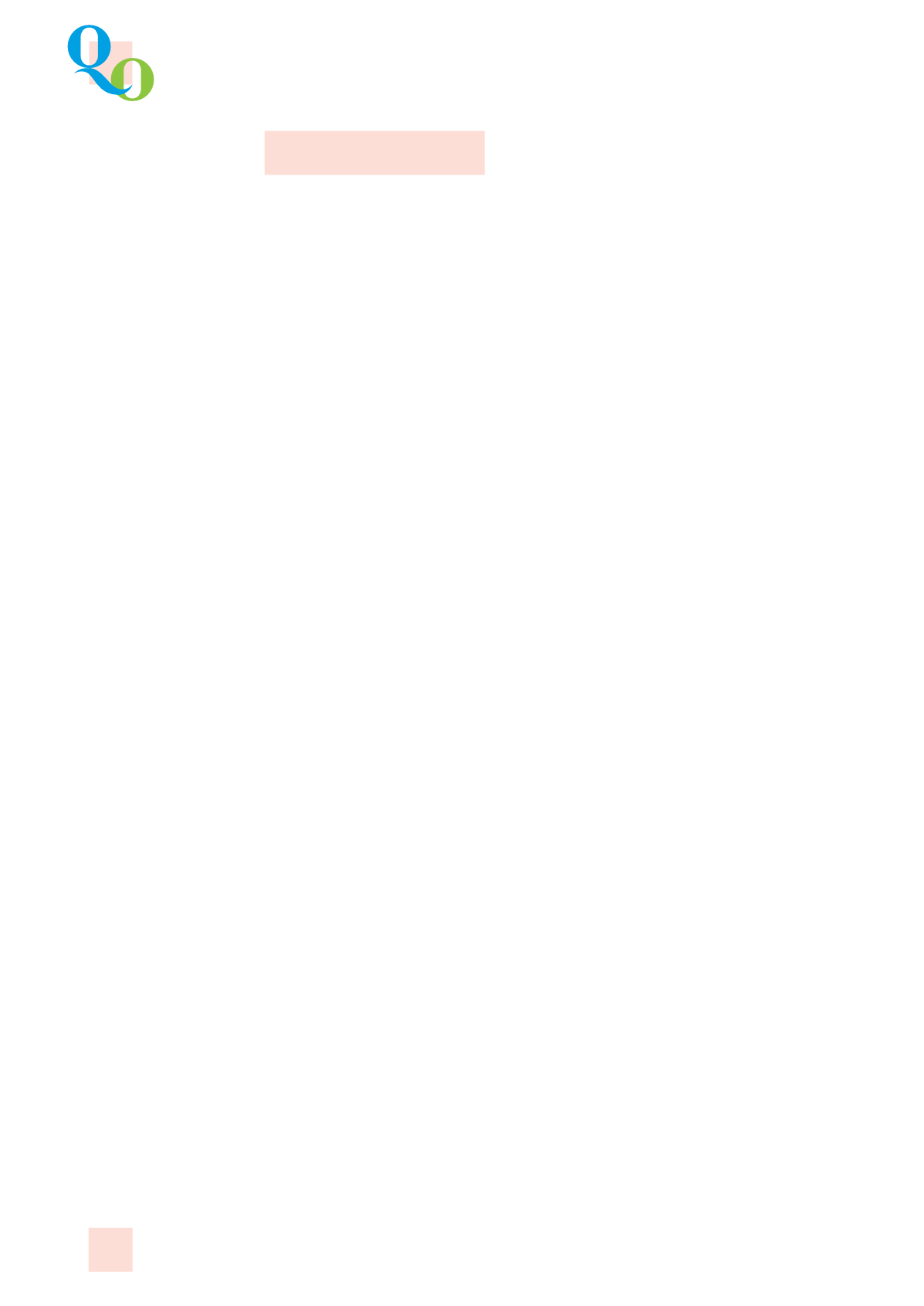
34
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
ORIENTAMENTO E SCUOLA
l’Altro mediante la scoperta del
Sé, abbia avuto un notevole suc-
cesso. In sintesi, il messaggio se-
condo cui si può essere uguali
solo attraverso la differenza sem-
bra essere stato percepito e regi-
strato dall’accresciuta importan-
za attribuita all’autoconsapevo-
lezza, assieme alle migliorate
competenze relazionali indicate
dagli intervistati nel questionario
post-intervento.
L’evidenza empirica di tali esiti
risulta confermata dalle doman-
de di controllo poste relativa-
mente ad atteggiamenti su cui
l’intervento non ha lavorato. Per
esempio la rabbia come reazione
disfunzionale. Gli atteggiamenti
relativi a questo comportamento
non sono infatti mutati prima e
dopo l’intervento. Proprio per-
ché non c’era nessun nesso logi-
camente causale che ne determi-
nasse il cambiamento. Per con-
cludere, i risultati indicano an-
che un incremento degli indici di
maturità, calcolati sulla base
della misurazione di una serie di
atteggiamenti dichiarati nei con-
fronti dei genitori e dei docenti.
L’indice di maturità pre-inter-
vento nei confronti dei genitori
era del 66.7%. Diventa del 70%.
Quello nei confronti dei docenti
dell’89,8%. Post-intervento di-
venta del 95%. In questo caso l’e-
videnza empirica non è comple-
ta. Altri fattori potrebbero influi-
re su questo aumento, comunque
non estremamente elevato, di
maturità (auto-dichiarato) nei
confronti di adulti significativi
quali i genitori e gli insegnanti.
Bisogna però notare che tra il
questionario pre e quello post-
intervento sono passati poco più
di due mesi. Il fattore tempo
potrebbe essere quindi conside-
rato gerarchicamente inferiore
rispetto all’impatto relativo gli
interventi svolti.
CONCLUSIONI
La ricerca-intervento svolta sem-
bra dimostrare, anche grazie al-
l’ausilio di dati raccolti ed elabo-
rati su base statistica, come esista
una complementarietà tra
proces-
so di individuazione
e
processo di
socializzazione
. Si è visto infatti
come lavorando sulle risorse
individuali (riconoscimento delle
proprie emozioni), non solo si sia
incrementato il potenziale di
auto-consapevolezza dei singoli,
ma siano anche aumentati i livel-
li di relazionalità, sia a livello
orizzontale che verticale. I risul-
tati ottenuti permettono perciò di
rivedere gli interventi scolastici
anche da un punto di vista ope-
rativo. Nel senso che si possono
utilmente connettere le socio-
terapie praticate per la preven-
zione e/o la cura del disagio con
gli interventi di mediazione cul-
turale. Questi due ambiti non
sono diversi, se l’obiettivo rima-
ne quello di favorire ‘sani’ e fun-
zionali processi di individuazio-
ne e socializzazione, in contesti
sempre più culturalmente diffe-
renziati.
■
NOTE
1) La parola Altro viene scritta in
maiuscolo in quanto tale termine è
inteso in senso simbolico ovvero
collegato all’immagine archetipa
dell’Altro.
2) I minori stranieri presenti in
Italia godono di tutele e attenzioni.
Normativa sul diritto all’inseri-
mento scolastico nelle scuole ordi-
narie e alla pari: art. 1 legge nr. 943
del 30/12/1986; circolare ministe-
riale nr. 301 dell’8/9/1989 e nr. 205
del 26/7/1990; circolare ministe-
riale nr. 205 del 1990 “La scuola
dell’obbligo e gli alunni stranieri,
educazione interculturale” e nr. 73
del 1994 “Dialogo interculturale e
convivenza democratica: l’impe-
gno progettuale della scuola”.
3) Viene riportato il termine “com-
prendere” così come proposto da
Todorov, tuttavia ritengo impro-
prio parlare di reale comprensione
semmai di conoscere strumentale.
Infatti, assumo che il termine com-
prensione includa in sé un qualche
livello di empatia (conoscenza ana-
logica che include un contatto e-
mozionale) che non può, per sua
natura, andare nel senso della di-
struzione; mentre invece un tipo di
analisi logico-strumentale, un sa-
pere che indica il miglior percorso
possibile per raggiungere uno sco-
po, senza aver nulla a che vedere
con il contatto con l’Altro, può con-
durre alla razionale distruzione
dell’Altro, inteso come nemico così
come avvenuto in Messico, ma
anche in tempi più recenti con
l’Olocausto (Bauman 1992).
4) In tale lista le emozioni sono
state ordinate per tipologie (es:
area rabbia, tristezza, gioia…) ed
intensità (es: l’area rabbia può ave-
re un’intensità alta: sentirsi furioso,
fuori di sé; media: essere adirato,
aggressivo; bassa: sentirsi infasti-
dito, indispettito).
5) Si vedano per esempio la ricerca
di Durkheim sul suicidio e quella
di Stouffler ed altri relativa all’A-
merican Soldier.
6) Gli altri 11 indici erano: relazio-
nalità (1); rispetto (2); autorità (3);
buona salute (4); capacità (5); affet-
■
26