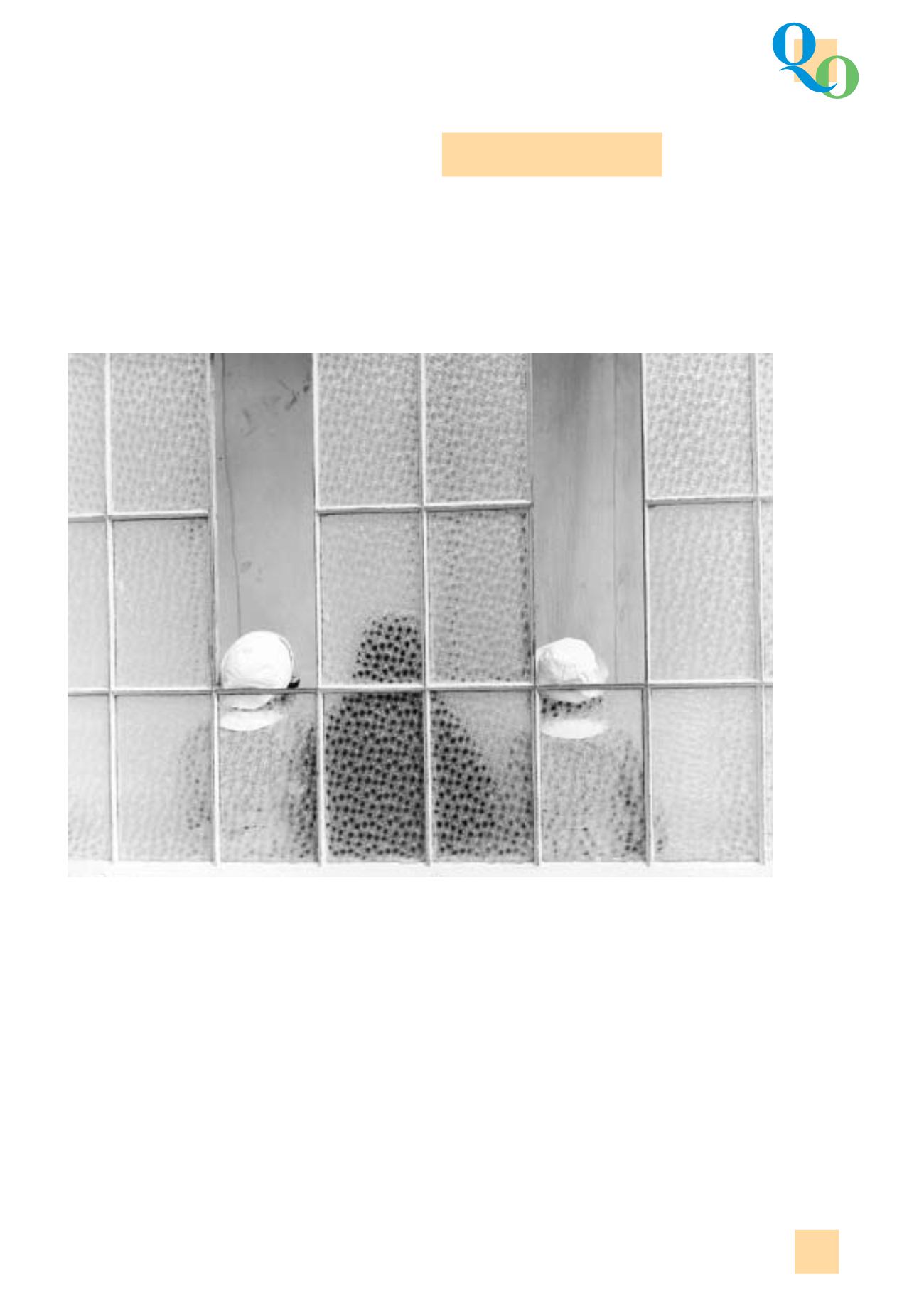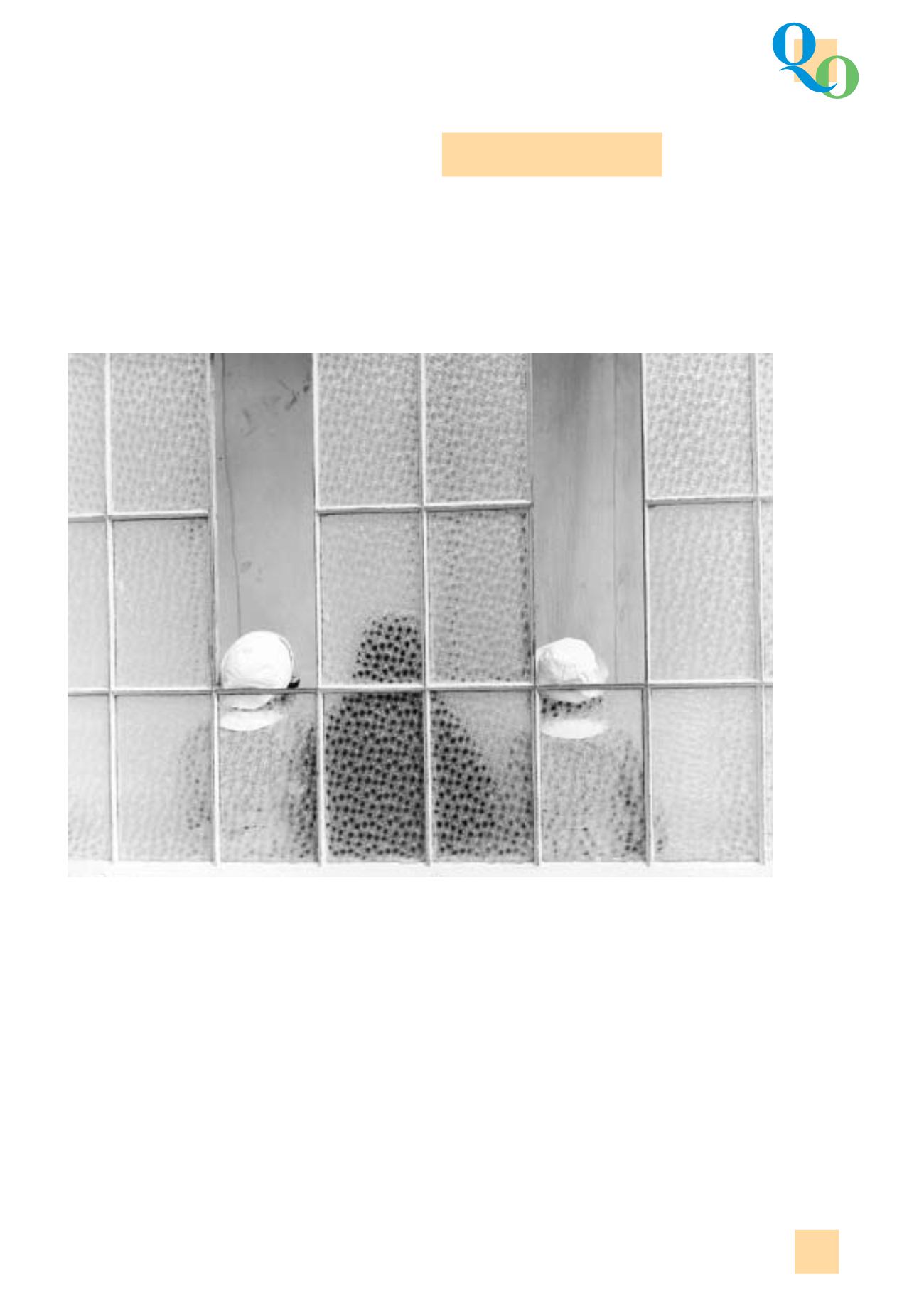
zionale e motivazionale. La passio-
ne, la curiosità, l’azione euristica
generano una tensione conoscitiva
che suscita risonanze metodologi-
che. Un allievo impara a gestire la
propria ricerca se la ricerca lo inte-
ressa. Tale competenza ha bisogno
di un lungo addestramento anche
se poi può essere generalizzata.
L’insegnante potrebbe suscitare
questa scintilla passionale e stimo-
lare l’esplorazione, l’interesse, la
curiosità, sollecitare la ricognizione
di un territorio ancora sconosciuto
e ricco di sorprese. Il problema del-
la metodologia dunque rimanda
anche all’insegnante. È un proble-
ma di interazione e non solo un
problema dell’allievo. O, forse, bi-
sogna superare la tradizione indivi-
dualista e approfondire la ricerca
nel versante relazionale. “
Per la tra-
dizione individualista esisteva una net-
ta divisione fra il ruolo dell’insegnante
e quello dello studente. Il primo doveva
fornire le migliori informazioni e capa-
cità d’osservazione disponibili, mentre
il lavoro del secondo era approfondire
queste informazioni. L’insuccesso dello
studente era convenzionalmente attri-
buito alla mancanza da parte dello stu-
dente stesso delle capacità, delle attitu-
dini e delle motivazioni. Nei decenni re-
centi siamo mano a mano giunti a com-
prendere che il lavoro effettivo dello
studente è il risultato di una collabora-
zione. Il fulcro centrale della collabora-
zione risiede certamente fra l’insegnan-
te e lo studente. Qui numeri crescenti
escono a dimostrare il punto di vista di
Lev Vygotsky secondo il quale non c’è
nulla nella mente che non sia prima
nella cultura, e il significato di una
stretta, sensibile e centrata relazione tra
insegnante e studente. Per molti ciò si-
gnifica una sofisticata forma di tiroci-
nio. Lo specialista della comunicazione
William Rawlins sostiene che l’istru-
11
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
24
Orientamento e scuola
Carlo Bevilacqua,
Attesa,
1964 ca.