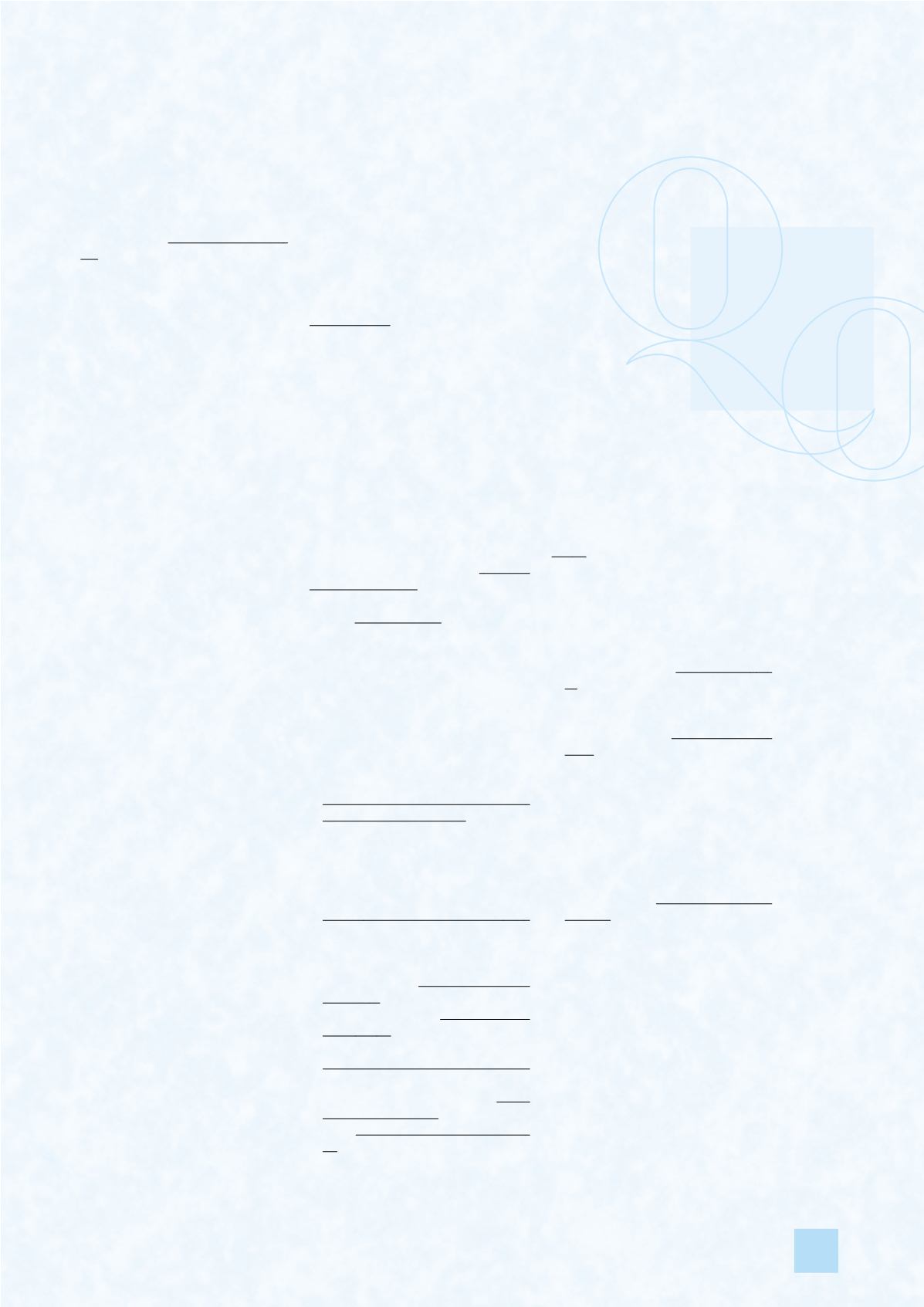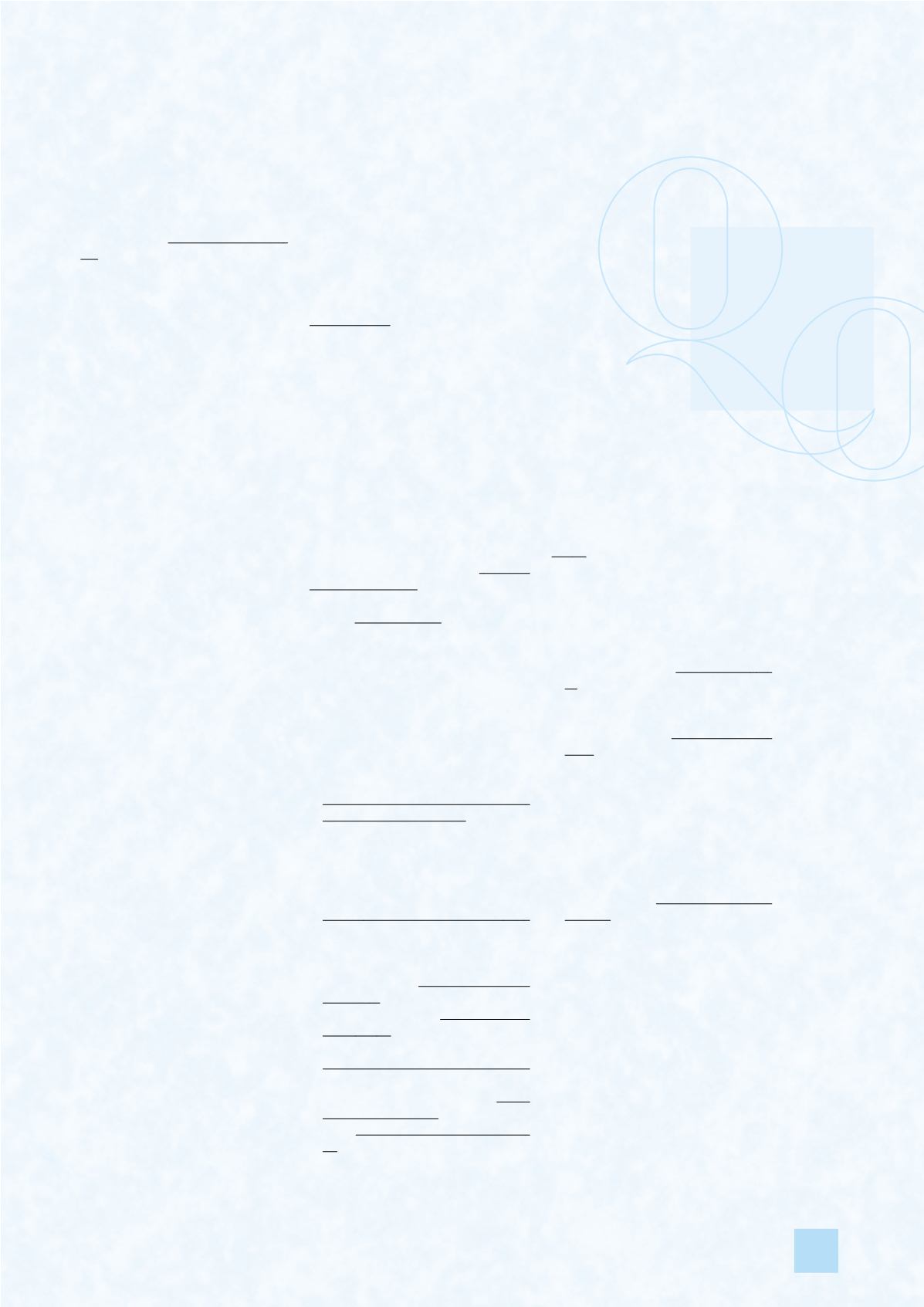
5
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
21
una larga fascia di clienti: per esem-
pio, buona parte di coloro che si ri-
volgono ai centri per l’impiego e
non sono in condizione di “sceglie-
re” o di elaborare un “progetto pro-
fessionale”;
• altre, infine, di consulenza alle scel-
te (meglio, alla messa a punto di
progetti formativi e lavorativi perso-
nalizzati); anche questo tipo di biso-
gno interessa diversi target (studenti
e giovani, adulti occupati e disoccu-
pati) ed è presente come azione in
diversi sistemi (gestita da risorse in-
terne o in integrazione con servizi
dedicati). Nel suo significato più
ampio la consulenza orientativa
,
sia
pure con delle differenze rispetto al
tipo di pratica assunta come riferi-
mento operativo (consulenza breve,
counseling orientativo, bilancio di
competenze), ha tentato fino ad og-
gi di dare una risposta a bisogni di
sviluppo dell’esperienza individua-
le; non a caso, si tratta di pratiche
che entrano in gioco o in momenti
di scelta (scolastico/professionale) o
in situazioni di cambiamento dell’e-
sperienza consolidata (perdita o
cambiamento del lavoro). Un ap-
proccio metodologico come quello
largamente utilizzato in queste prati-
che è da considerarsi ad alta specifi-
cità orientativa:
1. si basa principalmente sulla motiva-
zione della persona a gestire consa-
pevolmente il proprio processo di
orientamento,
2. richiede un soggetto in grado di in-
teragire attivamente con il professio-
nista che funziona da facilitatore
dello sviluppo delle sue competenze
orientative,
3. è finalizzato soprattutto alla dimen-
sione progettuale dell’esperienza
formativa e lavorativa.
Sul piano empirico ci possiamo trova-
re in presenza di una persona che pos-
siede già un’idea progettuale; il profes-
sionista con il suo intervento ne sostie-
ne soprattutto la praticabilità attraverso
un’azione cosiddetta di “consulenza
breve” sia individuale che di gruppo,
(Consolini M., Pombeni M.L., La con-
sulenza orientativa, Angeli, Milano,
2000). In altri casi possiamo essere di
fronte o ad una persona che non ha
ancora maturato un proprio progetto di
sviluppo oppure che si trova in una si-
tuazione di transizione particolarmen-
te complessa, ma in entrambi i casi è
disponibile/motivata a farsi carico atti-
vamente del suo problema; esempi di
pratiche in questa direzione possono
essere il “counseling orientativo”, so-
prattutto con studenti e giovani, (Gy-
sbers N.C., Heppner M.J., Johnston
J.A., Conseil et developpement de car-
riere tout au long de la vie, in L’orien-
tation scolaire et professionnelle, 1,
79-90, 2000) o il “bilancio di compe-
tenze” con i lavoratori adulti. (Ruffini
C., Sarchielli V., Il bilancio di compe-
tenze: nuovi sviluppi, Angeli, Milano,
2001).
A livello definitorio, va mantenuta
quindi l’unitarietà della categoria
orientamento come insieme che com-
prende sia azioni di aiuto alle scelte
(per giovani ed adulti) sia azioni di
supporto alle transizioni all’interno dei
percorsi formativi, nel passaggio dalla
formazione al lavoro e all’interno delle
esperienze lavorative (sul lavoro). Lo
sforzo dovrà essere quello di declinare
le diverse tipologie di azioni preceden-
temente evidenziate rispetto alla speci-
ficità dei singoli sistemi e ai bisogni dei
diversi target.
L’ampliarsi delle risorse (contesti / ser-
vizi / professionalità) in gioco su uno
stesso territorio pone due ulteriori pro-
blemi: da un lato, quello del raccordo
e/o coordinamento fra sistemi e azioni,
dall’altro quello della funzione dei co-
siddetti servizi dedicati. Se nel passato
queste strutture si sono caratterizzate
soprattutto per l’erogazione di servizi
direttamente rivolti agli utenti, è possi-
bile prevedere che oggi questa funzio-
ne, con il potenziamento di alcune
azioni orientative all’interno dei diver-
si sistemi, sia destinata progressiva-
mente a diminuire. Ora, il loro ruolo
potrebbe ulteriormente svilupparsi as-
sumendo anche funzioni di:
• promozione, coordinamento e svi-
luppo della rete locale attraverso
l’attivazione di dispositivi di raccor-
do ed integrazione fra i soggetti e le
strutture che, con competenze diver-
se, si occupano dei diversi destinata-
ri/clienti;
• elaborazione di proposte operative
e supporto alla sperimentazione di
interventi orientativi rispondenti alle
esigenze dei singoli sistemi; scambio
sistematico sull’analisi dei bisogni
orientativi del territorio e confronto
fra gli operatori sull’utilizzo di buo-
ne pratiche (valutazione di effica-
cia);
• supporto alle risorse professionali
della rete territoriale di orientamen-
to sia in termini di analisi dei fabbi-
sogni di formazione sia con funzio-
ne di accompagnamento/supervisio-
ne all’implementazione di attività
specifiche.
Un ultimo nodo critico concerne il te-
ma della professionalità degli operato-
ri, anche in questo caso il problema
esplode proprio in corrispondenza del-
le azioni rivolte agli adulti.
Lo sviluppo generalizzato dell’orienta-
mento ha fatto emergere in questi ulti-
mi anni due posizioni contrapposte: da
un lato, una chiusura su posizioni di-
fensive che mira a ridefinire le pratiche
di orientamento (e le professionalità
messe in campo) in termini riduttivi; il
tentativo è quello di circoscrivere il
campo di azione ad alcune pratiche
consolidate (il counselling orientativo,
il bilancio di competenze), definendo-
ne in modo preciso finalità, metodolo-
gie e destinatari; va di pari passo la
tendenza ad identificare delle compe-
tenze legate alle singole pratiche e tal-
volta addirittura dei profili professiona-
li specifici per ciascuna area di inter-
vento (lo psicologico scolastico, il con-
sigliere di bilancio, ecc.); dall’altro la-
to, una sovrapposizione aspecifica del-
l’orientamento ad azioni dalle finalità
molto diverse con una proliferazione
di figure professionali che svolgono
anche attività di orientamento.
Se prendiamo in considerazione le
esperienze maturate nei diversi conte-
sti, possiamo prefigurare che in futuro
l’orientamento venga realizzato attra-
verso un doppio contributo:
• da un lato, profili professionali che
hanno una mission specifica e diver-
sa dall’orientamento (formazione
della persona, preparazione al lavo-
ro, inserimento occupazionale) ma
che erogano una funzione concor-
rente all’attivazione di questo pro-
cesso; sono da considerarsi in que-
st’area tutte quelle attività finalizzate
a sviluppare condizioni e competen-
ze propedeutiche alla possibilità del
soggetto di gestire in modo autono-
mo ed efficace le situazioni di tran-
sizione legate ai propri percorsi for-
mativi e lavorativi;
• dall’altro lato, profili professionali
dedicati (non necessariamente un’u-
nica figura di orientatore) finalizzati
a supportare il processo di orienta-
mento nelle sue diverse modalità di
sviluppo, svolgendo sia attività che
accompagnano i percorsi della per-
sona in alcuni momenti di snodo
sviluppando nel soggetto competen-
ze di auto-monitoraggio della pro-
pria esperienza, sia attività consu-
lenziali di supporto alla presa di de-
cisioni e allo sviluppo di progetti for-
mativi e lavorativi personali.
Per concludere potremmo dire che:
• in questo momento lo scenario del-
l’orientamento in Italia, dopo un pe-
riodo spontaneistico, sta per affron-
tare una fase importante e molto de-
licata di razionalizzazione (finaliz-