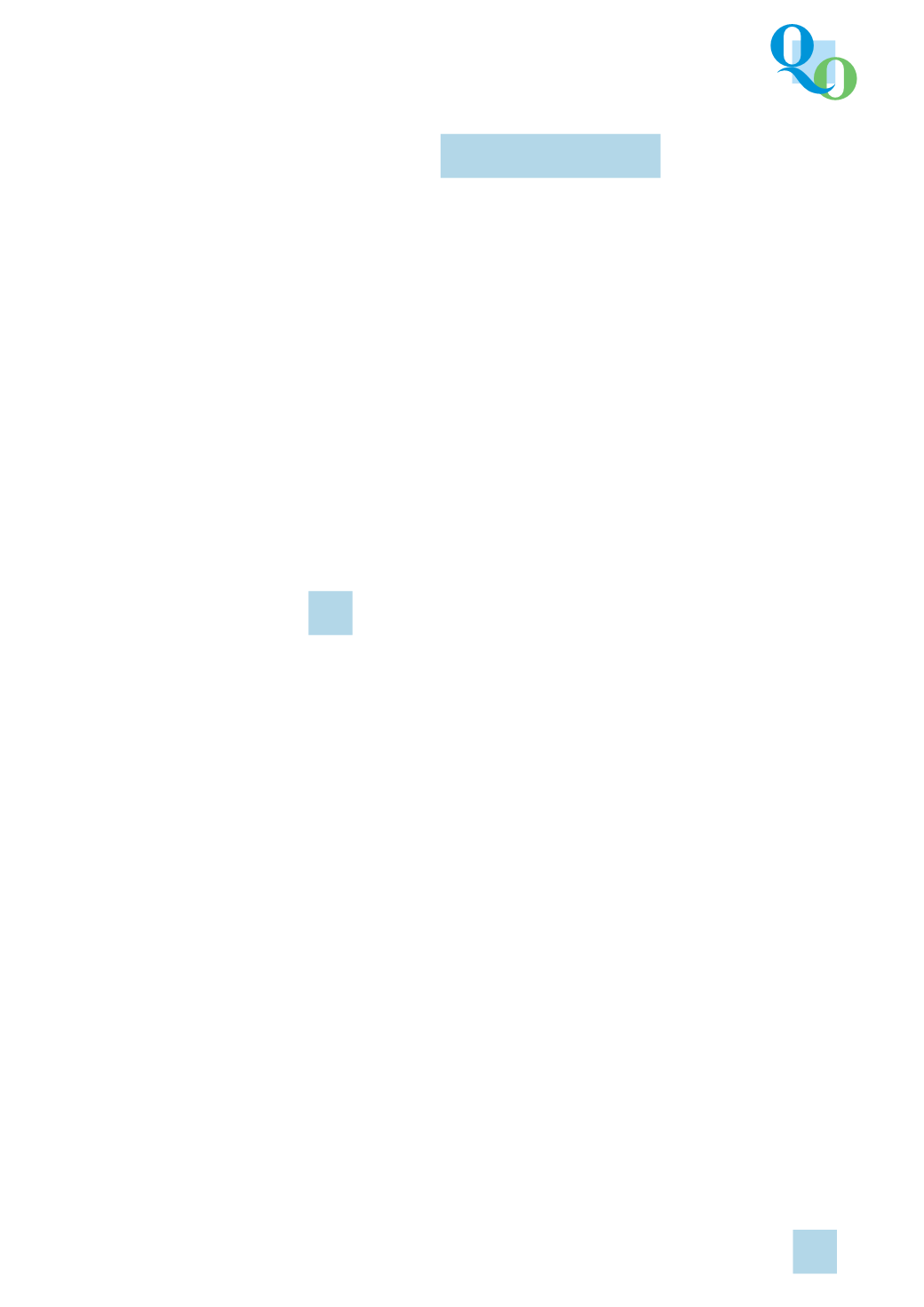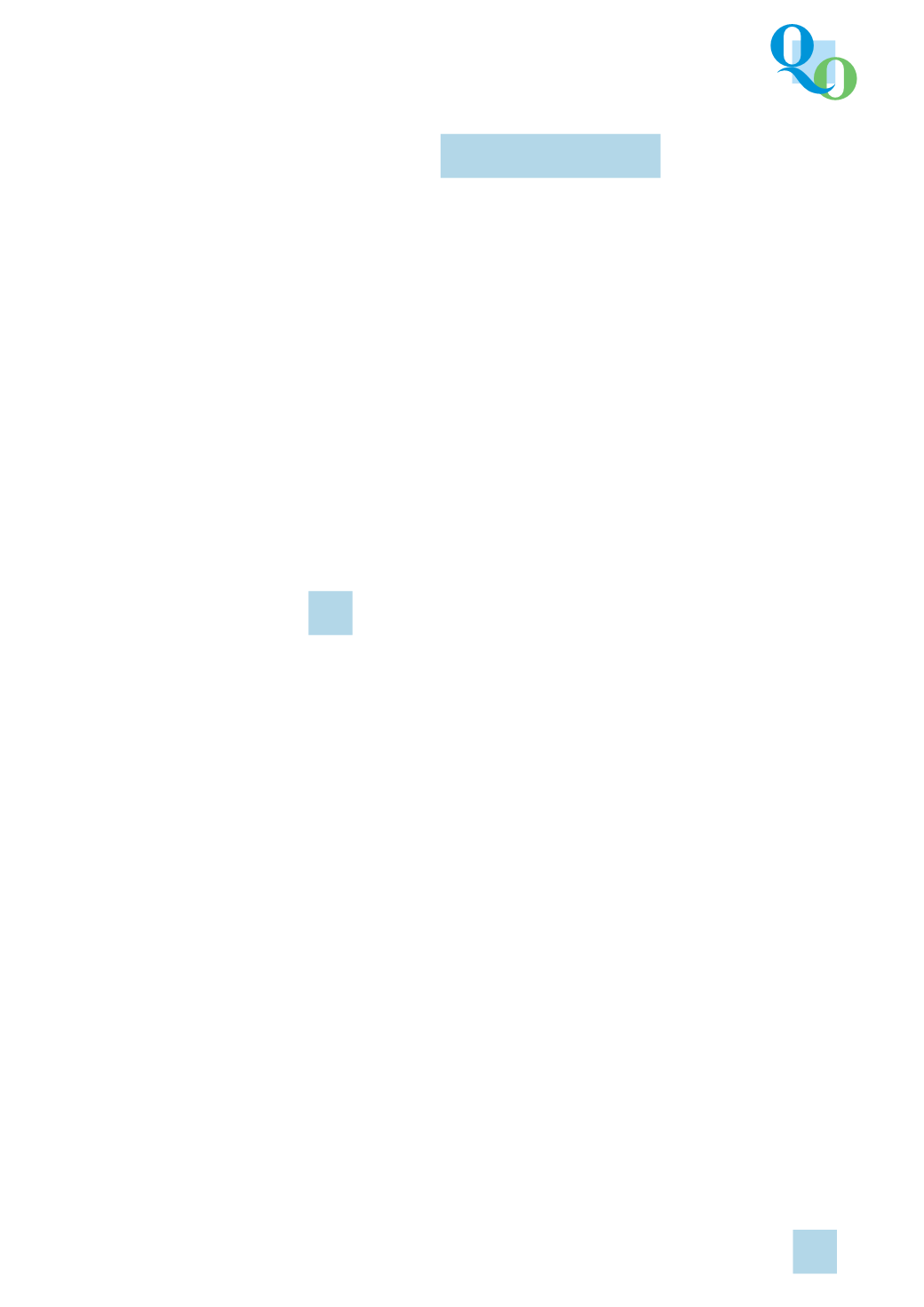
come il passaggio a nord-ovest di
M. Serres, che mette in comunica-
zione l’Atlantico con il Pacifico:
“Si apre, si chiude, si torce, attraver-
so l’immenso arcipelago artico fratta-
le, lungo un dedalo follemente com-
plicato di golfi e canali, di bacini e
stretti, tra il territorio di Baffin e la
terra di Banks. Distribuzione aleato-
ria e forti vincoli regolari, il disordine
e le leggi. Lo imboccate allo stretto di
Davis, finisce nel mare di Beaufort.
Da là, percorrete il nord dell’Alaska
verso le Aleutine. Liberazione, vi af-
facciate sul nome della pace”.
Il benessere nel percorso formati-
vo
è una scommessa
:
“gli itinerari la-
birintici che il viaggiatore è costretto
a percorrere stanno a indicare che il
passaggio stesso non è tracciato una
volta per tutte, che esso, appunto, si
apre e si chiude in una fluttuazione
imprevedibile, in una distribuzione di
probabilità … Dipende dallo stile del
tentativo la sua riuscita o il suo falli-
mento, così come lo stesso tentativo fa
parte della geografia mutevole del
percorso: è il viaggiatore che determi-
na il passaggio dal possibile al reale,
nell’uno o nell’altro senso; può aprire
uno spiraglio là dove l’icefield appare
impenetrabile, o chiudere, con la sua
presenza, un varco tra i ghiacci che
l’oscillazione aleatoria del caso ha
scoperto”.
“Per la natura stessa delle cose, un
esploratore non può mai sapere che co-
sa stia esplorando finché l’esplorazio-
ne non sia stata compiuta. Egli non ha
in tasca una guida che gli indichi le
chiese da visitare o gli alberghi dove
pernottare; ha solo l’ambigua tradizio-
ne di altri che l’hanno preceduto su
quella strada”.
12
Ma l’allievo non è un esploratore
solitario. Scopre e costruisce i suoi
saperi in ambienti di relazioni. Con-
divide, media e negozia la costru-
zione di nuovi significati. In questo
ambiente ogni studente, ogni do-
cente, ogni disciplina, tutto si in-
treccia in un benessere che è insie-
me di tutti e di ciascuno; dove cia-
scuno è portatore di una propria
specificità, di proprie aspettative, di
propri sistemi simbolici e rappre-
sentativi, di proprie visioni del
mondo, di proprie interpretazioni
proprio come ogni filo nella trama
di un tessuto.
NOTE
1) Ogni disciplina si presenta con
valenze metodologiche plurali, sia
nel suo farsi come disciplina acca-
demica, sia nel suo proporsi come
disciplina-insegnamento. La me-
diazione scientifica e culturale com-
porta la ricerca dei metodi e delle
tecniche che accomunano (o per lo
meno, avvicinano) i “modi” del-
l’apprendere dell’allievo con i “mo-
di” del sapere della disciplina.
2) “
Il metodo diventa veramente il pro-
cedimento che garantisce la razionalità
del lavoro didattico, ma non esaurisce
più il lavoro didattico. Esso è uno stru-
mento indispensabile ma non unico
della didattica; soprattutto non è elabo-
rato una volta per tutte, ma è soggetto
a variazioni, a cambiamenti, a trasfor-
mazione, in funzione della sua applica-
zione guidata dai principi della didatti-
ca come scienza.”
(T. Tomasi,
Il meto-
do nella storia dell’educazione
, Torino,
Loescher, 1985, p. 27)
3)
“Perché devo studiare ’sta roba?”
Una domanda di questo tipo (im-
plicita o esplicita che sia) deve sem-
pre essere risolta. Con gli adole-
scenti la soluzione non sta nell’of-
frire loro soluzioni preconfezionate,
né dettate dal dogmatismo pro-
grammatico (
“Sta scritto nei pro-
grammi …, Devi saperlo per l’esame
…”
), né dettate dalla nostra espe-
rienza e dal nostro buon senso (
“Ti
servirà quando dovrai imparare …, Io
l’ho trovato molto utile.
…). L’adole-
scente deve capire per accettare, de-
ve riconoscersi nell’idea del gruppo
(ricerca condivisa) e, in ultima
istanza, deve rispondere autonoma-
mente ai suoi “perché” con la rifles-
sione consapevole (
analisi metaco-
gnitiva
).
4) Il principio della continuità ri-
guarda la successione degli ap-
prendimenti, secondo il senso at-
tribuito dallo studente (e non
quello dell’insegnante) a tale suc-
cessione; il docente sa che cosa in-
segnare prima e che cosa insegna-
re dopo (
diacronia
), è l’allievo che
spesso non ne capisce il senso e
assimila la successione (nel mi-
gliore dei casi) come logica di cau-
sa-effetto. Più difficile, dal punto
di vista metodologico, è la gestio-
ne della
sincronia
: lo studente (co-
me ogni essere umano) vive la
propria vita secondo unitarietà di
senso (e “
i semi della conoscenza che
copiosamente versiamo
” cadono di
volta in volta in terreni molto di-
versi); è difficile (se non impossi-
bile) riuscire a governare le diver-
sità contingenti dell’adolescente;
possono invece essere governate
le dissonanze di senso che l’orga-
nizzazione scolastica provoca. Per
es.: le prime due ore sono di lette-
re (lezione e interrogazione di let-
teratura), la terza di fisica (labora-
torio); oppure, le prime due ore
sono di matematica (compito in
classe), la terza di storia: all’avvio
della terza ora quanto tempo ci
vuole agli studenti per abbando-
nare il “senso” delle prime due
ore ed entrare in quello dell’ora
successiva? Quanto influisce la
coesistenza di emozioni e processi
Orientamento e scuola
9
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
27