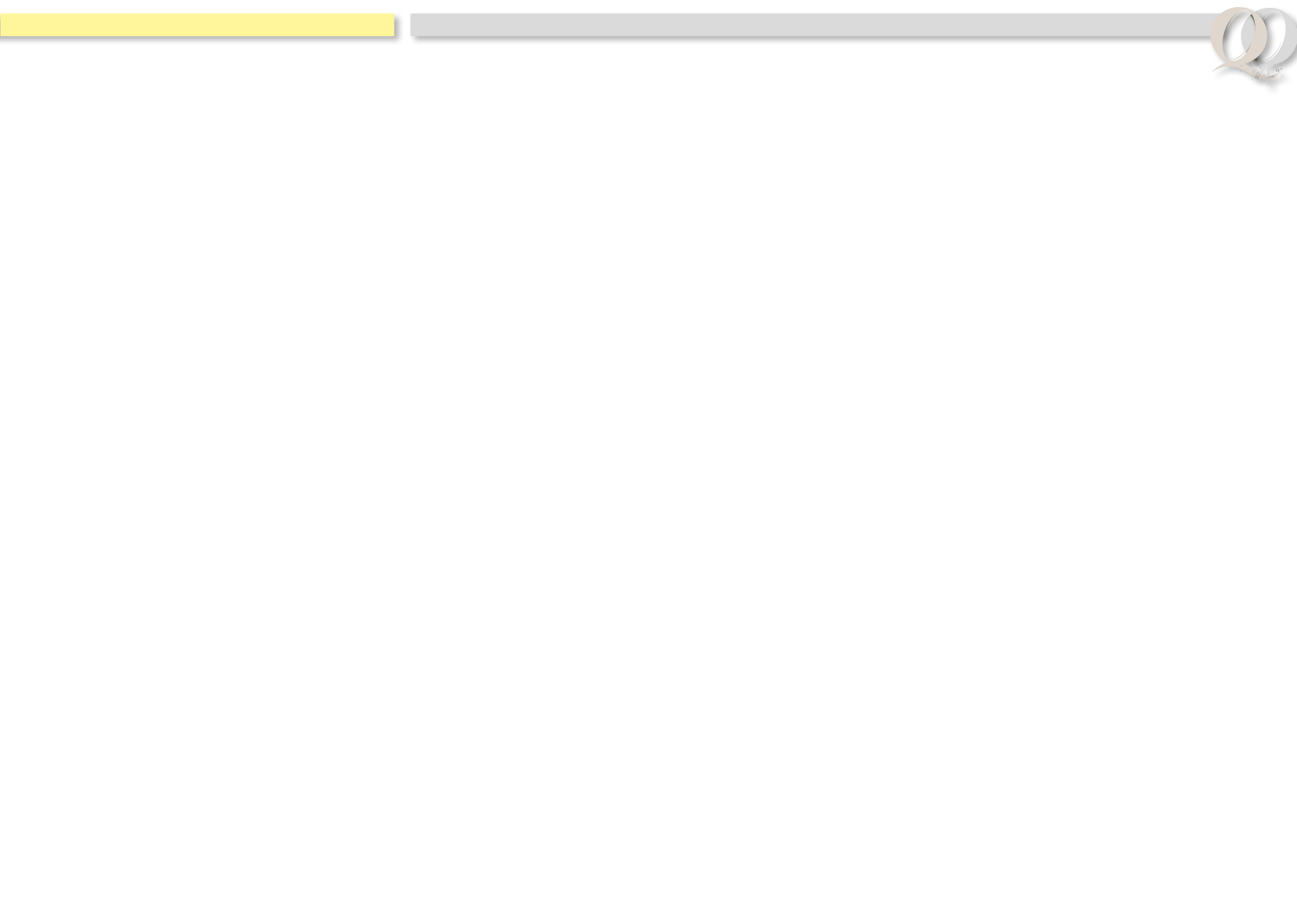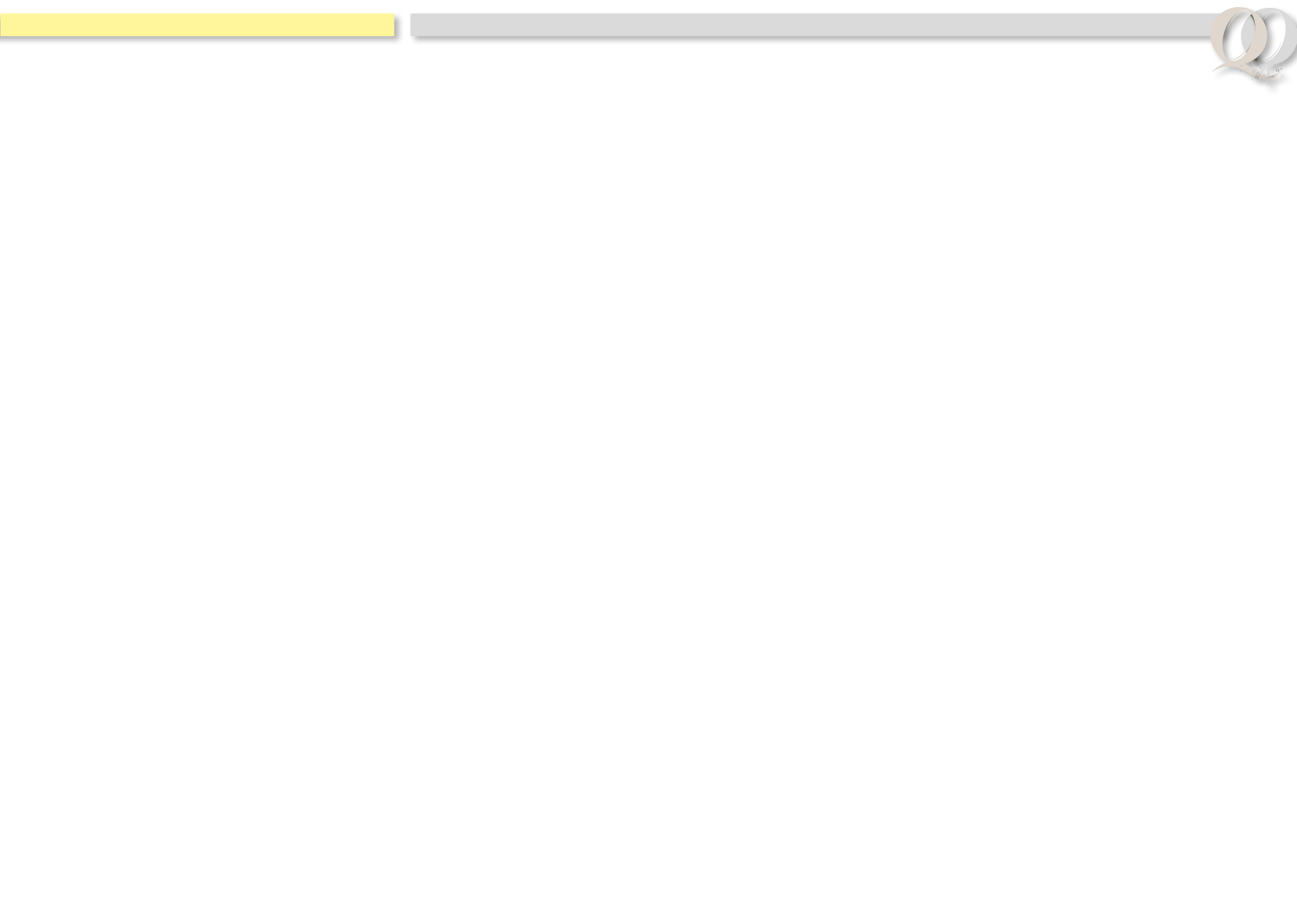
32
33
ORIENTAMENTO
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 49
L’ARTE DI CAMBIARE
L’APPRENDIMENTO
Insegnare tenendo a mente
il cervello dell’adolescente
Pamela Filiberto
Neuroscienze
cognitive e pratica
dell’insegnamento:
un binomio
possibile?
Uno dei primi ricercatori a stabilire
una connessione tra le funzioni del cer-
vello e le tradizionali pratiche educative
fu Leslie Hart nel 1983, nel suo libro
Human Brain and Human Learning.
1
Comprendere le modalità attraverso
cui il nostro cervello apprende e colle-
gare questa consapevolezza al campo
educativo è l’obiettivo del concetto
conosciuto oggi come
Brain-based Le-
arning
(BBL), apprendimento basato
sul cervello. Eric Jensen, uno dei padri
fondatori, definisce il BBL come
“un
apprendimento che entra in sintonia
con il modo in cui il cervello natural-
mente disegnatoper apprendere”
.
2
Pu
essere visto quindi come una qualsiasi
tecnica di insegnamento o strategia
educativa che sfrutta le informazioni
sul cervello per l’organizzazione delle
lezioni e che, utilizzando le ricerche
in ambito neurologico e nelle scienze
cognitive, diviene uno degli strumenti
usati dal docente per potenziare il suo
intervento in ambito educativo.
Negli anni ’90 il BBL ottiene un ampio
accordo tra studiosi di varie discipli-
ne, e le neuroscienze e l’educazione
sono definitivamente messe in colle-
gamento con la pubblicazione della
rivista scientifica di riferimento,
Mind,
Brain and Education,
la rivista ufficia-
le dell’International Mind, Brain, and
Education Society. La ricerca attuale in
questo ambito di studi si arricchisce del
lavoro combinato di neurologi, biolo-
gi, psicologi, educatori e medici. Tutti
professionisti il cui principale obiettivo
è quello di estrapolare i risultati delle
ricerche più recenti sul cervello e tro-
vare possibili ambiti applicativi nella
didattica.
3
Contemporaneamente, nell’am-
bito educativo cresce la necessità di
migliorarsi adottando nuove teorie e
approcci che permettano di superare
i limiti dell’insegnamento tradizionale
elevandone la qualità. Costruttivismo,
intelligenze multiple, apprendimen-
to attivo, classe capovolta, appren-
dimento basato sul porre questioni,
apprendimento
hands-on
, sono solo
alcuni dei nuovi approcci. In generale,
tutte queste proposte considerano il
discente come soggetto direttamen-
te responsabile del proprio appren-
dimento, protagonista di una scuola
interessata a entrare in contatto anche
con le sue esperienze, le sue emozio-
ni, i suoi valori, che sono la vera base
dell’imparare
4
.
Partendo dall’individuo, e dalla sua
“dotazione cognitiva”, si arriva a consi-
derare un approccio all’insegnamento
centrato sullo studente, che mira a
sfruttare le procedure attraverso cui
il cervello apprende naturalmente,
e che porta il nome di
Brain-based
Teaching Approach
(BBTA). Basato sui
principi del
Brain-based Learning
, è
un approccio olistico che, ad esem-
pio, ingloba al suo interno l’attenzio-
ne verso la componente emotiva, gli
ambienti arricchiti, il movimento, l’as-
senza di componenti stressogene,
5
al
fine di massimizzare la partecipazione
e il successo scolastico di studenti e
studentesse. Con la creazione delle
condizioni che permettono un effetti-
vo mutamento nel cervello, si compie
quello che James Zull considera esse-
re la pratica dell’insegnamento, ossia
“
l’arte di cambiare il cervello
”.
6
Cosa accade
in un cervello
che apprende.
Neuromiti che
circondano
il cervello e
l’apprendimento
Negli ultimi anni l’entusiasmo per la
ricerca sul cervello e le sue applicazio-
ni in ambito educativo cresce anche
tra i docenti. Tuttavia la mancanza di
conoscenze sufficienti e uno scambio
comunicativo non sempre efficace tra
educatori e scienziati, hanno portato
alla diffusione di numerosi “neuromiti”,
ossia errori di interpretazione o iper
semplificazioni di studi scientifici che,
pur contenendo un nocciolo di verità,
ormai rappresentano delle false cre-
denze sul cervello.
7
A contribuire alla proliferazione di
queste convinzioni, fin dagli anni ’90
e soprattutto in America e in Inghil-
terra, vi è l’incremento di una serie di
programmi educativi a supposta base
scientifica. Raccolti sotto l’etichetta più
generale di “Apprendimento Accelera-
to”, sono più che altro l’amalgama di
alcune ipotesi speculative in ambito
psicologico e neuroscientifico con una
serie di credenze popolari e di pratiche
derivate dall’esperienza in classe.
Per esempio, è comune enfatizzare
l’esistenza di una dominanza cerebrale
emisferica destra o sinistra per spiegare
le differenze tra gli individui. In realtà,
ad eccezione dei rari casi di cervelli
lesionati, esistono connessioni per-
manenti tra emisfero destro e sinistro,
grazie al passaggio di fibre nervose
attraverso il corpo calloso.
Di conseguenza, nessuna parte del
cervello è mai inattiva durante l’esecu-
zione di un compito e, a maggior ragio-
ne, in un’esperienza di apprendimento,
che per il suo livello di sofisticazione,
richiede che entrambi gli emisferi la-
vorino insieme parallelamente.
8
Le tecniche di “Apprendimento Ac-
celerato”coinvolgono anche tutto l’ap-
parato concettuale inerente gli Stili di
Apprendimento. Ecco cosa è succes-
so in questo caso: ricerche in ambito
psicologico rivelano come possano
esserci preferenze individuali verso
certi modi di apprendere. In campo
educativo, il concetto è stato tradotto
con la possibilità di poter “catalogare”
lo studente all’interno di tre tipologie
di stili di apprendimento (visivo, udi-
tivo, cinestesico). Questo ha portato a
ritenere che gli individui apprendano
meglio quando viene presentato loro
il materiale di studio nella modalità
sensoriale preferita.
Tuttavia, c’è una considerevole scar-
sità di ricerche che supportano il valore
dell’identificare stili di apprendimento
9
.
Uno studio recente verifica se lo stile di
apprendimento preferito correli con la
performance nel recupero dell’informa-
zione memorizzata. I risultati non rile-
vano nessuna correlazione
10
. Natural-
mente, esperimenti di questo tipo non
escludono la validità di un approccio
didattico che preveda la presentazione
dei materiali di studio usando formule
diverse e differenti strumenti.
L
e emozioni hanno un
ruolo preponderante nel
cervello di un adolescente,
che subisce un processo di
sviluppo massivo proprio
in questi anni. La ricerca
attuale si arricchisce
del lavoro combinato
di neurologi, biologi,
psicologi, educatori e
medici