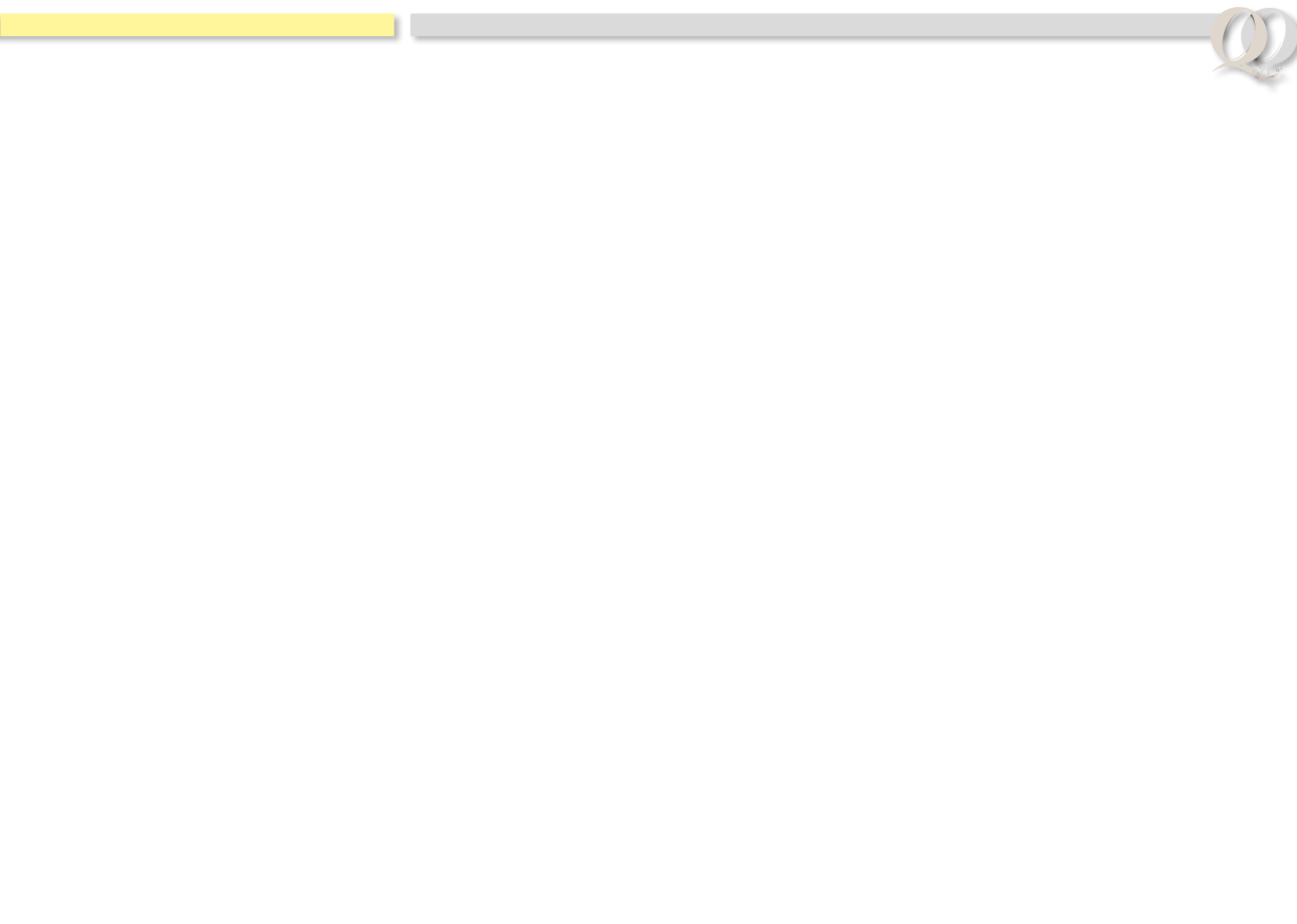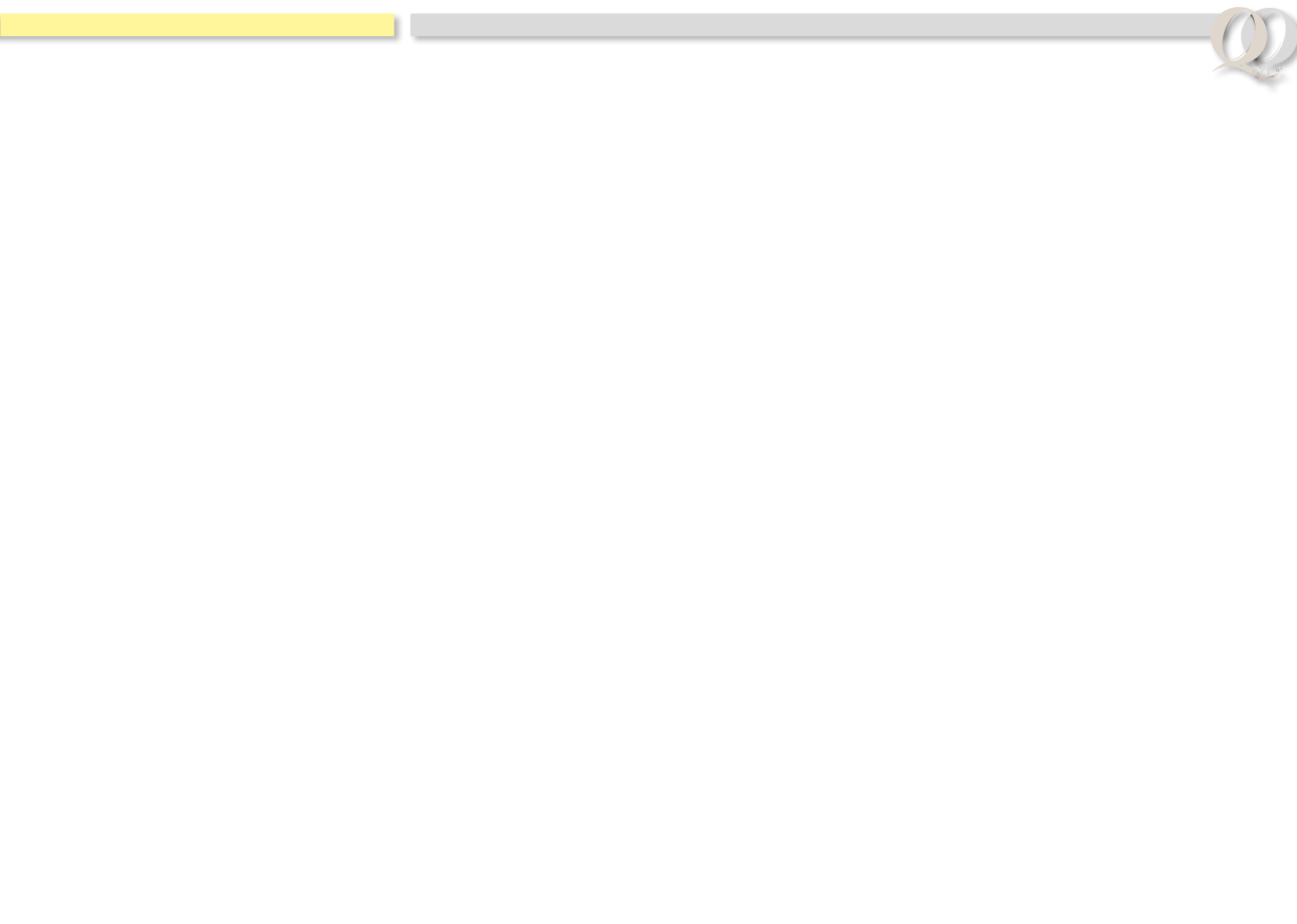
14
15
ORIENTAMENTO
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 49
pertanto, da questo punto di vista, pare
l’approccio adottato dal linguista cali-
forniano James Paul Gee.
A suo modo di vedere, infatti, il video-
gioco, come ogni altro (con)testo, con-
figura di fatto un “dominio semiotico”
(
semiotic domain
). Ovvero, un contesto
di segni e significati stratificato su tre
livelli costitutivi:
1. le
grammatiche interne
, che sono
le regole del gioco, senza le quali il
gioco stesso non potrebbe esistere;
2. le
grammatiche esterne
, che sono
l’insieme di contatti, scambi e rela-
zioni tra i fruitori del gioco stesso e
che contribuiscono a formare vere e
proprie comunità di interesse, i grup-
pi di affinità;
3. l’
identit del giocatore
che Gee ar-
ticola ulteriormente su tre livelli:
3.1) l’
identit reale
, ossia l’in-
dividuo che decide di giocare;
3.2) l’
identit virtuale
, ossia l’a-
vatar attraverso le cui caratteri-
stiche ci si avventura nel gioco;
3.3) l’
identit proiettiva
, ossia il modo
in cui l’identità reale interpreta l’esi-
stenza del proprio avatar.
Riconsiderare l’attività del videogio-
care all’interno di tale griglia concet-
tuale (qui schematicamente riassunta),
consente a Gee quanto meno di fare
intuire la complessità di interazioni e
relazioni che stanno alla base dell’espe-
rienza (video)ludica. E, al contempo,
lascia intendere quanto sia improprio
banalizzare tale stratificato dominio se-
miotico nella misurazione/valutazione
di una “evasione”, all’occorrenza utile
a motivare l’impegno didattico di un
qualche discente.
IMPARARE A
“LEGGERE” E A
“SCRIVERE” AL TEMPO
DI PIKACHU
Ma procediamo per gradi. Anzitutto,
spiega Gee nel suo “
Come un videogio-
co. Imparare e apprendere nella scuola
digitale”
(Raffaello Cortina, 2013), non
deve sorprendere il fatto di concepire il
videogioco come un dominio semiotico.
Dopotutto, “
il linguaggio non l’unico
importante sistema di comunicazione
di cui disponiamo: immagini, diagram-
mi, artefatti e molti altri testi visivi sono
dotati di significato, oggi più che mai
”. E
se questo è vero, non dovrebbe essere
difficile, secondo Gee, vedere nei video-
giochi, specie in quelli più sofisticati e
interattivi, “
la forma di alfabetizzazione
multimodale per eccellenza
”.
Ora, la consapevolezza che ogni video -
gioco rappresenti un microcosmo di
segni e significati entro cui il giocatore,
attraverso la sua identità virtuale, pro-
gressivamente si inserisce e interagisce,
consente allo studioso californiamo di
fare un passo ulteriore nella sua analisi.
Gli permette, infatti, di riflettere sul fatto
che non esiste un apprendere astratto,
disincarnato; ma solo situato, contestua-
lizzato. Ovvero, precipitato in (almeno)
un dominio semiotico. Pertanto, aggiun-
ge ancora Gee, “
se siamo preoccupati
di stabilire se un apprendimento sia di
valore oppure no - che si tratti di video-
giochi
o di qualsiasi altra cosa,
dobbia-
mo iniziare a farci domande del tipo:
che campo semiotico viene introdotto
attraverso questo apprendimento? È
un campo valutabile o no?
[...]
Chi ap-
prende sta imparando a comprendere
(“leggere”) le parti del campo o anche a
produrre (“scrivere”) significati all’interno
del campo?
”.
É proprio grazie a domande di que-
sto tipo che ci si pu rendere conto,
per esempio, di quanto sia complesso
individuare quale/i campo/i semiotico/i
entri/no
in gioco
mentre un individuo
(o un gruppo di individui) sta cercando
di apprendere qualche cosa in contesti
tanto formali quanto informali. Per citare
un’esperienza personale: capitano spes-
so in sede di esame studenti universi-
tari capaci di analizzare e commentare
con proprietà di linguaggio, poniamo,
l’imperativo categorico kantiano. Ma
che, alla prova dei fatti, non sanno dire
come agirebbe il filosofo di K nisberg
applicando in una precisa e concreta
situazione la sua celeberrima teoria. In
circostanze come queste Gee direbbe
che lo studente sa “leggere” ma non
sa “scrivere” dentro il dominio semio-
tico dato. In altri termini, è un “gioca-
tore dimezzato” in quanto si sarebbe
dimostrato “incapace” di fare un’attiva
esperienza del mondo avvalendosi degli
strumenti/ concetti conosciuti in quel
dato dominio semiotico.
Gee, addentrandosi ulteriormente
nel merito della questione, opportu-
namente prosegue con l’osservare che
un apprendimento attivo non è ancora
un apprendimento critico. Sarà magari
oggetto di una prossima pubblicazione
(magari in questa stessa sede) l’appro-
fondimento della sottile e cruciale que-
stione qui solo accennata; nel presente
testo, invece, l’obiettivo è piuttosto quel-
lo di fornire un qualche strumento di
analisi tale da consentire un approccio
più consapevole e informato alle “oasi”
del (video)gioco. Cercando al contempo
di invitare chi legge, proprio nel solco
tracciato da Eugen Fink, a riconosce-
re nei videogiochi, specie in un’epoca
pervasa e trasfigurata delle tecnologie
digitali, un dominio (semiotico) privi-
legiato per provare a
(ri)leggere
e a
(ri)
scrivere
la grammatica e la sintassi delle
nostre vite quotidiane.
Un esercizio, a ben vedere, non par-
ticolarmente diffuso. Come del resto si
pu constatare, per esempio, andando
a vedere quanto accaduto a seguito
della diffusione planetaria di
Pokémon
Go.
Oggetto di critiche e anatemi da
più parti, come sistematicamente acca-
de con la comparsa di qualsiasi novità
tecnologica, il gioco di Niantic ha inne-
scato riflessioni capaci di sottolineare,
nel bene e nel male, le potenzialità della
tecnologia di cui
Pokémon Go
è solo
una delle prime avanguardie
1
. Da più
parti si è gridato piuttosto alla perico-
losità del gioco, puntando l’indice con
supponenza e distacco contro le orde
di ragazzi (e non solo!) che hanno in-
vaso Central Park o Piazza del Popolo
per catturare Pikachu e le altre creature
fantastiche immaginate dalla Nintendo.
Dando conto di ingorghi o di inciden-
ti stradali provocati da giocatori scel-
lerati, per molti commentatori è stato
fin troppo facile e intuitivo individuare
nell’ultima frontiera del videogioco un
passo ulteriore e per alcuni decisivo,
verso una innaturale e alienante de-
materializzazione dell’esistenza. E non è
mancato addirittura chi, nella fattispecie
mons. Antonio Staglian , vescovo di
Noto, ha incaricato ben due avvocati per
valutare gli estremi di una denuncia dal
momento che, sostiene il presule,“
c’ in
campo la sicurezza sociale degli uomini
e delle donne da preservare
”.
Nello specifico, qualcuno potrebbe
avvisare Staglian che i suoi “colleghi”
Salesiani del Collegio Maria Ausiliatrice
di Bernal (Argentina), estensori di una
visione meno tecnofobica e apocalittica,
stanno per lanciare
Don Bosco Go
. In
occasione del 201° anniversario della
nascita del sacerdote educatore, infat-
ti, hanno inaugurato “
caccia a santi e
beati
” che impegna i ragazzi durante
le ore di svago
2
.
Ma il punto non è questo. Che si “va-
da a caccia” di santa Maria Ausiliatrice
o di Pikachu, ci che, di questo gioco,
meriterebbe più attenzione è il suo es-
sere il primo esperimento di massa di
realt aumentata
. Ovvero, di una nuova
ontologia con potenzialità di sviluppo
di cui, appunto,
Pokémon Go
(o, se si
vuole, anche
Don Bosco Go
) rappresenta
solo la punta dell’iceberg. Presto la re-
altà aumentata, e ben al di fuori della
dimensione prettamente ludica, sarà
esperienza diffusa e quotidiana.