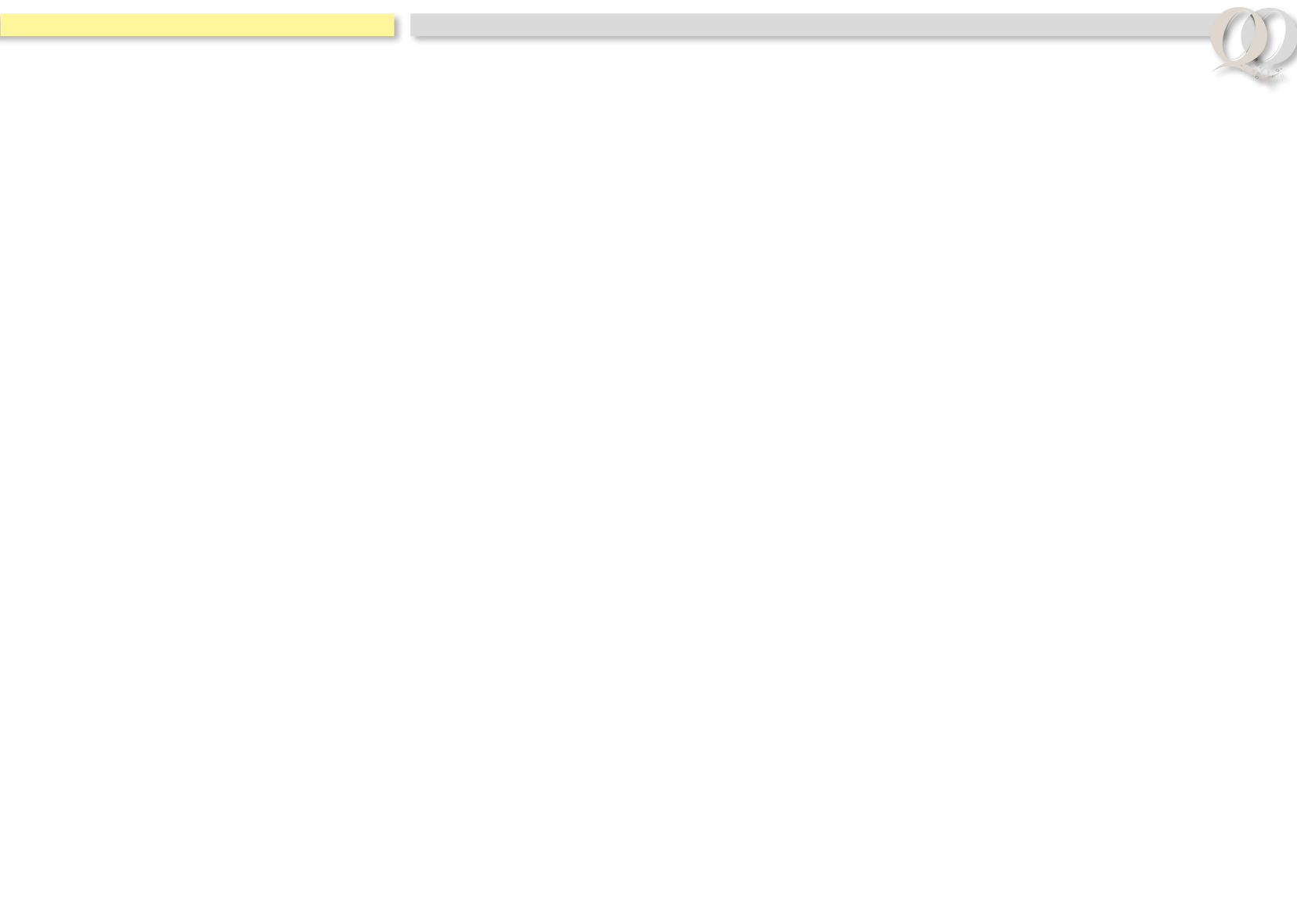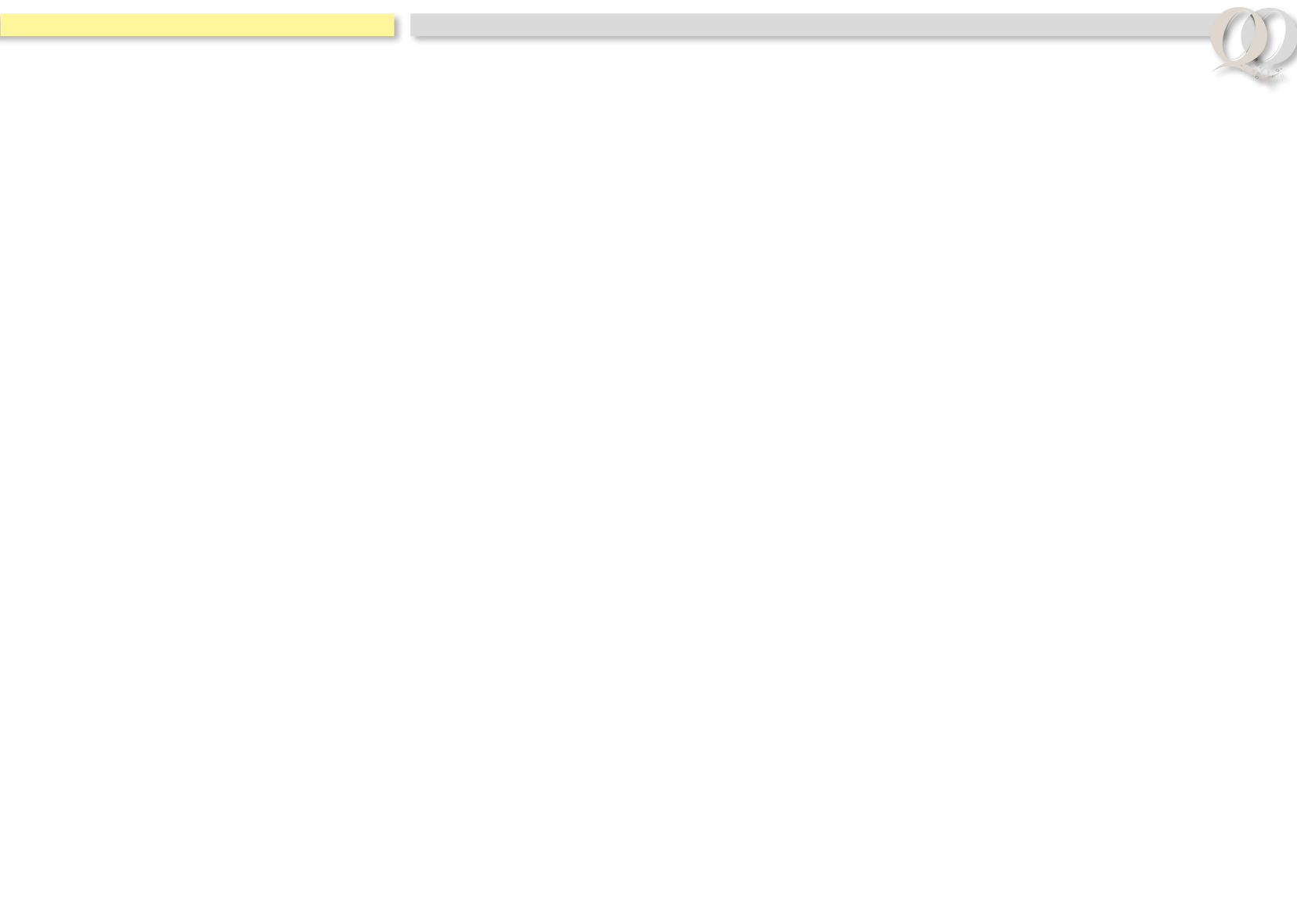
12
13
ORIENTAMENTO
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 49
I
Da Eugen Fink a
Pokémon Go
Perché il (video)
gioco non è solo un
divertimento
Stefano Moriggi
l gioco una pratica
tanto antica quanto
profonda che non pu
in alcun modo essere
ridotta al divertimento e
all’evasione che di volta
in volta consente
un“fenomeno
esistenziale
fondamentale”
“
In questo nostro secolo attraversa-
to dal fragore delle macchine, tra le
personalit eminenti della critica della
cultura, tra i pionieri della moderna pe-
dagogia, e tra gli scienziati delle dottrine
antropologiche, sta crescendo l’atten-
zione per la grande significativit che il
gioco riveste nello strutturarsi dell’espe-
rienza umana
”. Cos , nell’ormai lontano
1957, esordiva Eugen Fink (1905-1975)
in uno dei più originali saggi, “
Oasi del
gioco”
(Raffaello Cortina, 2008), dedica-
to all’esperienza ludica che la filosofia
novecentesca di lingua tedesca abbia
mai conosciuto.
Il brillante e originale allievo di
Edmund Husserl, il padre della feno-
menologia, era infatti persuaso che il
gioco fosse un argomento filosofico a
tutti gli effetti e che, pertanto, meritasse
l’attenzione e il rigore tradizionalmen-
te riservati ai più consueti temi della
speculazione teoretica e della ricerca
accademica. Riteneva inoltre che i tem-
pi fossero sufficientemente maturi per
avviare una radicale perlustrazione an-
tropologica di una dimensione umana,
quella ludica, appunto, tanto complessa
e articolata quanto ancora sottovalutata
e trascurata. Una dimensione che, a suo
modo di vedere, avrebbe contribuito
non poco a far luce su tattiche di vita e
strategie di azione tipicamente umane
di fatto eccedenti la specifica pratica di
questo o quel gioco, ma difficilmente
comprensibili se non ricondotte al gioco
come loro costitutiva matrice culturale.
Fink riteneva che la (
sua
) moderni-
tà fosse un momento propizio e op-
portuno per addentrarsi in tali temi e
questioni. Se infatti, notava il filosofo,
“
nella storia dell’uomo vi furono tempi
che vennero vissuti nel segno del gio-
co più del nostro presente, tempi che
furono più sereni, più liberi e giocosi,
che conobbero maggior tempo libero
e furono in intima comunione con le
celesti Muse
”; d’altra parte, per , “
nes-
suna epoca ha avuto oggettivamente
così tante possibilit e occasioni di gioco
quanto la nostra, poiché nessuna ebbe
a disposizione una così gigantesca or-
ganizzazione della vita
”.
Cogliere la natura del gioco e, attra-
verso di essa, mettere meglio a fuoco al-
cuni tratti dell’essere umano richiedeva
pertanto una comprensione che si spin-
gesse ben al di là della sua dimensione
prettamente ludica. E non a caso, pur
seguendo con grande interesse, e non
senza un qualche sospetto, il crescente
“
proliferare di campi da gioco, di centri
sportivi, la crescita della produzione di
vari tipi giochi su scala industriale
”, il
filosofo di Costanza nel suo breve sag-
gio non trascurava di evidenziare come
una emergenza di contesti e strumen-
ti ludico-ricreativi non corrispondesse
affatto a una effettiva “
comprensione
approfondita dell’essenza del gioco
”.
Il commento di questi brevi ma signi-
ficativi brani rende già piuttosto chiaro il
messaggio di Fink: il gioco è una pratica
tanto antica quanto profonda che non
pu in alcun modo essere ridotta al di-
vertimento e all’evasione che di volta in
volta consente. Limitarsi ad analizzarlo
avvalendosi di questi ultimi parametri,
più che un errore pare un tentativo di
rimozione della sfida che attende chiun-
que decida, appunto, di considerare il
gioco cos come merita.
Ancora Fink: “
È concepito come ci
che non serio, ci che non normativo,
ci che non autentico... una manife-
stazione marginale, una compensazio-
ne periferica, per così dire un’aggiunta
che d sapore alla pietanza pesante
del nostro essere
”. Eppure, ribadiva con
convinzione,“
appartiene essenzialmente
alla costituzione dell’esistenza umana
”.
A poco più di cinquant’anni di distan-
za, questo saggio di Fink meriterebbe
un’attenzione che, purtroppo, non ha,
se non tra gli “addetti ai lavori”. In un
tempo in cui l’industria del gioco sta
conoscendo orizzonti ed evoluzioni
inimmaginabili negli anni Cinquanta
del secolo scorso, sarebbe più che mai
opportuno raccogliere il testimone della
sua riflessione, proseguendo con rigore
e determinazione l’indagine che il filo-
sofo tedesco auspicava.
Come noto, l’evoluzione della tecno-
logia ha reso disponibile il rapido suc-
cedersi di generazioni di videogiochi
che hanno pesantemente contribuito
a riplasmare l’immaginario dei più gio-
vani. Tuttavia, ancora troppo spesso ci
si ferma alla superficie della discussione,
cercando, quando va bene, un qualche
“equilibrio virtuoso” tra la piacevolezza
e i rischi delle inedite “evasioni” (più o
meno virtuali, più o meno interattive)
che tali strumenti (o contesti) ludici
consentono.
Certo non è mancato chi, per esem-
pio, ha ritenuto l’approccio ludico, e
in particolare l’utilizzo di veri e propri
videogiochi, funzionale a inaugurare
un nuovo orizzonte per la didattica. Nel
merito, si dovrebbe parlare più preci-
samente di tecnologie educative: un
campo ampio e sfaccettato, ma sin-
tetizzabile in due principali scuole di
pensiero. Da un lato, c’è chi ritiene che
l’attività del videogiocare faccia bene
in sé, in quanto produce apprendimen-
to e contribuisce a sviluppare abilità
e attitudini preziose anche in contesti
ben diversi e lontani da quelli specifici
del (video)gioco. È questa la “filosofia”
dell’
edutainment
. Sull’altro fronte, in-
vece, c’è chi nel (video)gioco cerca una
credibile simulazione della realtà, quale
occasione e momento piacevolmente
formativo. Costoro sono i sostenitori dei
serious games
.
Come di recente ha sottolineato Pier
Cesare Rivoltella, docente di Tecnologie
dell’istruzione e dell’apprendimento
presso l’Università Cattolica di Milano,
“
nessuna delle due ipotesi convincente.
Non lo la prima
”, spiega il pedagogista,
“
perché non esiste apprendimento che
non comporti fatica
”. E non lo è neppure
la seconda in quanto, “
gi nella forma
lessicale
[
giochi
seri
]
lascia presagire
una scarsa disponibilit dell’utente
(il
bambino, il ragazzo)
ad accettarne le
regole di ingaggio
”.
Ciascuno a suo modo, infatti, i soste-
nitori dell’
edutainment
e dei
serious
games
, convengono nella necessità di
ricorrere al (video)gioco come allegge-
rimento, edulcorazione dell’esperienza
di apprendimento. Ma questo, prima
ancora che fraintendere, come puntua-
lizzava Rivoltella, la natura stessa dell’ac-
quisizione del sapere, non coglie, per
dirla ancora con Fink, la centralità e la
pregnanza dell’esperienza-gioco quale
“
fenomeno esistenziale fondamentale
”,
anche nel più ristretto contesto dell’ap-
prendimento. Molto più interessante,