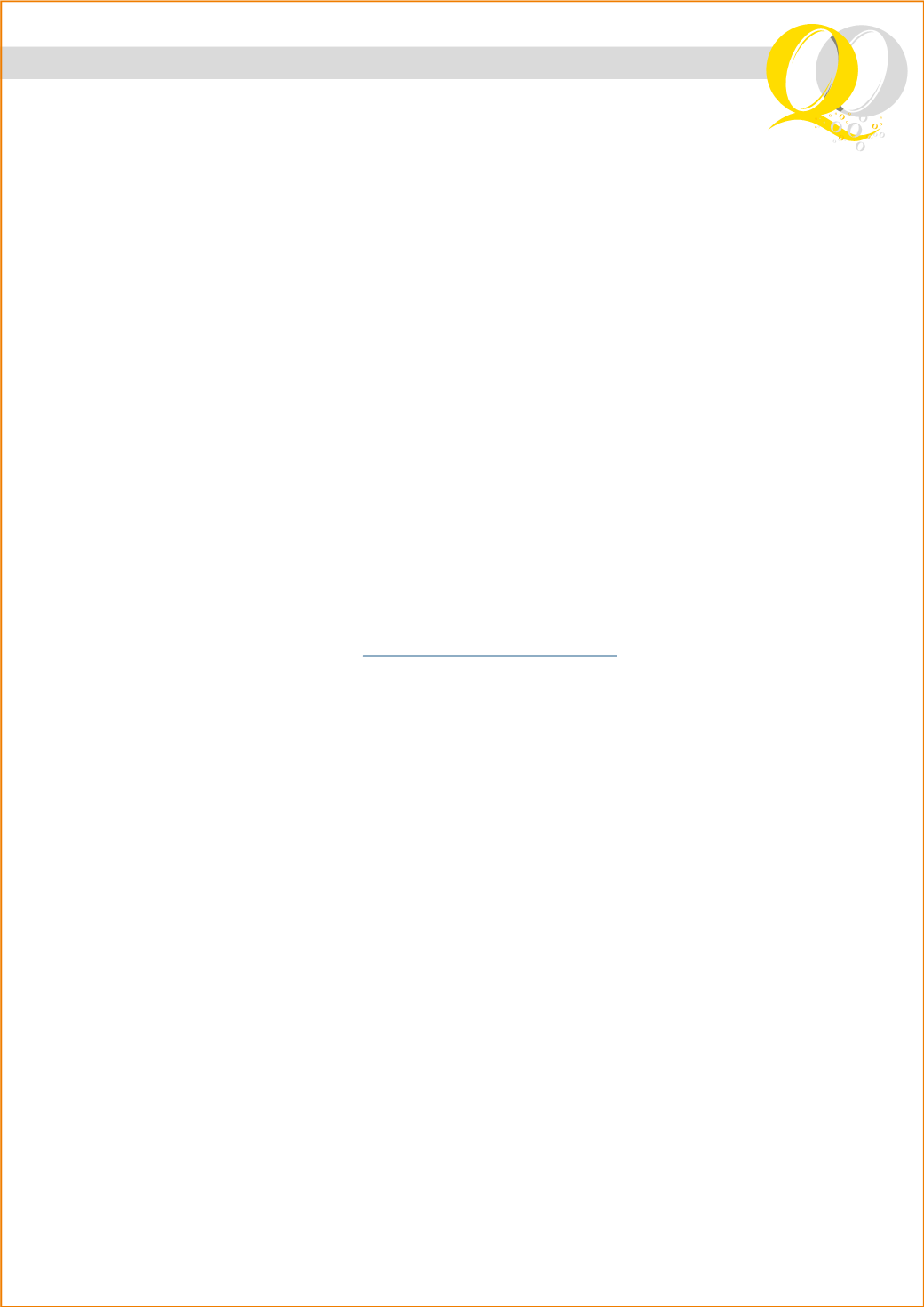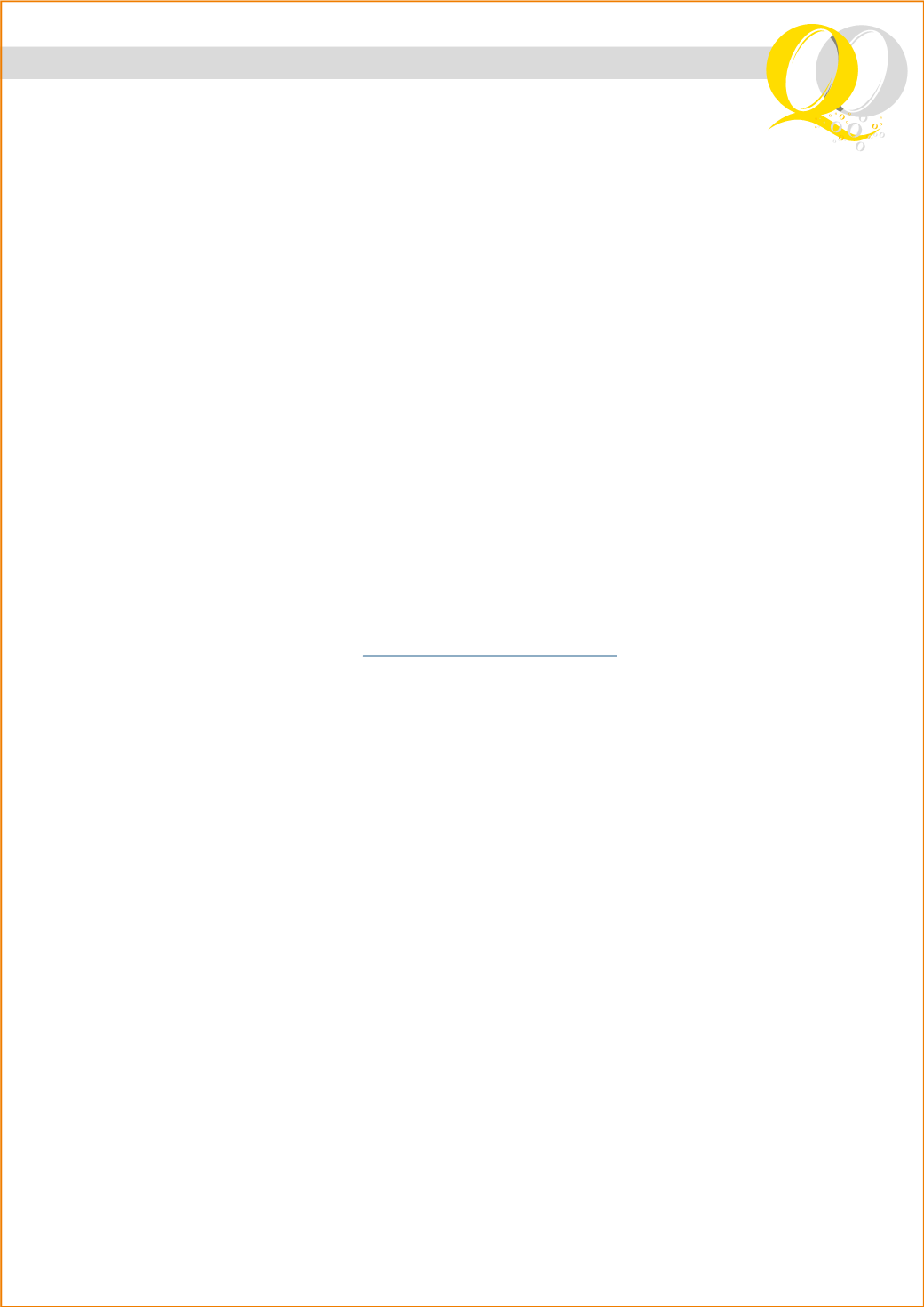
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO
39
Allo stesso modo, tutti gli appeti-
ti, gli apprendimenti e le memo-
rie delle ricompense tracciano un
orizzonte privilegiato di finalità e di
comportamenti. E se un tipo di ap-
prendimento o una forma di com-
portamento appreso e strumentale
al piacere diventano disfunzionali
per un individuo è questione che ri-
guarda non soltanto il suo cervello,
ma anche la sua situazione materia-
le, la possibilità di soddisfare i suoi
appetiti, le sue esperienze pregres-
se, le sue relazioni, le sue condizioni
economiche, l’ambiente in cui vive,
il valore che la società riconosce al
tipo di apprendimento e alla forma
del piacere che persegue. Definire
additivo un comportamento o un
piacere può infatti significare: 1) va-
lutare che quel comportamento o
quel piacere hanno un peso ecces-
sivo in un periodo della vita di un
individuo; 2) giudicare che quel tipo
di comportamento o quel piacere è
moralmente inaccettabile (Foddy e
Savulescu, 2007). In entrambi i casi
abbiamo a che fare non soltanto
con processi e fenomeni occorrenti
nel cervello o nel corpo di un indivi-
duo ma anche con norme morali e
dinamiche sociali.
La dipendenza, come ogni altro
apprendimento e abitudine, dipen-
de da una modulazione circolare e
integrata a più livelli, dal piano mo-
lecolare alle rappresentazioni socia-
li. Una modulazione circolare che
spiega la variabilità e la complessità
delle manifestazioni comportamen-
tali della dipendenza, il loro caratte-
re individuale, la loro connessione
causale con la farmacologia delle
sostanze ma anche la loro aper-
tura all’esperienza, alla storia, alla
volontà e ai valori degli individui.
Oggi alcuni sviluppi della genetica
e della genomica funzionale sem-
brano prefigurare l’incorporazione
nel concetto biomedico di questa
natura complessa, plurifattoriale
e multidimensionale della dipen-
denza. Forse non è tanto lontano il
momento in cui sarà possibile fare
ciò che l’analisi critica del concetto
biomedico di dipendenza dimostra:
dar conto in termini genuinamente
biologici dei determinismi neuro-
farmacologici e della dimensione
morale e psicosociale dei compor-
tamenti d’abuso. Anche perché
questa dimensione sovrabiologica
comunque contribuisce a distillare
il bagno chimico entro cui funziona-
no i neuroni e a plasmarne così i cir-
cuiti che mediano i comportamenti
sani o patologici.
Stefano Canali
Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati SISSA
Trieste
BIBLIOGRAFIA
Akiskal H.S.,
Toward a definition of
generalized anxiety disorder as an
anxious temperament type
, Acta
Psychiatr Scand Suppl.; 393:66-73,
1998.
Bennett M.R., Hacker P.M.S.,
Philosophical foundations of
neuroscience
, Blackwell publishing,
Oxford, 2003.
Blum K., Sheridan P.J., Wood R.C.,
Braverman E.R., Chen T.J., Cull J.G.,
Comings D.E
.,
The D2 dopamine
receptor gene as a determinant of
reward deficiency syndrome
. J R Soc
Med. 89(7):396-400, 1996.
Blum K., Braverman E.R., Cull J.G.,
Comings D.E
.,
Reward deficiency
syndrome
. Am. Sci., 84:223-228,
1996a.
Boorse C.,
On the distinction between
disease and illness
. Philosophy and
Public Affairs, 5, 49–68, 1975.
Boorse C.,
What a theory of mental
health should be
. Journal of Social
Behaviour, 6, 61–84, 1976a.
77