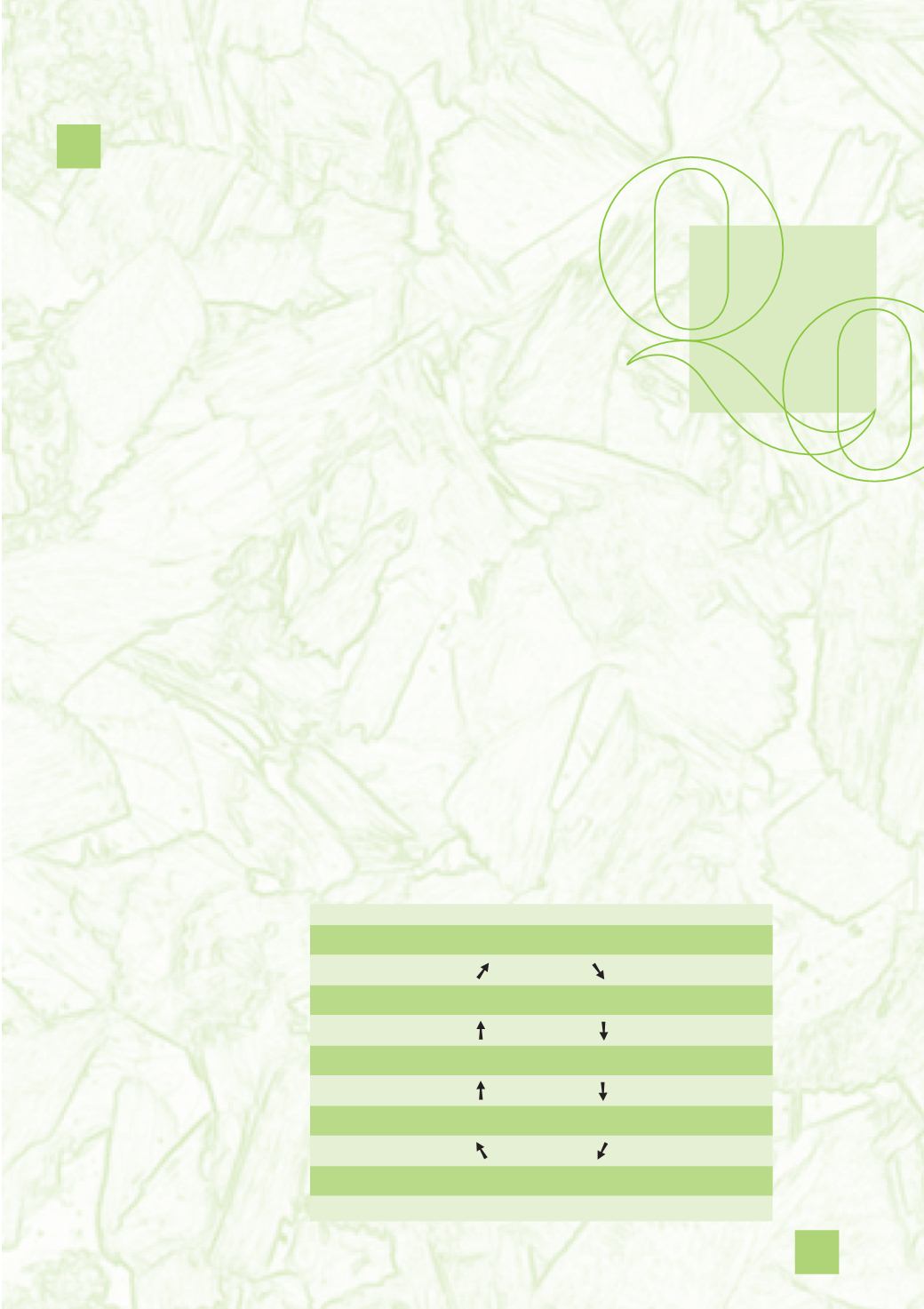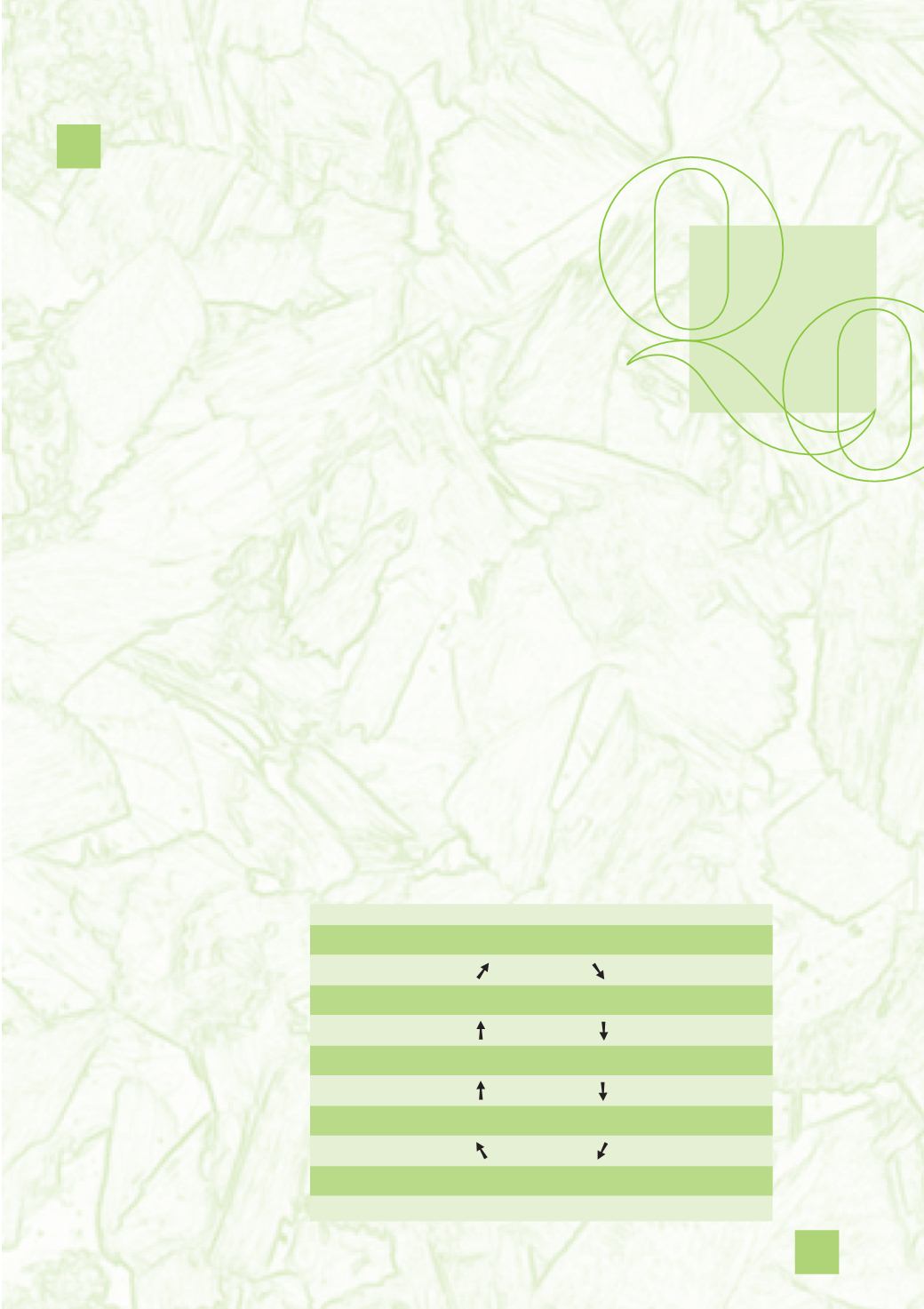
7
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
23
è soltanto la conseguenza della per-
cezione della situazione vissuta
dall’assistito, è possibile influire sul
rifiuto soltanto modificando il con-
testo referenziale che condiziona le
sue reazioni emotive.
In materia di emozioni ci imbattia-
mo spesso, sia tra gli esperti che tra
le persone comuni, in pregiudizi,
teorie, miti e interpretazioni distorte
di ciò che dovrebbero essere le rea-
zioni emotive, la loro funzione
adattiva, il loro manifestarsi, la loro
struttura e intensità, la loro influen-
za sul rifiuto, sull’adattamento e sul-
l’indecisione, nonché su ciò che
nella sfera delle emozioni va ritenu-
to normale o alterato. Molte perso-
ne ritengono di essere “assennate”,
quando reagiscono in maniera ra-
zionale, mentre tutto ciò che è emo-
tivo rientra a loro avviso nella sfera
dell’“irrazionale”, dell’insensato e
del non dignitoso. Anche nelle no-
stre scuole si stanno ingrossando le
fila dei sostenitori della cultura
“cool” ovvero della freddezza e del-
l’indifferenza. Perciòmolti ragazzi si
trovano in costante lotta con le pro-
prie emozioni. Inoltre essendo così
diffusa questa tendenza, è com-
prensibile il manifestarsi di ulteriori
reazioni emotive, e precisamente di
vergogna e rifiuto per le sensazioni
provate o addirittura di rifiuto di
qualsiasi emozione. Dunque non è
possibile comprendere il rifiuto sen-
za comprendere la sequenza delle
reazioni psichiche, descritte nel se-
guente modello causale.
ventati adulti e non dal contributo
che sapranno dare alla società. Lun-
go il percorso di consulenza si va
dunque a cozzare contro un rifiuto
determinato dalla scala dei valori del
ragazzo e dalle tendenze del mo-
mento che lo inducono ad optare
sempre per le professioni di grido.
Molte sono le professioni che forni-
scono all'adolescente un immediato
ritorno dal punto di vista del conso-
lidamento della sua identità (dell'im-
magine ideale che ha di sé), sebbene
a lungo termine non siano in grado
di garantirgli una congrua fonte di
reddito. Il rifiuto dell'adolescente è
dunque un segnale per l’operatore, e
precisamente un segnale che rivela
la «consapevolezza» dell'importan-
za della situazione che l'adolescente
si trova a vivere.
Il dr. Zoran Milivojevic´ (2001) se-
gnala che l’individuo non tollera
quelle strutture di rappresentazione
della realtà che demoliscono una
parte importante del suo contesto
referenziale. L’individuo si oppone
a tutti gli stimoli che intaccano la
struttura e la gerarchia dei suoi va-
lori fondamentali. A questa disso-
nanza egli si oppone con una serie
di meccanismi di difesa che l’ope-
ratore riconosce e definisce come
rifiuto. I meccanismi di difesa ser-
vono dunque a preservare l’equili-
brio psichico dell’assistito. Alcuni
operatori ed anche psicoterapeuti
cercano di modificare il comporta-
mento degli assistiti che esprimono
un rifiuto. Poiché il comportamento
nuova situazione di vita
azione – rifiuto
percezione
immagine mentale attribuzione percezione cosciente
tendenza comportamentale (coscienza)
valutazione
reazione emotiva
IL RIFIUTO
NELL’ORIENTAMENTO
SCOLASTICO
E PROFESSIONALE
Mihajlo Rostohar
(psicologo)
Gordana Rostohar
(psicologa)
LA NATURA DEL RIFIUTO
Il rifiuto nel campo dell'orienta-
mento scolastico e professionale si
manifesta sotto tre forme: rifiuto del
rapporto con l'operatore, rifiuto del-
le proprie sensazioni e rifiuto dei
problemi che l'assistito desidera (o
meglio non desidera) risolvere. Se-
condo l'opinione di alcuni operato-
ri tale rifiuto si ricollega alle reazio-
ni mediante le quali l'assistito si op-
pone ad un efficace percorso di
orientamento. Tutto ciò che ostaco-
la il processo di orientamento, così
come inteso dall’operatore, dai ge-
nitori e dagli insegnanti, viene dun-
que definito
rifiuto
.
Tale definizione di rifiuto si basa su
un approccio epistemologico ob-
biettivista. Gli operatori dei servizi di
consulenza scolastica, che si identi-
ficano nel ruolo di «salvatori», sono
convinti di avere il diritto ed il dove-
re esclusivo di stabilire la realtà psi-
cologica ed obiettiva dell'assistito.
L'approccio intersoggettivo a questo
tipo di attività postula invece che la
realtà soggettiva del consulente non
è più reale di quella del ragazzo. Se-
condo questo approccio, l'esperien-
za viene plasmata da entrambi e
dunque il consulente non presuppo-
ne di essere l'unico depositario della
realtà obiettiva. In tal modo può av-
vicinarsi alla percezione soggettiva
della realtà del suo assistito. Tipica-
mente il ragazzo si è creato un'im-
magine di sé da adulto, di cosa farà
e di quale sarà il suo status sociale.
Tuttavia provare ad immaginare il
proprio percorso professionale futu-
ro tende a scatenare nella maggior
parte dei ragazzi reazioni emotive
estremamente sgradevoli. Molti ri-
tengono che il valore futuro della lo-
ro persona dipenda esclusivamente
dalla loro capacità o incapacità di
«essere davvero unici» una volta di-