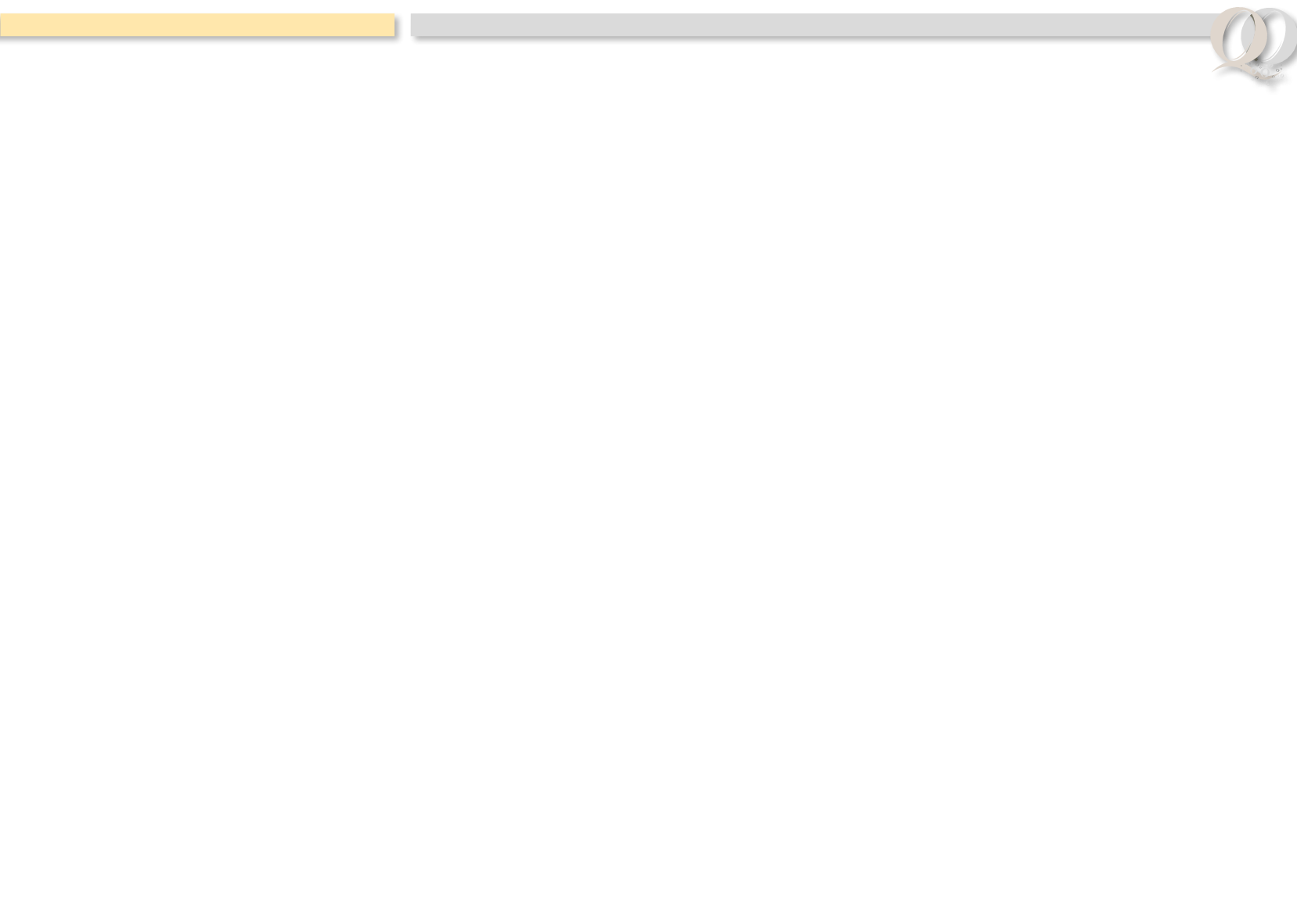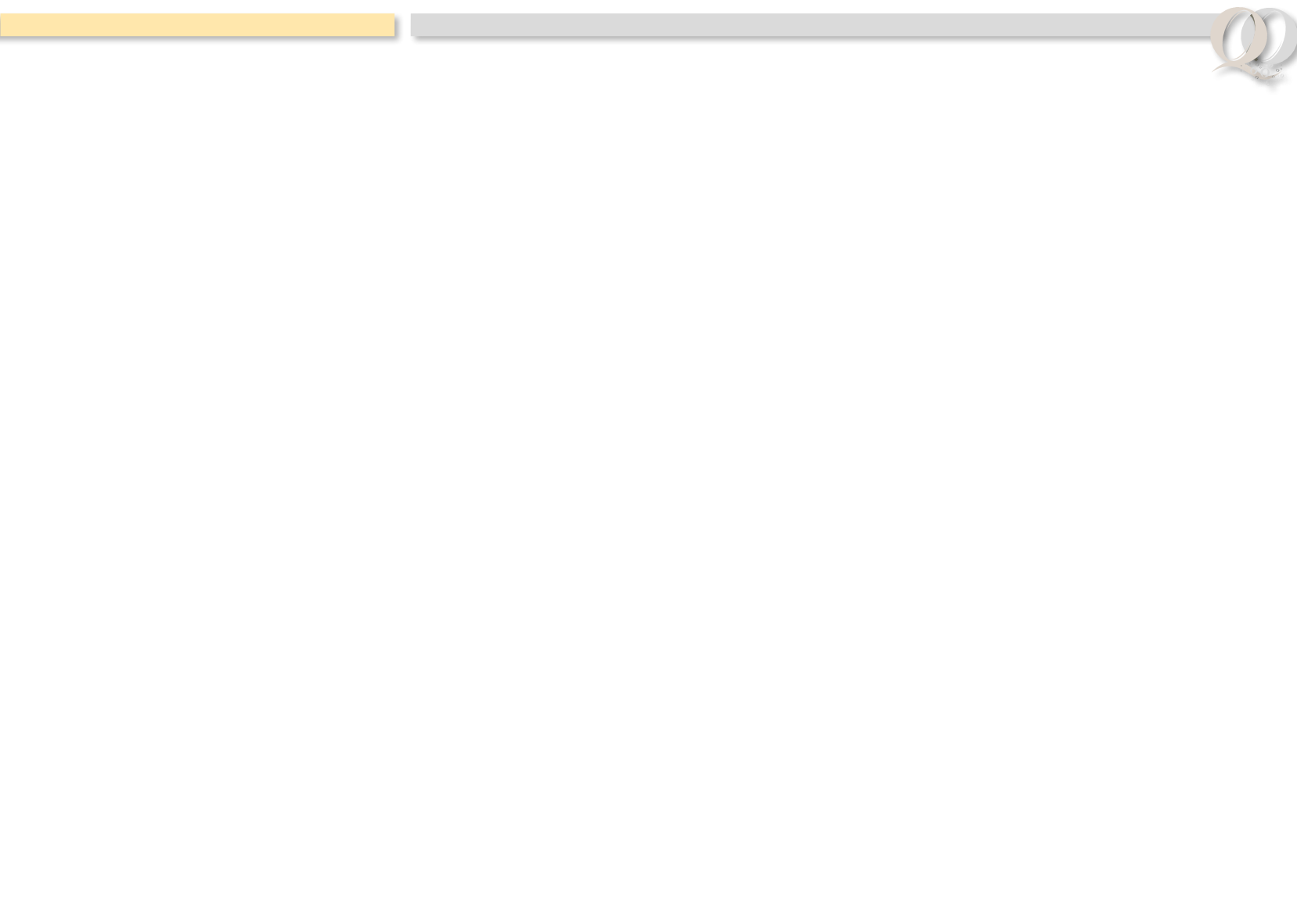
56
57
ORIENTAMENTO E SCUOLA
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 49
tudini, possono stare male in un certo
momento della loro vita: “
Non vengono
mai soli a scuola. In classe entra una ci-
polla: svariati strati di preoccupazione,
rancore, rabbie, desideri insoddisfatti,
rinunce furibonde accumulati su un
substrato di passato disonorevole, di
presente minaccioso, di futuro precluso.
Ecco che arrivano, il corpo in divenire e
la famiglia nello zaino. La lezione pu
cominciare solo dopo che hanno posa-
to il fardello e pelato la cipolla. Difficile
spiegarlo, ma basta uno sguardo, una
frase benevola, la parola di un adulto,
fiduciosa ed equilibrata, per dissolve-
re quei magoni, alleviare quegli animi,
collocarli in un presente rigorosamente
indicativo. Naturalmente il beneficio
sar transitorio, la cipolla si ricompor-
r all’uscita e forse domani bisogner
ricominciare daccapo. Ma insegnare
proprio questo: ricominciare fino a
scomparire come professori. È qualcosa
che si impara, soprattutto sul campo
e col tempo
” (D. Pennac, 2008, p. 55).
Insegnare è poter transitare anche per
questi corridoi, oltre che per i labirinti
del sapere, per entrare in classe;
-
nelle relazioni
: rappresentano il tes-
suto su cui si imbastisce l’istituzione,
il gruppo-classe, la vita scolastica del
singolo, come fili intrecciati fra loro (la
scuola nel suo complesso è fatta da per-
sone); potrei aggiungere che l’eteroge-
neità è uno dei nodi della trama e non è
immediatamente visibile, ma, ad esem-
pio, fa capolino quando in classe c’è un
cambiamento dell’ordine costituito (ba-
sta cambiare la disposizione di banchi e
cattedra che si creano altre dinamiche)
o quando il professore, nel bel mezzo
di una lezione, recupera, attraverso una
battuta ironica, una citazione, un’im-
magine, una risonanza allusiva dentro
al pensiero razionale, quasi a suggerire
che le idee e i concetti non devono solo
essere capiti, ma anche amati, “
io, nei
libri, cerco emozioni
” (J. L. Borges, 2001,
p. 131), che c’è una comprensione per
concetti e una comprensione per affetti
che sono complementari.
Fino ad oggi si è privilegiato un mo-
dello cognitivo secondo cui l’intelligen-
za è basata sul ragionamento logico-
deduttivo di una conoscenza astratta,
era importante essere colto e sapiente,
possedere tante informazioni, che sem-
bravano aver perso il contatto con il
sapere pratico dell’esperienza anche
manuale, come se fosse di serie B, in no-
me di una dualità cartesiana fra materia
e spirito che nega un principio eviden-
te: che siamo, in quanto esseri umani,
un’unità psicosomatica fatti di corpo e
di mente, di intelletto e fisicità. È l’intelli-
genza razionale dell’illuminismo, dove se
ponevi una domanda in maniera logica
e corretta ottenevi sempre una risposta.
Oggi possiamo confrontarci con altri
modelli di intelligenza, che ci suggeri-
scono che la sola ratio non fornisce tutti
gli strumenti per orientarci nel mondo,
ma che sperimentiamo e pensiamo il
mondo anche attraverso i sensi, con
la vista, con l’olfatto, le ballerine con il
movimento, i pittori con le forme e i
colori, partiamo dal corpo per dar for-
ma al pensiero simbolico: “
Il sapere
anzitutto carnale. Le nostre orecchie e i
nostri occhi lo captano, la nostra boc-
ca lo trasmette. Certo, ci viene dai libri,
ma i libri escono da noi. Fa rumore, un
pensiero, e il piacere di leggere un re-
taggio del bisogno di dire
” (D. Pennac,
2008, p. 131).
In questo senso possiamo parlare di
un sapere che nasce dai sensi e dalle
emozioni e di un’intelligenza emotiva,
capace di coltivare l’immaginazione,
base di partenza per qualsiasi forma di
creatività:“
Immaginare, scegliere, inven-
tare delle parole nuove per dare nuova
forma al mondo, liberarlo, in qualche
modo, dalle parole in cui l’hanno co-
stretto
” (A. Bajani, 2014, p.53).
Non a caso, fin dall’antichità, il teatro,
che è fatto di corpo, azione e parola col-
legati in maniera armonica, non è con-
siderato solo una forma estetica, ma la
più antica forma di sapienza, a ricordarci
che esiste sempre un nesso tra l’azione
e la formazione, che i concetti formali
sono relativi al mondo in cui emergono
e che essi stessi concorrono a creare.
O, per dirla con le parole di uno scrit-
tore:“
L’arte ha un potere di preveggenza
o intuizione perché si muove su un piano
pre-logico, di cui per la logica non pu
fare a meno. Senza una pre-logica non
ci sarebbe conoscenza
” (A. Tabucchi,
2013, p. 36).
Un ulteriore aspetto invariante, che si
ritrova nelle esperienze di questi autori,
è un interrogarsi su qual è la sostanza
dell’apprendere ed essi la individuano
nella passione, nel desiderio stesso del
sapere. La passione è qualcosa che ci
coglie di sorpresa e che non possia-
mo né programmare, né controllare,
ci investe con la forza dell’enigma, del
mistero ed è importante innanzi tutto
perché consente un decentramento
da noi stessi, permette di cogliere che
il mondo, la materia, l’autore che stiamo
studiando, stanno fuori di noi, vivono di
vita propria, una vita diversa e nuova,
per noi che ci pu attirare e che pos-
siamo amare.
LA CONOSCENZA
COME PERCORSO
POLISEMICO
Il processo di conoscenza, in effetti,
non segue un corso lineare, ma è segna-
to dal cambiamento e dalla discontinui-
tà; inoltre, non è un elemento puramen-
te decorativo o di consumo: “
Inseguire
la chimera del mercato, per , pura-
mente illusorio [ … ]. La formazione
ha bisogno di tempi lunghi. Orientarla
esclusivamente sulle presunte offerte
del mondo del lavoro potrebbe rivelarsi
una sfida perduta in partenza
”(N. Ordi-
ne, 2016, p. 22); e ancora: “
Come si fa a
non capire che obbligare giovanissimi
studenti a scegliere una professione gi
prima di iscriversi alle scuole superiori, in
nome di programmi scolastici finalizzati
al mercato, finirebbe per uccidere qualsi-
asi possibilit di incoraggiarli a coltivare
liberamente i loro interessi e la loro
cu-
riositas?” (ibidem, p. 35), significa poter
pensare la conoscenza come un gesto
quotidiano che interessa la globalità
della nostra persona e della nostra vita.
La formazione, dunque, è una pratica
che lascia delle tracce (materiali, di signi-
ficato, emotive,…) e, aggiungerei, una
pratica sociale, dove il gruppo diventa
uno strumento elettivo per lo sviluppo
e la circolazione delle idee, uno spazio
reale ma anche simbolico che permette
ad ognuno di avere il proprio ruolo e, in
questomodo, di alimentare la speranza,
parafrasando Pennac, di poter avere un
proprio posto nel mondo.
Per concludere vorrei tornare al titolo
di questo breve articolo, che riprende
l’immagine di Babele: se di primo ac-
chito fa pensare a una confusione e a
un incontro difficile, se non addirittura
impossibile, fra le dinamiche che ca-
ratterizzano il percorso formativo e la
dimensione legislativa e burocratica
che ne definisce i confini, o fra i bisogni
di chi insegna e quelli di chi apprende,
o ancora fra le esigenze del singolo e
quelle del gruppo-classe, fra l’idealità
delle aspettative e la prosaicità del quo-
tidiano, ad un secondo sguardo la Ba-
bele pu essere vista come polisemia,
capace di dar vita a questo mutevole
caleidoscopio di relazioni, leggi, spazi,
materie, ecc., trasformando confusione
e antagonismi nel pensiero del molte-
plice“
che deriva dalla realt composita,
dall’enigmatica abbondanza del mon-
do
”(F. Brezzi, 2014, p. 90) che si incrocia
nel microcosmo della scuola.
Cristina Bertogna
Psicoterapeuta di gruppo
Psicoanalista Societ Psicoanalitica
Italiana