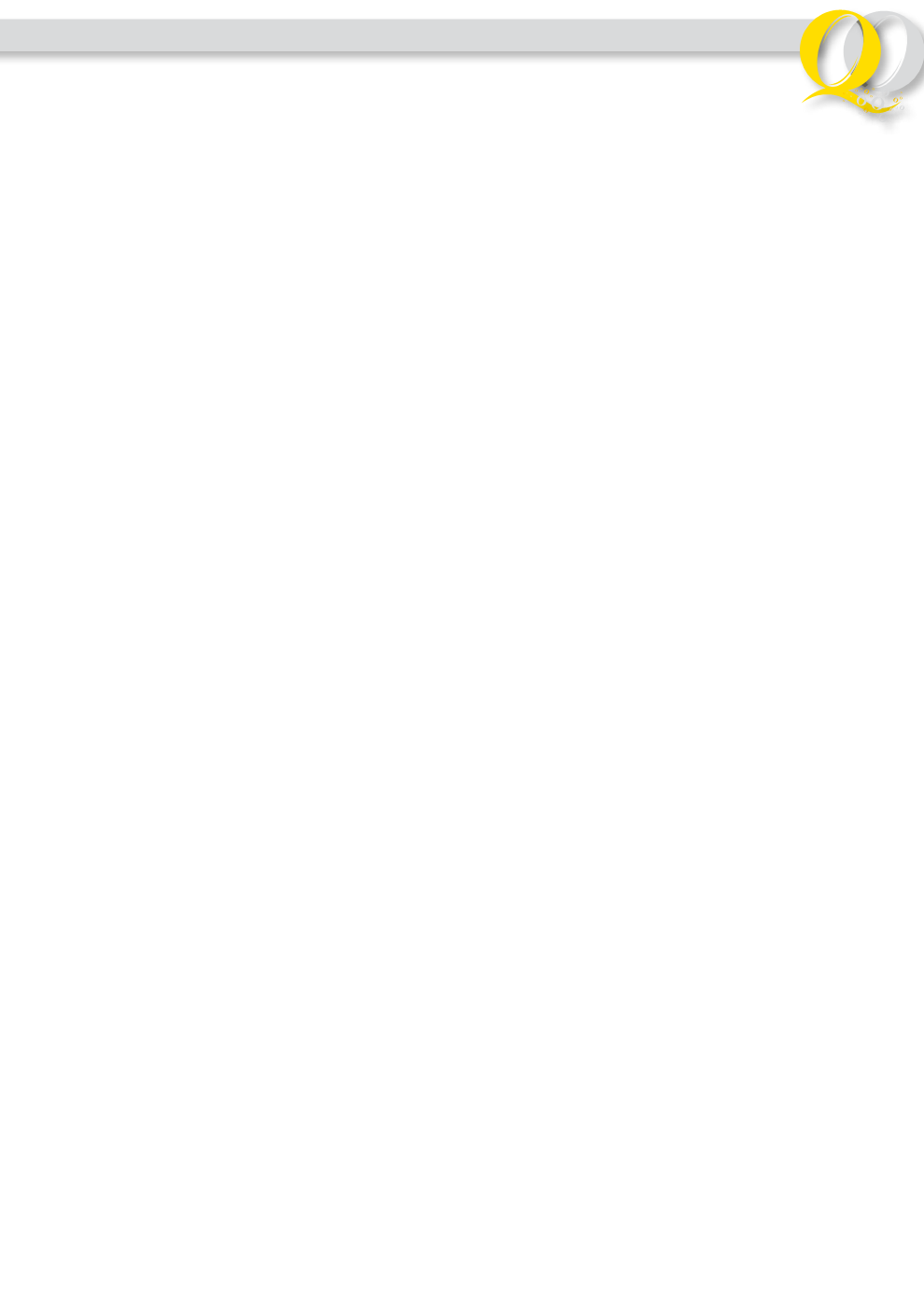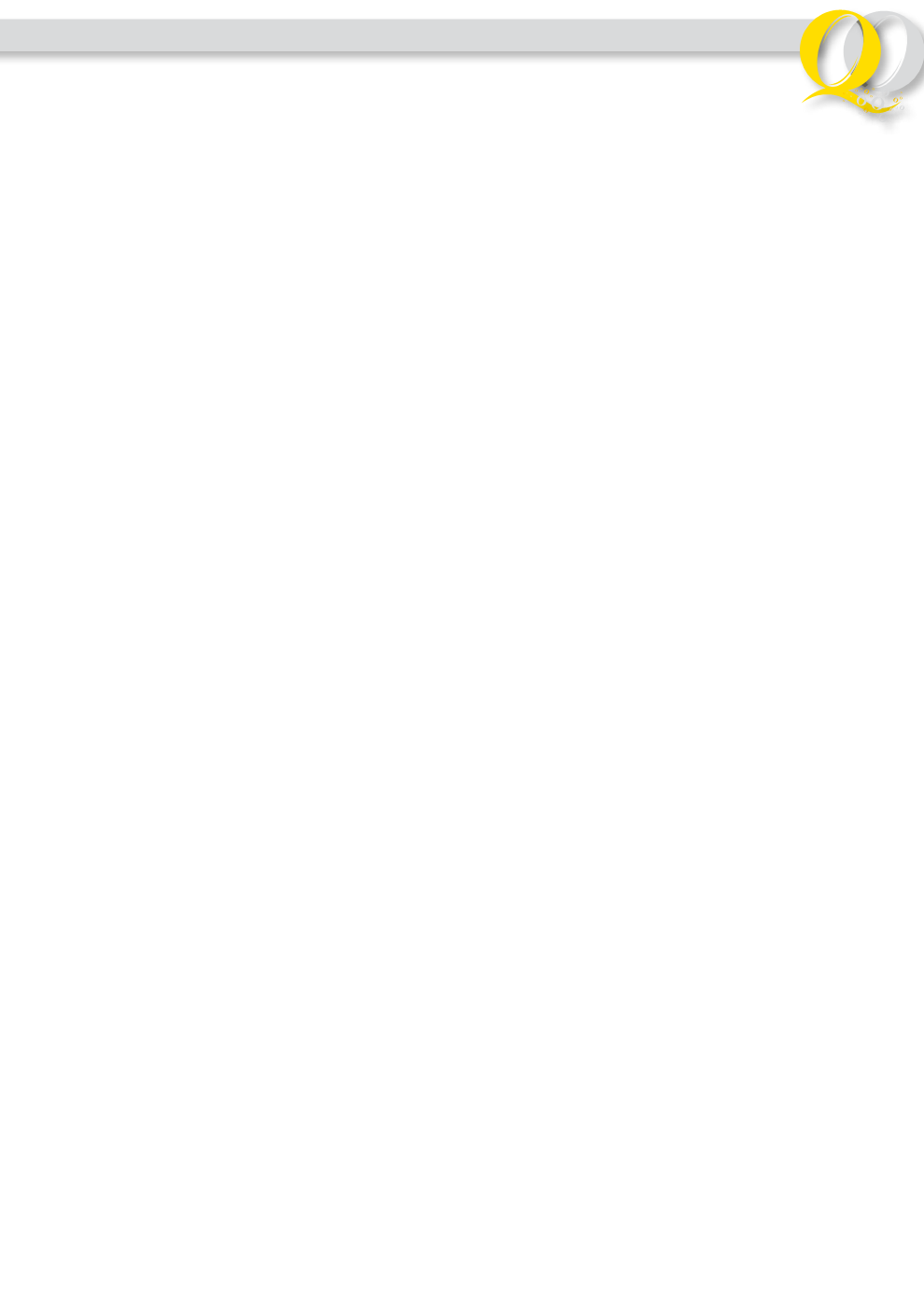
11
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 46
puter così da farlo ragionare e prendere
decisioni sulla base di criteri estetici?
”In
queste righe Keith non intendeva tan-
to prefigurare il futuro dell’espressione
artistica dominato e controllato dalle
macchine. Piuttosto, cercava di sollevare
una questione antropologica più sotti-
le, sottesa al complesso rapporto che
vincola strettamente tra loro i mondi
dell’arte e quelli della tecnologia.
“
La nostra esistenza
”, annotava, infatti,
qualche riga più sotto,“
l’individualità, la
creatività e persino le nostre vite sono
minacciate da questa estetica delle mac-
chine
”. Per dirla in breve, in gioco pare ci
sia la nostra libertà stessa di pensare e di
agire quando le macchine procedono
sicure verso la conquista e l’occupazio-
ne della nostra creatività. Occorre dirla
tutta. Se davvero la nostra creatività è
in pericolo, la nostra libertà (di conse-
guenza) non se la passa benissimo…
L’ORIGINE DELLA
CREATIVITÀ
Il tema è complesso e la posta in gioco
importante. Ed è proprio in casi come
questi che la via più breve per provare
a venire a capo di un problema tanto
articolato è quella di prenderla un po’alla
larga. Almeno quanto basta per riportare
il problema alla sua origine. Se c’è una
cosa che la filosofia ha in comune la me-
dicina (e con la scienza più in generale)
è proprio questo: cercare di risalire dai
sintomi evidenti alle cause probabili.
Un esercizio facile da raccomandare,
più difficile da mettere in pratica: sia per-
ché (come anche nel caso in questione)
le evidenze disponibili spesso suggeri-
scono terapie sintomatiche, ovvero rime-
di che agiscono con efficacia apparente
sugli “effetti preoccupanti” senza pren-
dere in considerazione le cause effettive;
sia perché la ricerca delle cause implica
una capacità di interrogare i fenomeni
naturali e gli eventi sociali con analisi e
pratiche concettuali poco diffuse e quasi
mai intuitive, quelle appunto tipiche
della ricerca.
Aggiungo, infine, che questo tipo di
indagini e questo è un altro aspetto per
nulla secondario, non esclude l’even-
tualità di mettere in gioco convinzioni
e credenze che, magari, si ritenevano
attendibili e consolidate, costringendoci
di conseguenza a ridisegnare il nostro
sguardo su noi stessi e sul mondo che
ci circonda.
E di questo era ben consapevole il
celebre poeta tedesco Friedrich Höl-
derlin quando, in versi divenuti ormai
un classico della lirica tedesca, scriveva:
“
Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Ret-
tende auch”. Ossia, “Dove c’è il pericolo,
cresce / Ciò che salva
”. Ora non è detto
che la comprensione di fatto o la so-
luzione di un problema, specie nella
dimensione laica della ricerca, costitu-
isca di per sé una “salvezza”; tuttavia, è
certo che non si dà ricerca (e dunque
ci si esclude dalla possibilità di com-
prendere), là dove non si mettono in
pericolo anche i concetti (e i valori) ai
quali, per una qualche ragione o per
un qualche sentimento, ci sentiamo
più ancorati.
Nel merito dell’argomento in ogget-
to, avremmo diverse strade da poter
intraprendere, posto che l’orizzonte
da interrogare è l’origine (e dunque il
destino) della creatività. Riflettendo,
pertanto, sulla emblematica consi-
derazione della docente di lettere da
cui abbiamo preso le mosse, parreb-
be infatti che la creatività sia qualcosa
di qualitativamente altro rispetto agli
strumenti della tecnica e della tecno-
logia. Certo, in alcuni casi, penso, per
esempio, alla penna, al pennello, allo
scalpello, ecc., gli arnesi possono co-
stituire un ausilio espressivo allo scopo
di dare corpo e forma, appunto, a ciò
che la nostra immaginazione ha par-
torito. Tuttavia, sembrerebbe scorretto
riconoscere un ruolo determinante allo
strumento (quale che sia) nella libera
elaborazione di un’idea o di un’opera.