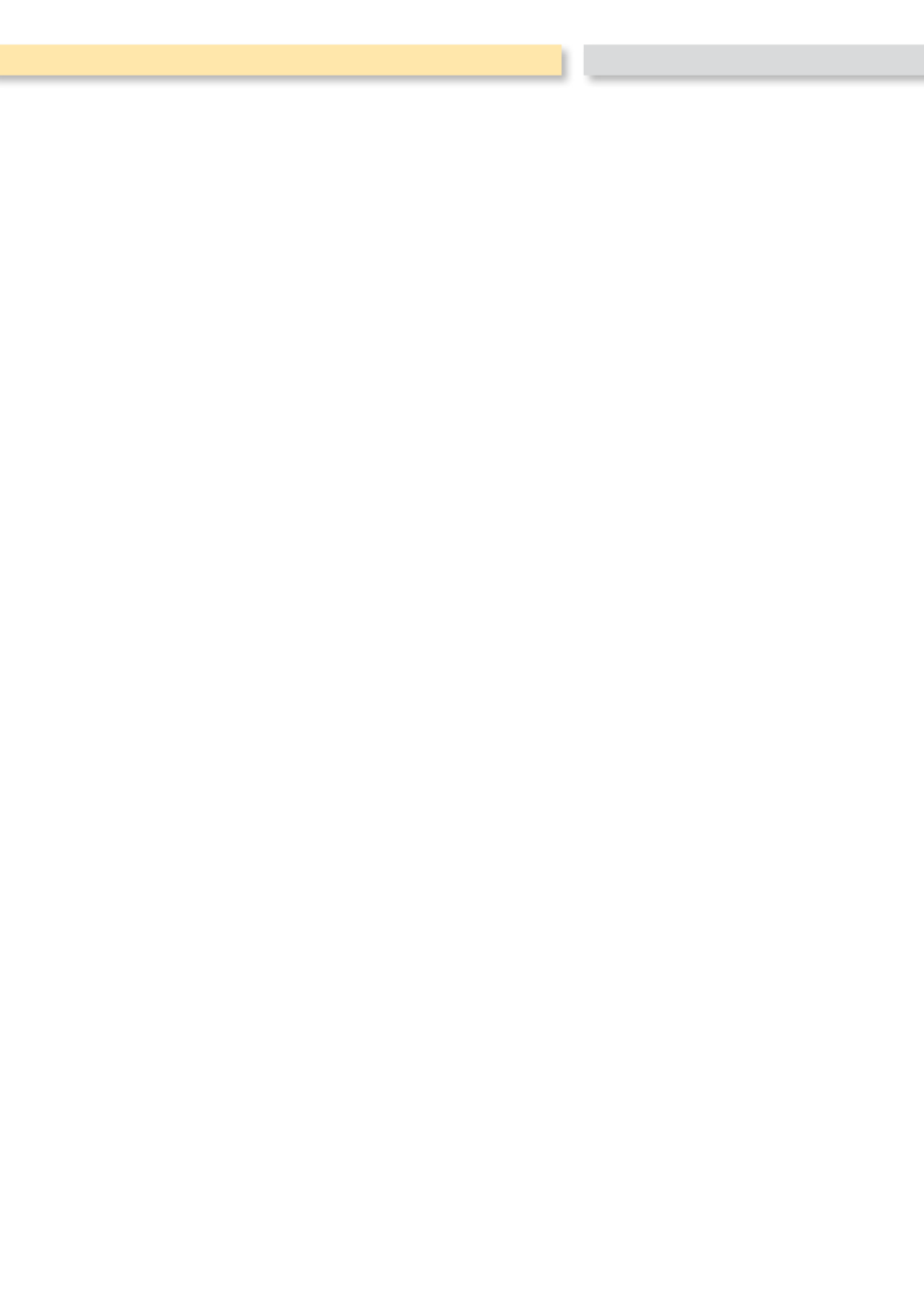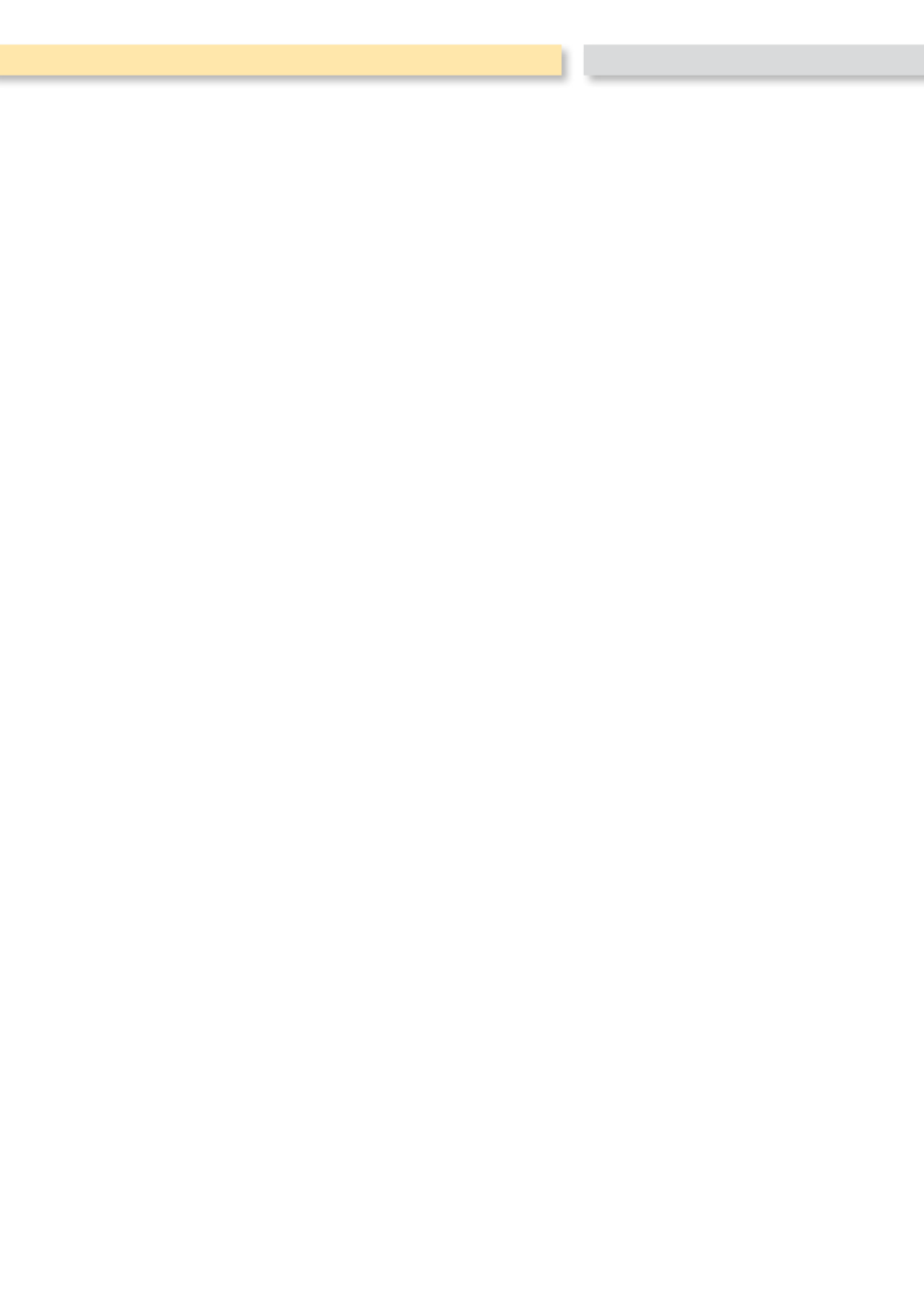
66
ORIENTAMENTO E SCUOLA
Le conclusioni di uno studio svolto su
154 bambini con DSA (Ming et al., 2007)
affermano che il 51% dei partecipanti mo-
stra ipotonia e il 34% aprassia (presente
soprattutto nei bambini più piccoli). Il 19%
dei soggetti esaminati presenta un modo
non coordinato di camminare e il 9% dei
deficit nella motricità grossa. Inoltre, un
numero elevato di essi presenta problemi
nella motricità fine. Questi dati sembrano
confermare i risultati di studi precedenti,
come quello di Page e Boucher (1998),
che notarono come la totalità dei soggetti
esaminati presentava problemi nel com-
portamento motorio gestuale.
Leary e Hill (1996), dopo aver esaminato
molti studi sul comportamento motorio
nell’autismo, hanno sostenuto l’importanza
di tali disturbi per la patologia in oggetto. I
due ricercatori ritengono che alcuni deficit
sociali dei soggetti con autismo possono
essere ascritti a sintomi neurologici di de-
ficit motori. Ne consegue che dovrebbe
essere possibile porre in connessione i gesti
omovimenti socialmente inappropriati con
i sintomi neurologici della psicomotricità.
Gli autori sottolineano che l’osservazione
di tali comportamenti nel contesto socia-
le non deve far dimenticare la possibile
causa neurologica dei comportamenti
stessi. L’obiettivo principale di Leary e Hill
è quello di mostrare un legame tra alcune
caratteristiche sociali dei DSA ed i correlati
neurologici dei disturbi motori. Essi hanno
proposto una teoria dei disturbi presenti
nei DSA nel loro comportamento motorio-
gestuale. Prendendo spunto dalle categorie
utilizzate in diversi strumenti che servono
per l’assessment neuro-motorio, gli autori
hanno raggruppato i sintomi motori dei
DSA in tre livelli:
(1) Disturbi della
funzione motoria genera-
le
: postura, tono muscolare, movimenti
accompagnatori e movimenti senza un
fine preciso (ad esempio i tic).
(2) Disturbi dei
movimenti volontari:
le dif-
ficoltà nella pianificazione del movimen-
to ed i movimenti spontanei ripetitivi.
(3) Disturbi dei
movimenti involontari:
tutti i disturbi motori che condiziona-
no a livello generale ed incontrollabile
il comportamento.
Secondo gli autori, la forte enfasi po-
sta sul contesto sociale in cui avviene un
comportamento potrebbe spesso portare
ad un’interpretazione erronea dei possi-
bili fattori neurologici che sono alla base
del deficit osservato. Pertanto, Leary e Hill
propongono di spostare l’attenzione sul
movimento. In questo modo si potrebbero
aprire nuove prospettive per la costruzio-
ne di più raffinati strumenti diagnostici e
riabilitativi.
Damasio e Maurer (1978) hanno pubbli-
cato i primi studi sistematici sulla deam-
bulazione in soggetti affetti da autismo.
Nelle loro conclusioni gli autori trattano
la deambulazione come movimento ge-
nerale, da considerare prioritariamente
nel quadro della valutazione motoria dei
disturbi dello spettro autistico. I risultati
dei loro studi affermano che tali soggetti
mostrano pattern deambulatori simili a
quelli delle persone affette da morbo di
Parkinson. Hallett (Hallett et al., 1993) ha
rilevato nei soggetti autistici una minore
motricità dell’anca, nel movimento delle
caviglie ed una posizione più bassa delle
ginocchia nelle prime fasi del movimento
deambulatorio.
Nel 1998 Teitelbaum (Teitelbaum et al.,
1998) ha esaminato lo sviluppo del movi-
mento (stare distesi–raddrizzarsi–sedersi–
camminare carponi–stare in piedi–cammi-
nare). Le conclusioni di tale ricerca afferma-
no che i bambini con DSA non superano
adeguatamente tali fasi. I suoi risultati si
possono così riassumere:
1. asimmetria delle braccia rispetto alle
gambe;
2. deficit a livello della sincronizzazione
dei canali motori: sequenza e mancata
sovrapposizione dello sviluppo, movi-
menti che non si sviluppano in maniera
integrata, ma in sequenza;
3. sviluppo motorio ritardato ed incom-
pleto: la deambulazione compare più
tardi rispetto al normale ed i deficit non
scompaiono mai del tutto, infatti anche