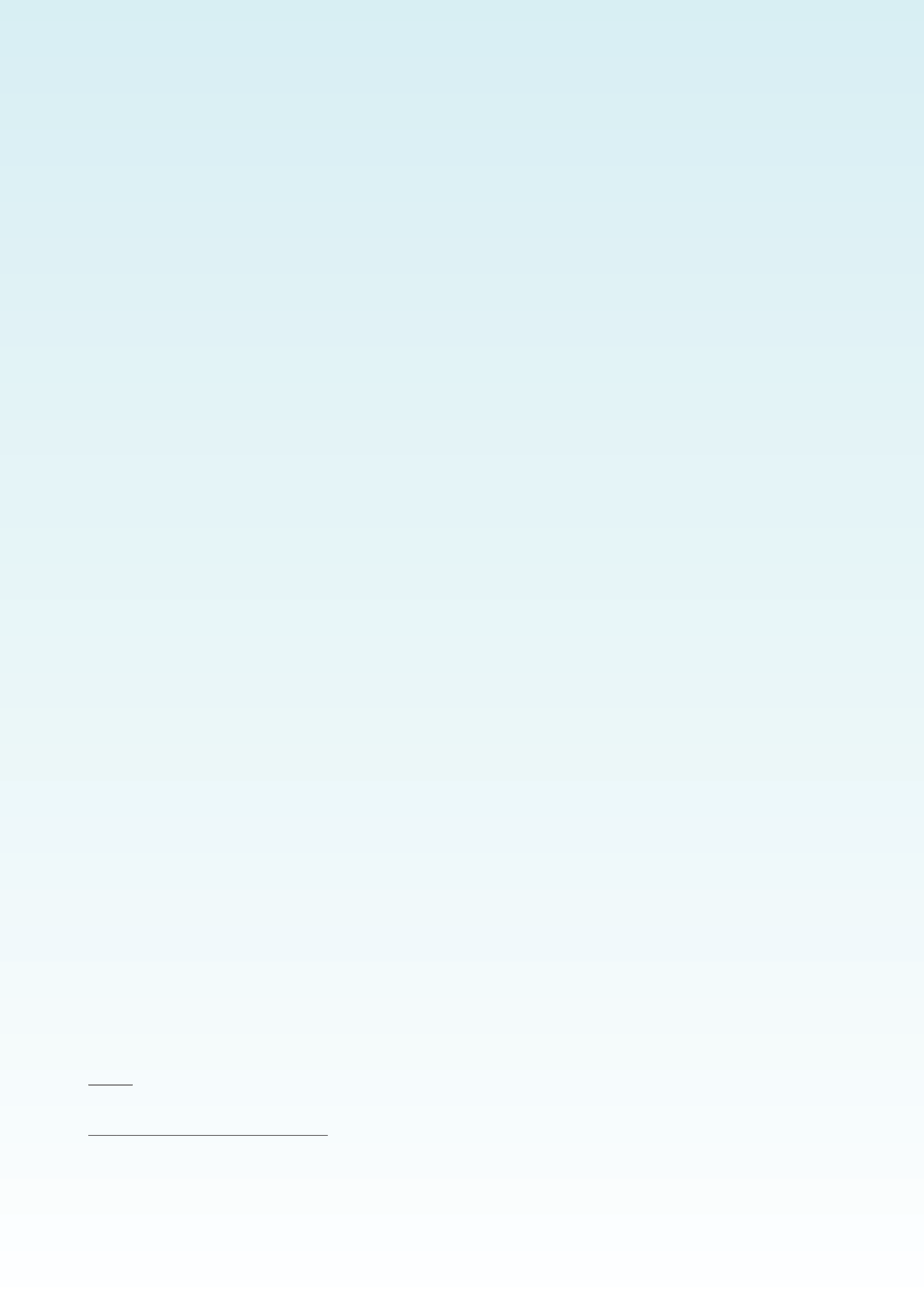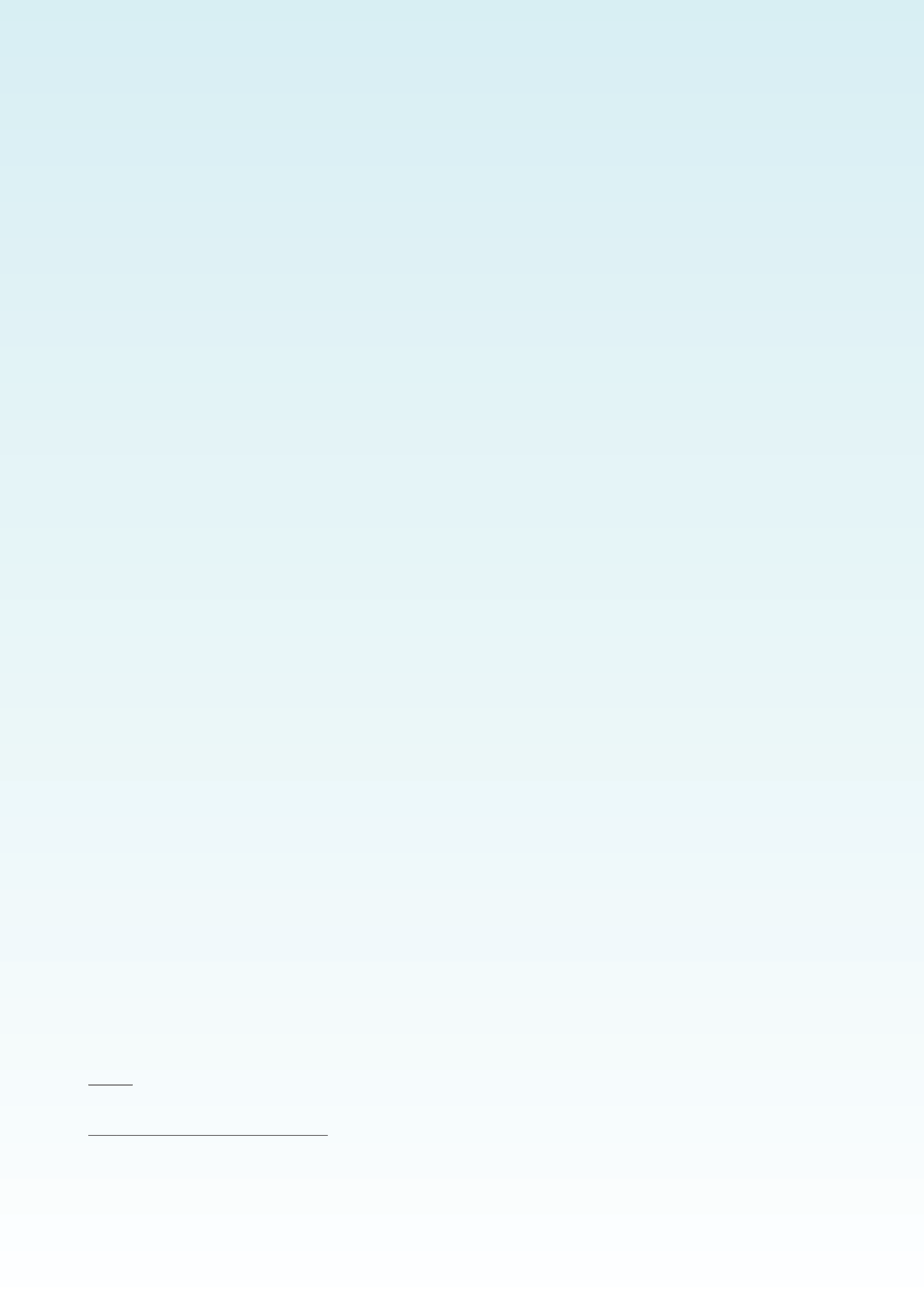
Il Centro risorse regionale per l’orientamento
Macrointervento 1
Cos’è un
Centro Risorse
? E' forse questa la domanda essenziale, la cui risposta può guidarci nel percorso di analisi
dell'attività fin qui svolta da quello che rappresenta uno dei principali dispositivi attivati attraverso il progetto Ri.T.M.O..
Un Centro Risorse è un luogo di informazione, documentazione, animazione, sensibilizzazione, formazione e consulen-
za su un determinato tema. Le sue attività caratteristiche sono la consultazione, il confronto e la sperimentazione indi-
viduale e collettiva, come momento di raccordo tra le varie realtà del territorio, come strumento di ricerca e osservato-
rio su tematiche specifiche.
E’ il “luogo” che favorisce la circolazione delle informazioni affinché queste siano la base di una costante azione for-
mativa per la comunità e che valorizza le competenze individuali per un interesse collettivo, affinché si creino “reti di
persone risorse” che agiscano da propulsore e stimolo di nuove progettualità.
Sono questi i concetti che hanno ispirato la costituzione del Centro risorse regionale per l’orientamento del Friuli -
Venezia Giulia e che, partendo anche dall’esperienza che l’ente gestore Aster ha capitalizzato gestendo dal 1993 il
Centro Risorse Nazionale per l’Orientamento a Bologna, hanno permesso l'individuazione di due capisaldi delle sue
attività: il lavoro in rete e la valorizzazione dell'informazione.
L’
informazione
nel processo di orientamento può essere definita come una condizione di base per assicurare a tutti i
cittadini la possibilità di formulare scelte motivate e consapevoli sui percorsi formativi e lavorativi. Parlare di condizione
di base significa avere chiaro che l’informazione non esaurisce il processo di orientamento, sia dal punto di vista dell’u-
tente sia dal punto di vista dell’operatore, ma che tuttavia un adeguato patrimonio informativo è una pre-condizione
senza la quale le attività di consulenza orientativa perderebbero la loro finalizzazione e la loro efficacia.
Il tema dell’informazione, che negli ultimi anni è rimasto un po’ sullo sfondo nel dibattito sull’orientamento dopo aver
conosciuto, verso la fine degli anni’80/inizi anni ’90, una forte attenzione - anche in concomitanza dell’apertura dei
primi servizi informativi rivolti all’utenza giovanile (Informagiovani) - ritorna oggi di grande attualità a partire da alcune
condizioni che hanno modificato profondamente il contesto di riferimento. Si allude, nello specifico:
o ai profondi mutamenti, in particolare di tipo normativo, che interessano il mondo dell’istruzione, della formazio-
ne e del lavoro e che ridisegnano il sistema delle opportunità dei cittadini nel campo dello studio e dell’occupa-
zione, all’interno di uno scenario in continua evoluzione. Scenario che richiede, a chi di occupa di informazione
orientativa, un importante e continuo lavoro di monitoraggio sui costanti sviluppi del contesto formativo-profes-
sionale (si pensi, per fare un solo esempio, a come si è ridefinita, negli anni, l’offerta di percorsi di studio all’in-
terno dei sistemi dell’istruzione superiore e dell’università a seguito dell’autonomia).
o all’avvento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che fanno sì che il pubblico acceda, con
sempre maggiore frequenza, direttamente alle fonti informative presenti su Internet, senza garanzia sull’affida-
bilità dei contenuti informativi che vengono acquisiti.
La complessità di queste problematiche, qui semplicemente accennate, si intreccia con il tema, ampiamente dibattuto
nella letteratura di riferimento, su cosa debba intendersi per “buona informazione”.
Se si concorda nel ritenere che una buona informazione debba rispondere ad alcuni criteri (fra i più condivisi quelli di
veridicità, comprensibilità, pertinenza, utilizzabilità e accettabilità) si intuisce come le competenze richieste per produrre
informazione siano competenze ad alta specificità professionale e le risorse economiche necessarie per mantenere un
sistema informativo aggiornato (anche sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie) siano cospicue. Ecco perché,
anche all’interno di documenti a valenza internazionale 1 , viene sottolineata l’importanza di servizi che, a livello nazio-
nale e/o regionale, coordinano le attività di raccolta, trattamento e verifica delle risorse informative nonché di identifi-
cazione dei bisogni, delle richieste e del livello di conoscenza degli utenti, attraverso il monitoraggio delle problemati-
che riscontrate dagli operatori a contatto con il pubblico. Un centro risorse deve essere un servizio caratterizzato in
questa direzione.
D'altra parte, l'
integrazione
è una finalità irrinunciabile per l’orientamento se si vuole ridurre la frammentarietà/par-
zialità delle risposte agli utenti e se si vuole eliminare la discontinuità del sostegno orientativo. E la rete 2 è la modalità
organizzativa propria dell’integrazione.
I servizi in rete sono in grado di affrontare la complessità sociale che viviamo, spostando l’attenzione sui bisogni dei cit-
tadini e non sulle proprie specifiche competenze.
I
Le attività di Ri.T.M.O.
1 Si veda, a questo proposito, il recente ed esaustivo documento di A. Tricot,
Amélioration de l’information sur les métiers,
(dicembre 2002),
predisposto nell’ambito dell’indagine OCSE sulle politiche relative ai servizi di informazione e orientamento e accessibile all’indirizzo web:
2 Per approfondire il tema delle reti in rapporto ai servizi di orientamento si veda l’articolo di D. Pavoncello e F. Marcigliano,
Le reti territoriali.
Sviluppo e organizzazione dei servizi di orientamento (D.M. 166/2001),
in
Magellano,
n. 17, 2003, pp. 33-42