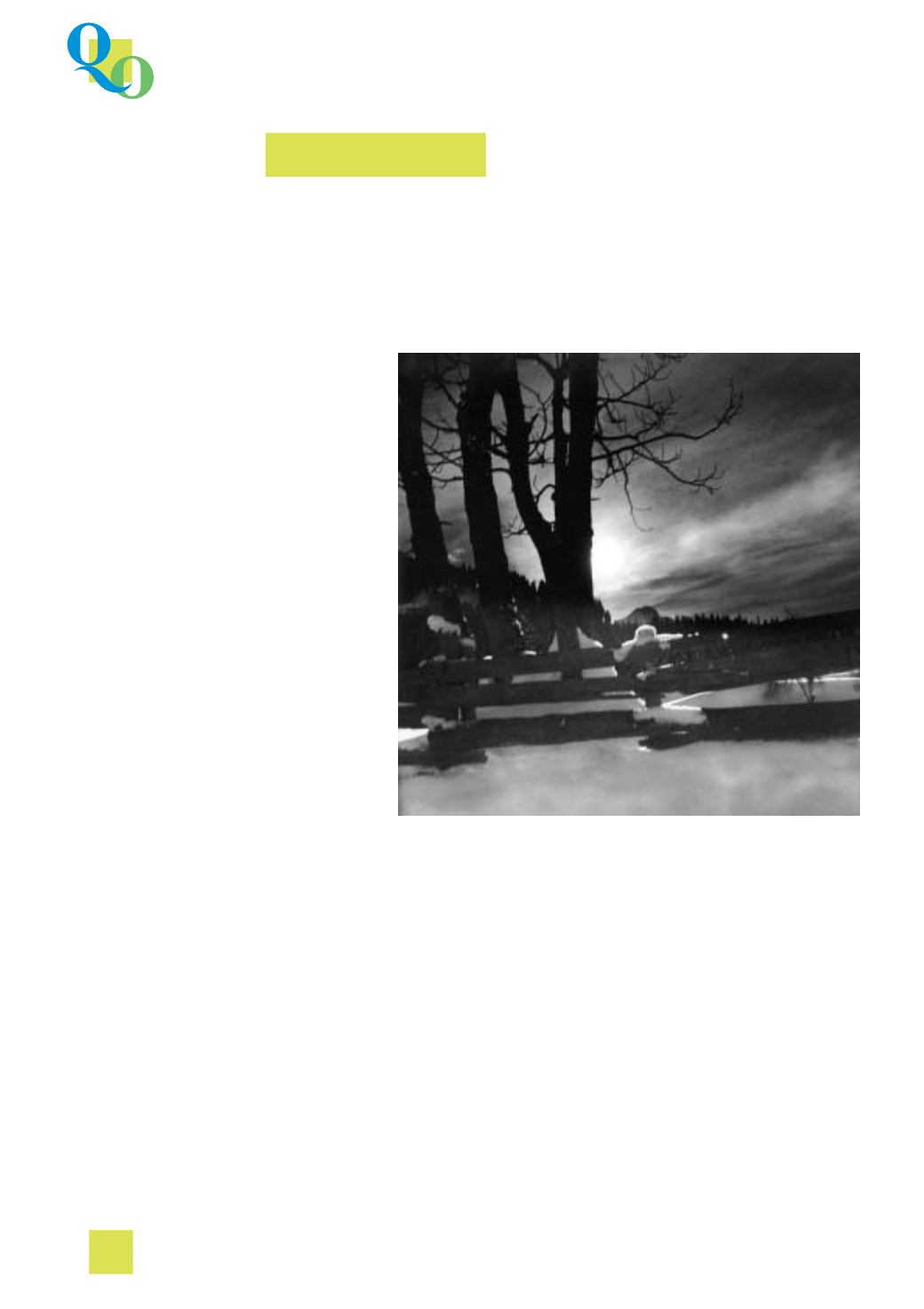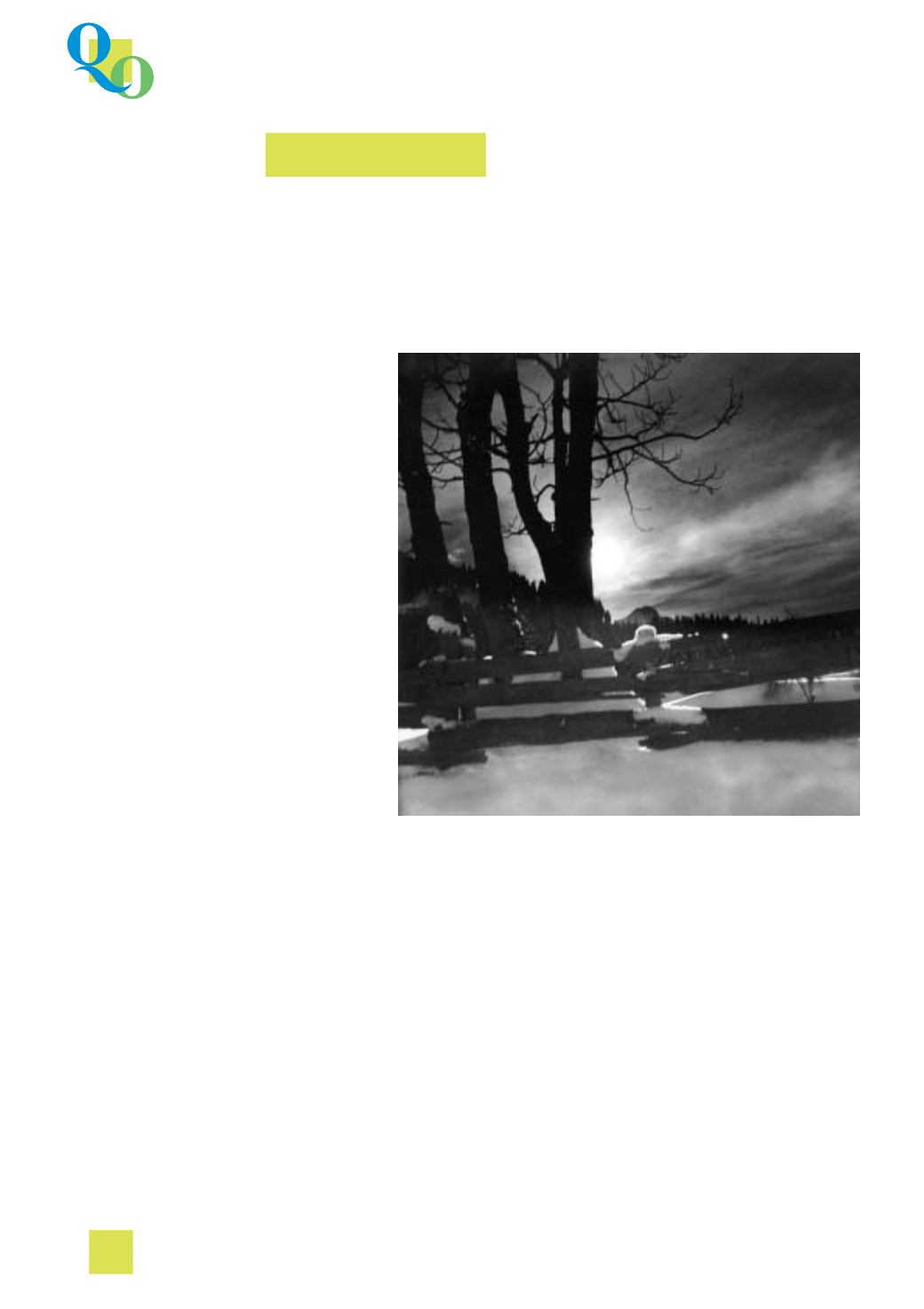
nuovo quadro normativo, divenuto
già vincolante per l’attività didatti-
ca, richiede un’attenta riflessione su
alcune questioni (anche organizza-
tive) che esso suscita nella sua fase
di attuazione (Semeraro, 1999). Le
norme sul riconoscimento di speci-
fiche ed autonome unità scolastiche
hanno posto le premesse per l’avvio
di un processo in cui la dimensione
giuridica si intreccia con quella cul-
turale e comportamentale e la di-
mensione pedagogica si fonde con
quella organizzativa. I cambiamen-
ti e le innovazioni che caratterizza-
no la scuola italiana di oggi sono
destinati a modificare radicalmente
il suo assetto strutturale: «occorrerà
ancora del tempo perché emergano
tutte le implicazioni che potranno
derivare dal passaggio da un siste-
ma centralistico, nel quale gli aspet-
ti burocratici hanno conservato a
lungo la loro importanza, a un mo-
dello ispirato all’autonomia orga-
nizzativa e didattica. Tale cambio di
scenario trova la sua ragione cultu-
rale da un lato nella complessità in-
trinseca a un diverso quadro delle
aspettative della società; dall’altro
nella definitiva affermazione della
prospettiva dell’autonomia, caratte-
rizzata da comportamenti profes-
sionali del personale della scuola
che non trovano alcun riscontro in
quelli di epoche precedenti. Proce-
dere nella direzione dell’autonomia
richiede l’acquisizione di nuove
consapevolezze e, soprattutto, la ca-
pacità di ricercare soluzioni ade-
guate a bisogni ed esigenze che im-
plicano un investimento culturale e
organizzativo nella prospettiva del
miglioramento continuo del servi-
zio erogato»
1
.
La terza spiegazione, infine, ripro-
pone la questione dei compiti della
scuola e, in particolare, l’annosa
controversia fra l’educare e l’istrui-
re. Tale dicotomia appartiene alla
storiografia della “lunga durata”,
nel senso che ha da sempre interes-
sato i pedagogisti ed ha visto con-
frontarsi, nel corso degli anni, op-
posti schieramenti a sostegno del-
l’una o dell’altra tesi. In Italia, il di-
battito sui compiti della scuola ha
ripreso vigore nei primi anni Ot-
tanta, ovvero quando si pose il
problema di ridefinire la funzione
della scuola pubblica in linea con
lo sviluppo delle scienze dell’edu-
cazione e con i nuovi bisogni della
società (Desinan, 1998). Dopo gli
anni Novanta il quadro concettua-
le entro il quale si svolgeva il di-
battito si è arricchito di nuovi in-
terrogativi e nuovi spunti, consoli-
dando la convinzione che qualsiasi
compromesso fra le due alternati-
ve sarebbe fuori luogo. In altri ter-
mini oggi la questione non si pone
più fra due alternative (educare o
istruire) che si escludono a vicenda
e, soprattutto, non è di esclusiva
competenza pedagogica. Il ruolo e
la funzione della scuola nell’attua-
le società complessa dipendono
anche dalla sua organizzazione, in-
tesa come un fattore chiave dell’ef-
ficienza complessiva dei processi
formativi: «i fallimenti nella scuola
sono anche dovuti a carenze orga-
nizzative e di intesa fra docenti. Le
tesi sostenute da educazionisti e
istruttivisti hanno quasi sempre
ignorato i problemi organizzativi.
Per una organizzazione efficace bi-
sognerebbe anche pensare a nuove
LA SCUOLA COME ORGANIZZAZIONE
10
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
■
23
Tramonto a Rutte, 1938