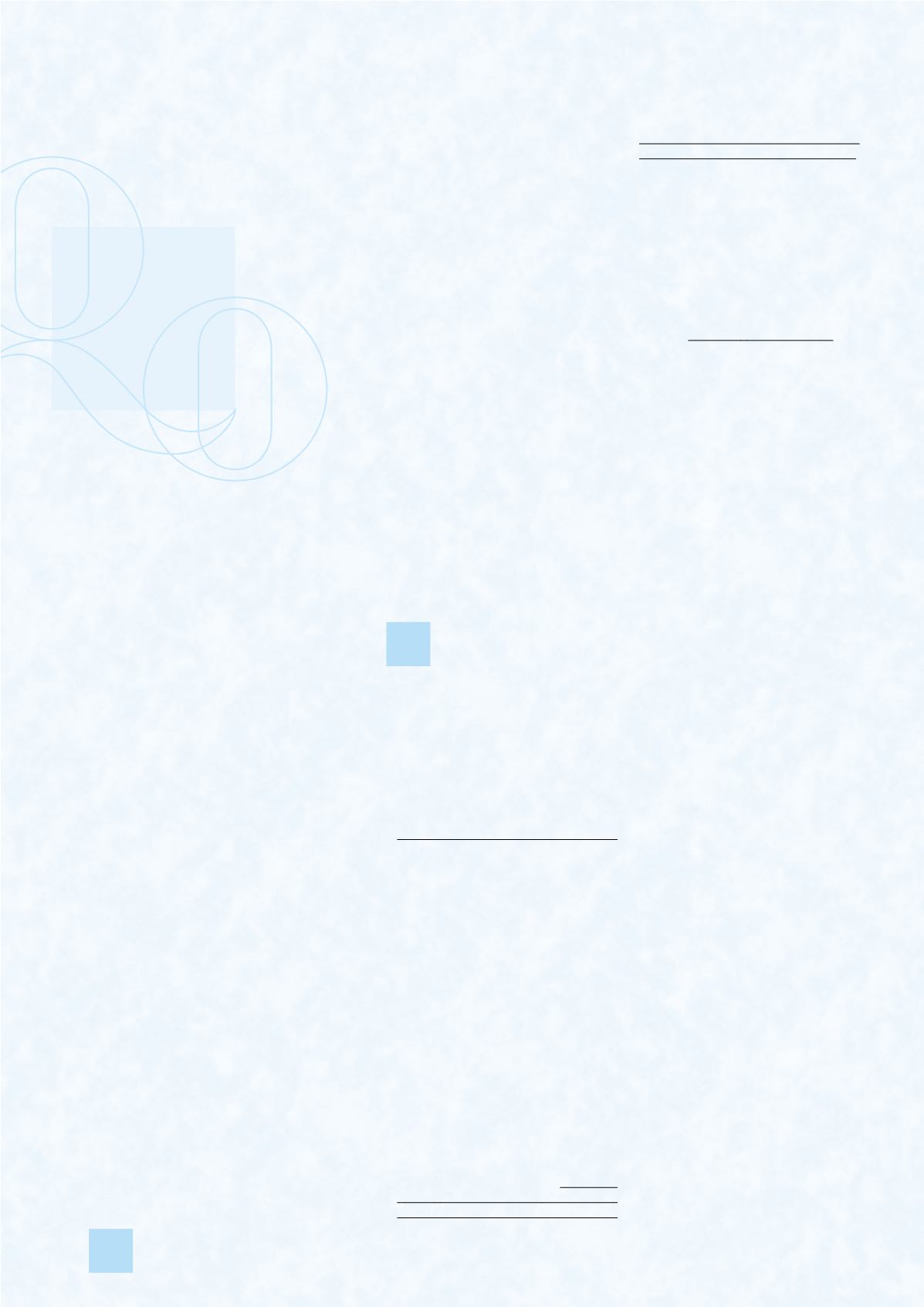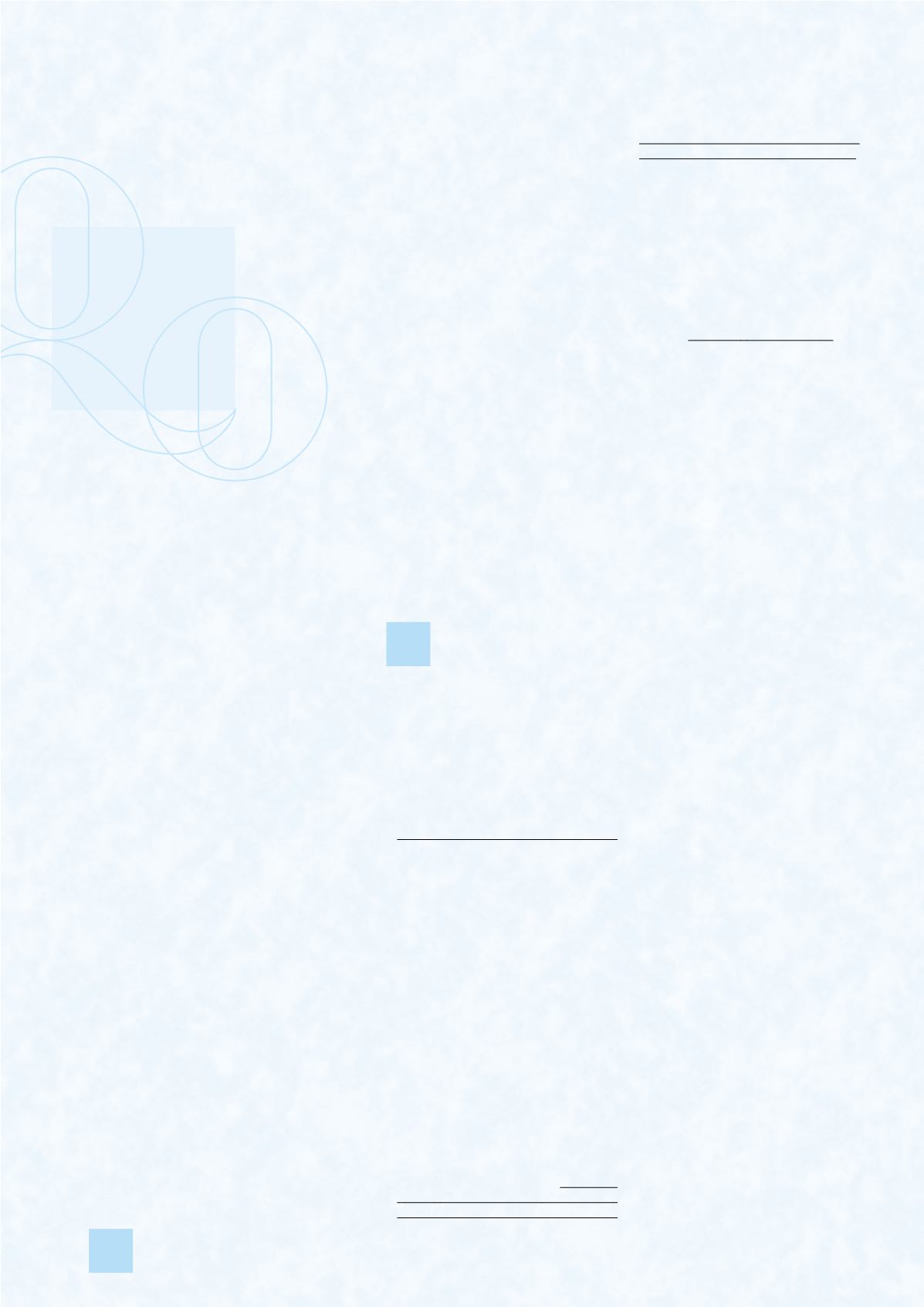
24
QUADERNI
DI
ORIENTAMENTO
21
ni di supporto sono state essenzial-
mente rivolte agli operatori:
• in primo luogo
formazione
, curata
dalla Dott.ssa Alessandra Selvatici
che, tra i primi in Italia, ha ap-
profondito la riflessione su questa
pratica professionale, per favorire il
trasferimento di know how specifico
sulla metodologia del bilancio a par-
tire dalla valorizzazione dell’espe-
rienza pregressa degli psicologi
orientatori su cui andavano “innesta-
te” nuove competenze;
• in secondo luogo
creazione e diffusio-
ne di materiali di supporto
. In questo
caso è stato realizzato un CD Rom
“Risorse per il bilancio di competen-
ze” contenente oltre ad una strumen-
tazione specifica, messa a punto sem-
pre dalla Dott.ssa Selvatici, un ap-
profondimento teorico-metodologico,
che è stato curato dal prof. Claude Le-
moine. Partendo con la sperimentazio-
ne in Friuli ci eravamo infatti accorti
che i materiali fin a quel momento
prodotti nel contesto nazionale sul bi-
lancio di competenze erano basati
prevalentemente sullo scambio di
buone pratiche (avendo come riferi-
mento l’esperienza dei CIBC francesi)
ma mancava uno strumento conosciti-
vo che permettesse di approfondire gli
aspetti scientifici e deontologici che
sottendono questa pratica professiona-
le. Il contributo di Claude Lemoine, in-
tegrato da altri contributi, non presen-
ti nel CD ROM, che testimoniano dei
percorsi progettuali, organizzativi e in-
dividuali che hanno segnato questa
sperimentazione, costituisce l’oggetto
del libro “Risorse per il bilancio di
competenze. Percorsi metodologici e
operativi” che viene dato oggi in di-
stribuzione ai partecipanti al conve-
gno e che vuole essere un ulteriore
strumento di supporto, a più ampia
diffusione rispetto al CD ROM. Infine,
una versione più “agile” di questi due
prodotti è stata resa disponibile anche
nella sezione “orientamento” del sito
regionale;
• in terzo luogo incontri di
assistenza
tecnica
e
supervisione
che hanno ac-
compagnato la sperimentazione.
Questi incontri sono serviti ad affron-
tare problematiche concrete legate
all’erogazione del servizio come:
la costruzione di rapporti con altri at-
tori istituzionali che operano nel cam-
po dei servizi per il lavoro, per la for-
mazione e l’istruzione (e qui solo un ri-
chiamo alla collaborazione proficua
che c’è stata fra Centri regionali di
orientamento e scuole che offrono cor-
si serali ai lavoratori per il consegui-
mento di un diploma, che sono un
esempio di come la rete di relazioni
già attiva fra scuole e Centri regionali
per l’orientamento scolastico ha trova-
to facilmente nuove sinergie nel cam-
zare e potenziare l’educazione perma-
nente degli adulti del 2 marzo 2000.
Certamente l’integrazione tra sistemi è
uno degli obiettivi di fondo di un siste-
ma di Educazione degli Adulti che de-
ve consentire l’acquisizione di titoli e
qualifiche professionali ma è significa-
tivo che in più punti il Documento sot-
tolinei l’importanza di un sistema EdA
che accresca la formazione libera del
cittadino (i suoi diritti di cittadinanza)
oltre che del lavoratore.
Il terzo documento fondamentale per
l’EdA è la Direttiva 22 del 2001 che
traduce l’Accordo del 2 marzo all’in-
terno del sistema dell’istruzione, foca-
lizzando l’attenzione sul ruolo dei
CTP, la loro collocazione territoriale e
le modalità di programmazione della
loro offerta formativa.
Rispetto al loro ruolo i CTP vengono
definiti “centri di servizio del sistema
di istruzione deputati all’attuazione
dell’offerta formativa integrata attraver-
so accordi di rete tra scuole di diverso
ordine e grado (art. 6). Il concetto di
“centri di servizio fa riferimento al ne-
cessario rapporto funzionale con altri
servizi territoriali, a partire dai servizi
per l’impiego.
Rispetto alla loro collocazione si prefi-
gura un rapporto tra Comitati Locali,
Enti Locali e Regione. Se ai comitati lo-
cali, in quanto luoghi di conoscenza
diretta del territorio, spetta il compito
di formulare proposte in merito all’isti-
tuzione dei CTP e alla loro dislocazio-
ne, è la Regione “d’intesa con gli EE.LL
e con il Dirigente dell’Ufficio scolasti-
co regionale, nel confronto con le par-
ti sociali, secondo gli obiettivi della
programmazione regionale dell’offerta
formativa” che definisce e decide la di-
slocazione dei CTP (art.6).
Per quanto riguarda la programmazio-
ne dell’offerta formativa dei CTP, non
saranno più i Centri a ricercare in pri-
ma persona le intese, gli accordi, le in-
tegrazioni e a costruire un Piano del-
l’Offerta Formativa rispondente ad una
propria lettura della esplicita e/o ipote-
tica domanda formativa degli adulti
nel territorio di riferimento ma i CTP
dovranno predisporre interventi per
l’EdA che siano “parte integrante della
programmazione locale dell’offerta
formativa svolta in attuazione degli in-
dirizzi e dei criteri contenuti nella pro-
grammazione regionale”. Le attività
dei CTP dovranno essere “coerenti con
la programmazione locale dell’offerta
formativa” e ad essa ricondotti “facen-
done ugualmente parte integrante”.
Era dunque prevista una complessa arti-
colazione per livelli, locale, regionale e
nazionale (il Comitato Nazionale avreb-
be dovuto individuare le priorità strate-
giche, gli indirizzi generali, le risorse at-
tivabili, le linee guida per la determina-
zione degli standard, del monitoraggio,
della valutazione, dei dispositivi di cer-
tificazione e riconoscimento dei crediti)
po dell’orientamento degli adulti);
la definizione di caratteristiche di
omogeneità nell’erogazione di bilanci
fra i diversi centri regionali;
la costruzione di strumenti di monito-
raggio della sperimentazione;
la supervisione su casi che ponevano
problematiche specifiche;
l’individuazione di forme strutturate di
collaborazione con esperti del mercato
del lavoro che possano in qualche mo-
do assolvere alla funzione della rete
interistituzionale dei CIBC presente in
Francia e assente nel nostro contesto
nazionale;
infine, anche questo
convegno
può es-
sere considerato un’azione di supporto
in quanto, se da un certo punto di vista
segna la “conclusione” di una fase di
lavoro e la condivisione dell’esperien-
za con gli attori che a livello locale e
nazionale operano nel campo dell’o-
rientamento, dall’altro, per il tipo di
contributo che è stato chiesto ai relato-
ri della prima sessione, “rilancia” verso
nuove piste di riflessione e pone nuove
sfide ai servizi che intendono occupar-
si di orientamento degli adulti.
Esperienze ed attività
dei Centri Territoriali
Permanenti
Valentina Goldschmidt
IRRE – FVG
Esperienze e attività dei CTP
1. Che cosa sono i CTP e a quali ne-
cessità formative dovrebbero rispon-
dere
L’Ordinanza Ministeriale 455 del 1997
che istituisce i Centri Territoriali Per-
manenti supera la precedente logica
puramente compensativa (recupero in
età adulta dei titoli di studio di base)
che aveva sostenuto i precedenti inter-
venti statali in materia di EdA. Gli
adulti, si sostiene coerentemente con
le indicazioni della Conferenza di Am-
burgo, hanno bisogno di continuare ad
apprendere durante tutta la vita come
condizione di una cittadinanza effetti-
va, per conseguire quelle abilità e
competenze richieste dai costanti cam-
biamenti e dalle caratteristiche della
società attuale. L’OM 455/97 chiama
ad interagire due sistemi paralleli,
quello della scuola e quello della for-
mazione professionale, per dare rispo-
ste sia alle domande provenienti dai
singoli che da istituzioni e mondo del
lavoro. L’enfasi sul tema del lavoro è
ripresa nell’altro documento fonda-
mentale riguardante l’EdA: L’Accordo
tra Governo, regioni, province, comu-
ni e comunità montane per riorganiz-