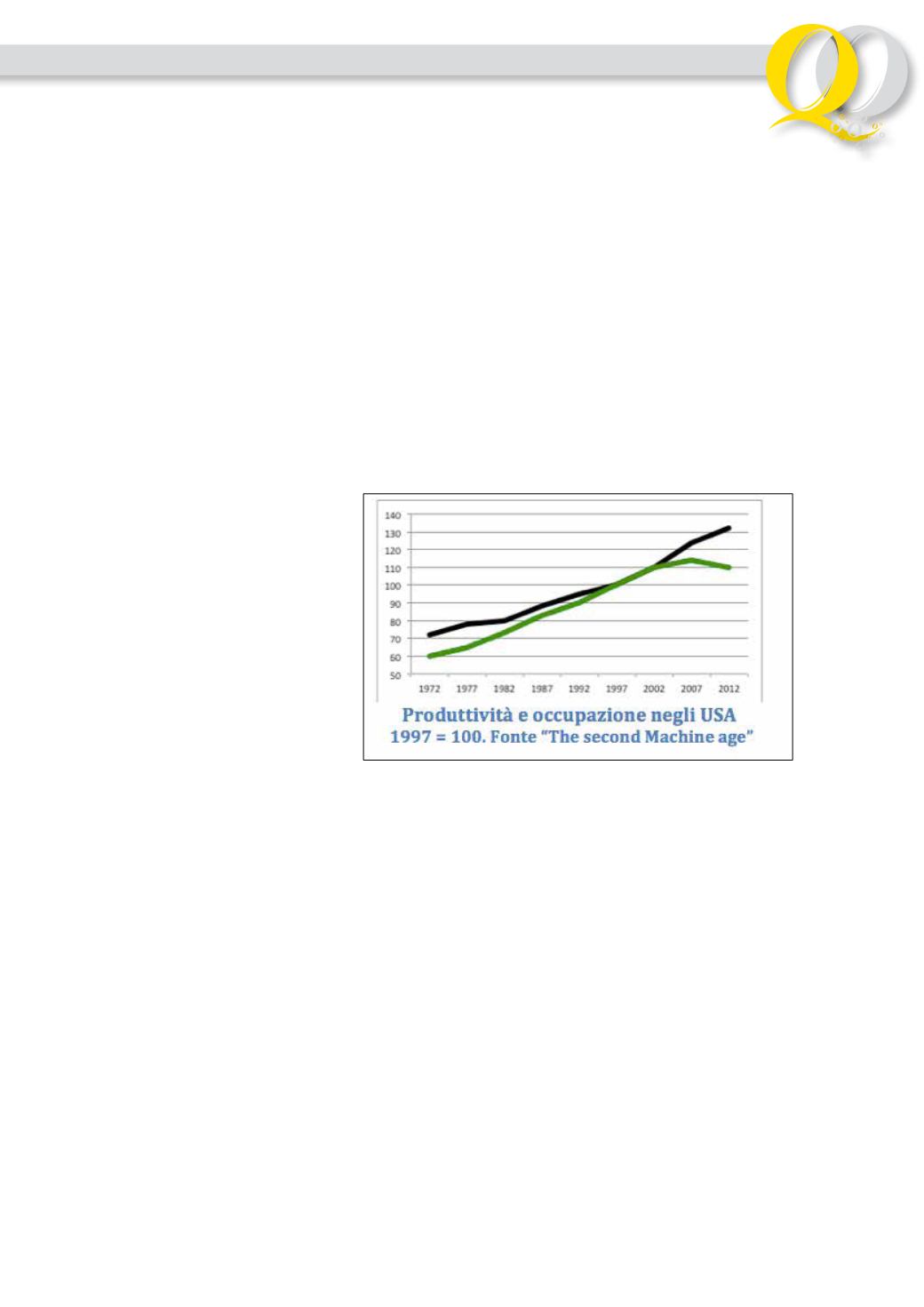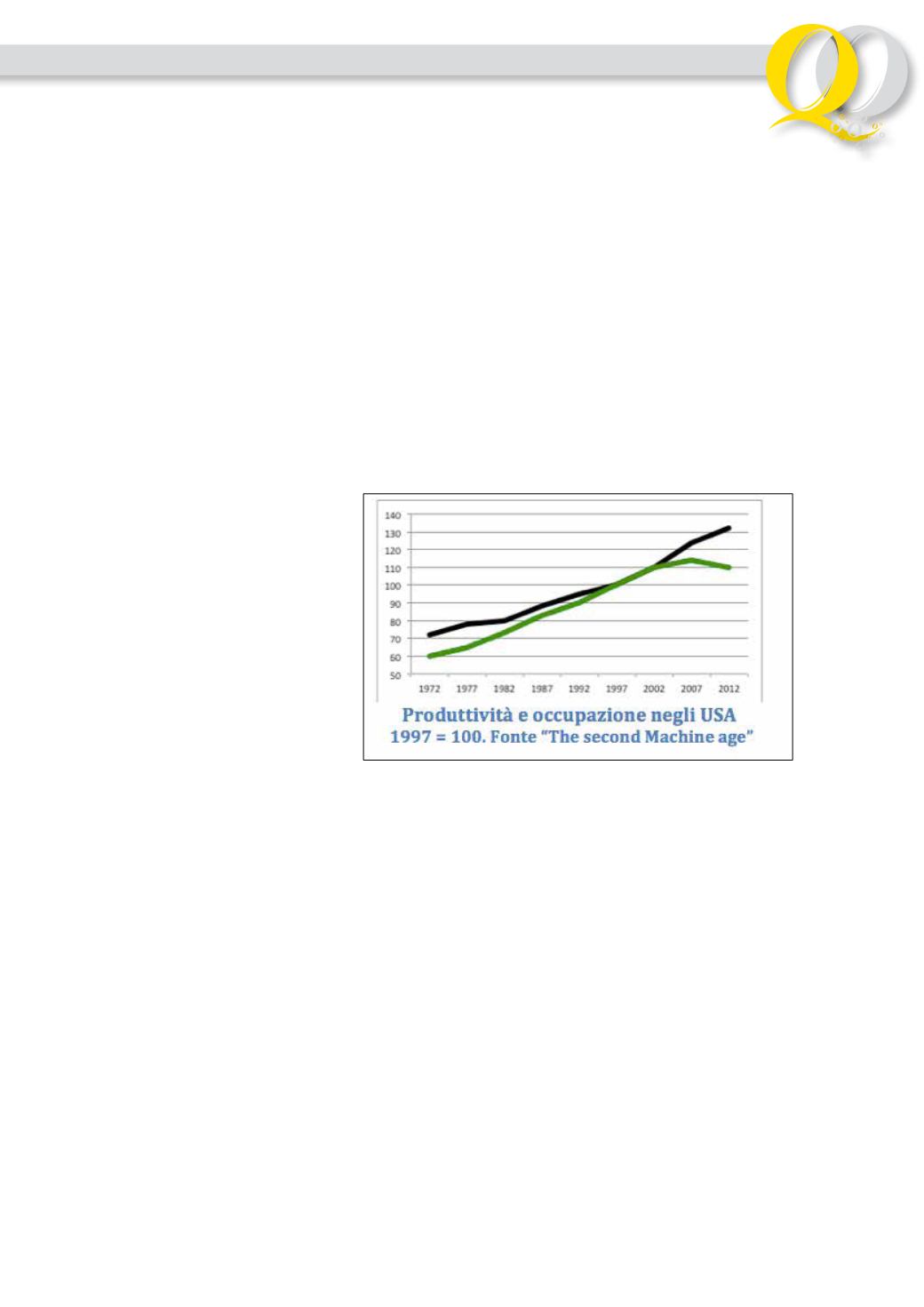
63
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 45
soprattutto
“The second Machine Age”
di
Brynjolfsson e McAfee (MIT) e, anche,
“The
future of Employment”
di Frey e Osborne
(Università di Oxford) e “
La società a costo
marginale zero”
di J. Rifkin.
UN PO’ DI STORIA
Lo sviluppo tecnologico è l’anima e il
motore di quello industriale. Fin da quan-
do, nella seconda metà del diciottesimo
secolo, Watt inventò la macchina a vapore,
l’era industriale e il tumultuoso sviluppo
che ha consentito di arrivare alle conquiste
sociali attuali (lavoro, welfare, benessere,
etc.) sono nati e si sono sviluppati sulle
conseguenze di innovazioni tecnologiche
che hanno reso possibili continui aumenti
(a volte salti) di produttività. E, sempre, una
nuova tecnologia ha avuto impatti sociali
rilevanti generando, sul medio lungo ter-
mine, un aumento di ricchezza e di lavoro e
una diminuzione di fatica, ma creando, nel
breve, anche problemi ai lavoratori: si pensi
ai movimenti Luddisti, nella prima metà
del diciannovesimo secolo in Inghilterra,
contro l’introduzione dei telai tessili, cau-
sa di riduzione di salari e disoccupazione.
Motore a scoppio, elettricità, telecomu-
nicazioni, tecnologie digitali hanno reso
l’attività lavorativa meno faticosa e l’occu-
pazione, nel complesso, è sempre cresciuta,
assorbendo, ogni volta, gli impatti negativi
temporanei con la creazione di nuove op-
portunità, nuovi prodotti e nuovi servizi.
Il progresso tecnologico ha sempre
avuto un duplice effetto sull’occupazio-
ne. Inizialmente, nel momento in cui la
tecnologia si sostituisce al lavoro umano,
c’è un effetto distruttivo, che richiede la ri-
allocazione dei lavoratori; successivamente
prende vita un effetto di capitalizzazione
dovuto alla espansione delle imprese per
l’aumentata produttività che genera un
aumento occupazionale.
Infatti, almeno fino al 2005, gli aumenti
di produttività negli USA sono sempre stati
accompagnati da aumento di occupazione.
Ma l’idea che la tecnologia possa, prima
o poi, accelerare ad un ritmo e a una dif-
fusione superiore alla possibilità di creare
nuova occupazione, diminuendo la do-
manda di lavoro complessiva e lasciando
molto più tempo libero ai lavoratori, non ha
mai abbandonato il pensiero economico.
Già J. M. Keynes, nel 1930, nel trat-
tato
“Economicpossibilities for our-
Grandchildren”
scriveva
“Stiamo per es-
sere colpiti da una nuova malattia, di cui
molti lettori non hanno mai sentito, ma di
cui sentiranno molto negli anni futuri, che
chiamo
disoccupazione tecnologica
, dovu-
ta alla scoperta di mezzi che economizzano
l’uso del lavoro a un ritmo superiore alla
possibilità di trovare nuovi sbocchi per il
lavoro stesso”
. Keynes ipotizzò comunque
un futuro migliore, nel quale, grazie alla
tecnologia, i bisogni materiali sarebbero
stati soddisfatti lavorando molto meno,
fino a 15 ore a settimana, consentendo un
ampio utilizzo di tempo libero.
Si è avverata la profezia di Keynes? Solo
in parte, per ora, nel senso che il maggior
tempo libero si è materializzato non co-
me riduzione dell’orario settimanale, bensì
come aumento degli anni attivi in cui non
si lavora (studio, pensione, aumento vita
utile): le ore dedicate al lavoro, con riferi-
mento al totale della vita attiva di veglia
disponibile, sono passate, in un secolo,
dal 35% al 20%. Lavoreremo anche molto
meno? Secondo gli autori e i testi citati
nell’introduzione questo potrebbe essere
uno degli effetti della crescente automa-
zione e informatizzazione.
Certamente lo sviluppo di queste tec-
nologie è stato rallentato, nelle ultime due