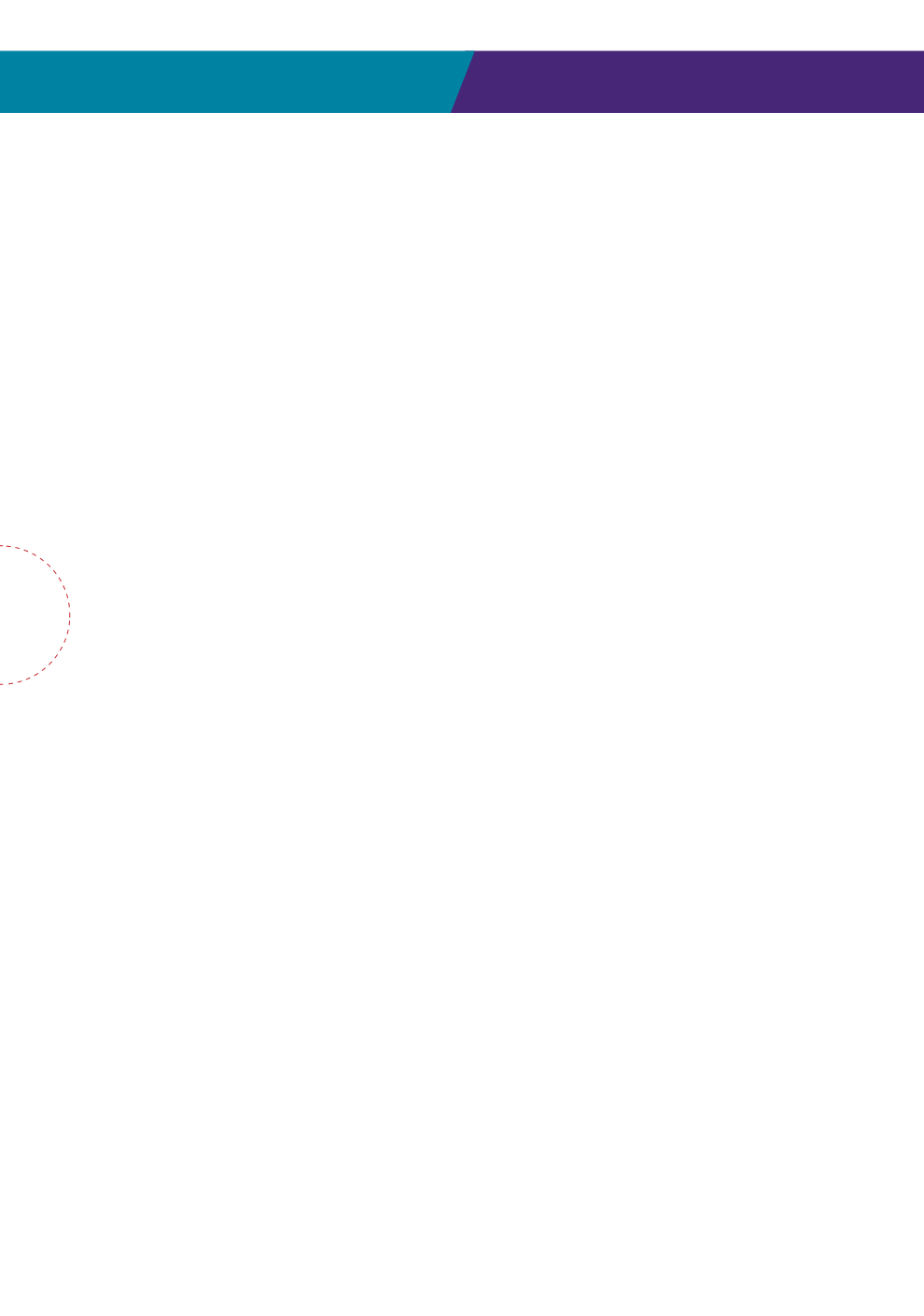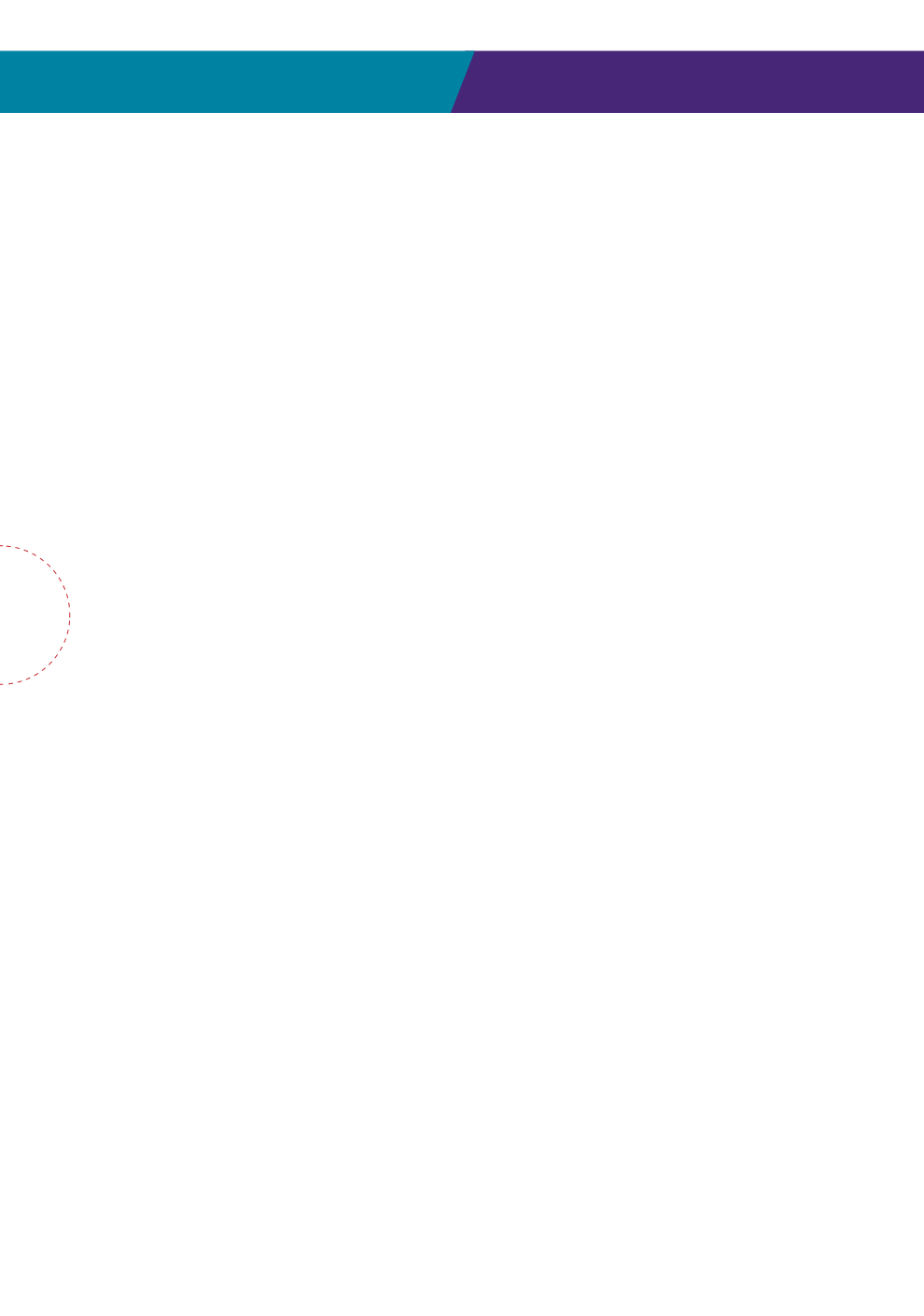
54
tutti gli studenti è difficile. Tuttavia alcuni profes-
sori ci riescono… Nel nostro appello chiediamo
maggior attenzione agli studenti come persone,
alle loro problematiche e insicurezze. Non sia-
mo numeri e desidereremmo la possibilità di
avere un dialogo con i docenti che dovrebbero
interagire di più anche tra di loro, scavalcando
possibili antipatie personali per il bene comune
e una miglior organizzazione. Il tutto andrebbe
a giovare alla progettazione di attività tra le
classi. I docenti dovrebbero inoltre essere in
grado di impartire un metodo di studio che si
basi meno sulla pura memoria ma piuttosto sul
ragionamento e la logica in modo che le cose
studiate rimangano impresse a lungo termine.
Importante ma sottovalutata dagli insegnanti
stessi, è una seria attività fisica, i cui benefici,
tra i quali la disciplina e lo spirito di sacrificio,
dureranno per tutta la vita. Vorremmo quindi
anche la possibilità di praticare più esercizio
fisico, e nella nostra visione utopica lasciamo
spazio a una scuola in cui viene fatta dell’attività
motoria ogni giorno.
Per quanto riguarda le classi, abbiamo già
uno spunto interessante: il numero di studenti
presenti. Nel nostro Liceo le varie classi rag-
giungono le venticinque presenze in aula e, in
qualche caso, tocca le trenta. Fare lezione in
classi così numerose non è possibile: su trenta
alunni, difficilmente tutti ascoltano, alcuni magari
sono in disparte e distanti dall’insegnante che
spiega e non sono coinvolti. Complicato è pure
gestire le verifiche orali: per interrogare, diciamo
quattro ragazzi alla volta, si sta più di sette ore.
Va abbastanza bene nel caso in cui si tratti di
una materia da quattro ore la settimana, ergo
in breve tempo si potrebbe aver finito. Però, chi
ha due ore che fa? Ci mette un mese? Tutto
ciò, ovviamente, salvo i frequenti imprevisti. E’
impossibile negare che le classi meno numerose
lavorino meglio e che l’ambiente sia più sereno:
essendo in numero inferiore, tutti hannomodo di
conoscersi meglio e anche gli inevitabili gruppetti
saranno sempre più uniti e solidali tra di loro.
Sarebbe da porre un limite, da rispettare non solo
a livello teorico, di venti studenti per classe. Per
quanto riguarda il programma delle variematerie,
parlando tra di noi, più d’uno ha notato di aver
studiato lo stesso identico argomento in cinque
materie differenti, quasi contemporaneamente.
Un esempio? Il Medioevo: i linguisti lo studiano
per italiano, storia, inglese, tedesco e francese e
spagnolo. D’accordo che si presenta la possibilità
di imparare vocaboli nuovi, ma soltanto con le
lingue. Gli insegnanti di storia e italiano, per
esempio, si potrebbero accordare, di modo che
l’argomento sia affrontato in unamateria sola. Si
favorirebbe così un risparmio di tempo ed energia
per uno dei due docenti che potrebbe occuparsi
di un altro argomento attinente a più materie.
Oppure potremmo prendere spunto dal sistema
scolastico finlandese che organizza il programma
scolastico per argomenti e non per materie, in
modo di affrontarlo a trecentosessanta gradi,
ma evitando ripetizioni e perdite di tempo.
“Vergognoso” è l’aggettivo che abbiamo
utilizzato per descrivere le lacune dei nostri
coetanei (sottoscritti compresi) in merito alla
geografia. Nelle scuole si studia soltanto durante
il biennio, però secondo noi andrebbe prose-
guito. Abbiamo fatto mente locale e tutti noi ci
ricordiamo di non toccare la geografia italiana
(monti, fiumi, città…) dalla quarta elementare
circa. Ma come? Certi argomenti, si vedano per
esempio la tettonica a zolle o astronomia, ven-
gono affrontati alle elementari, alle medie e alle
superiori. E la geografia no? Non è importante?
Sì, certo che se un ragazzo sente delle lacune
cercherà (o, almeno, dovrebbe) di approfondire il
discorso e non rimanere nell’ignoranza. Però, dai,
diciamocelo: vuoi per pigrizia o per disinteresse,
sono davvero pochi i casi in cui un giovane si
attiva in questo senso.
Facendo brain-storming tra di noi è emersa