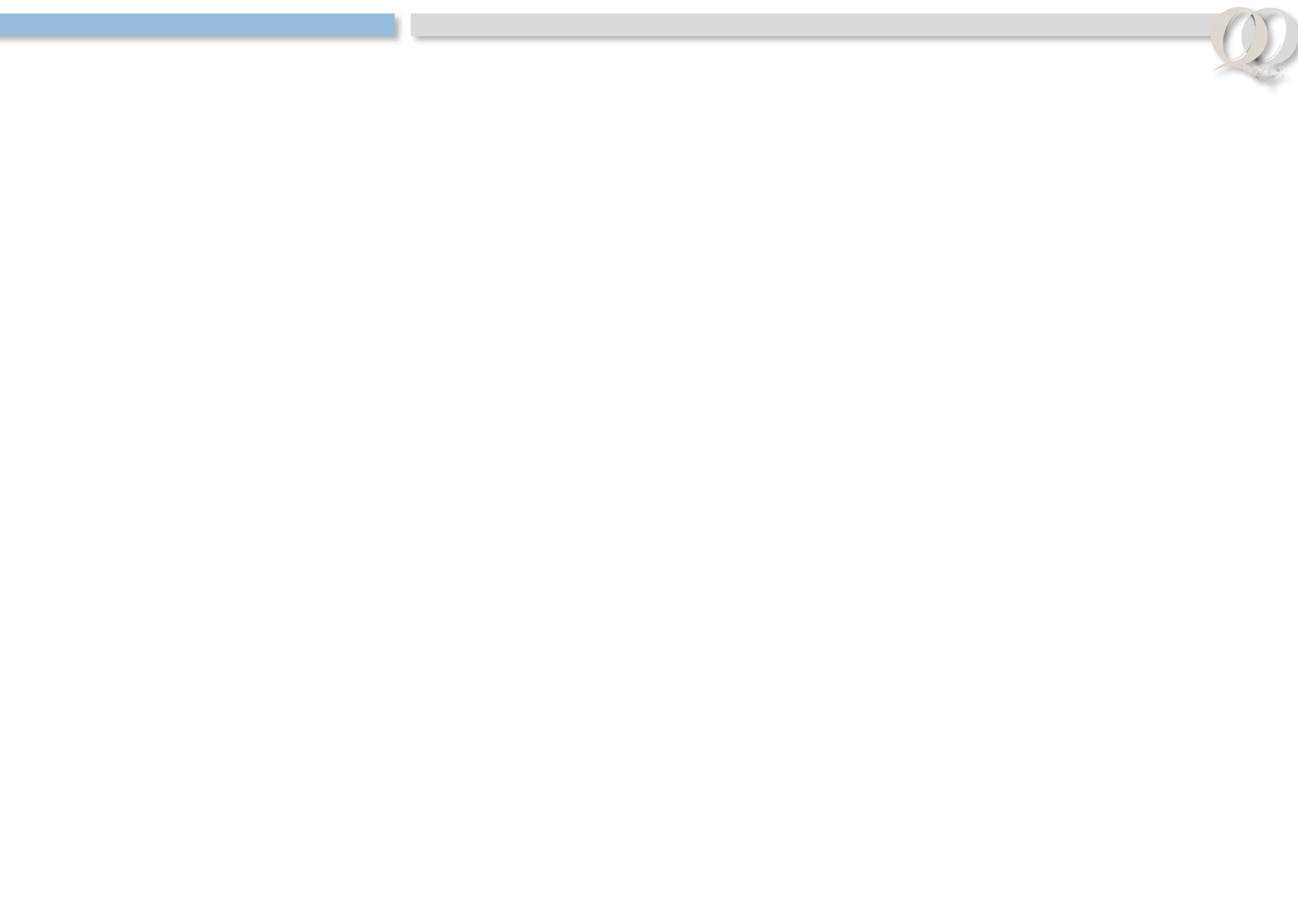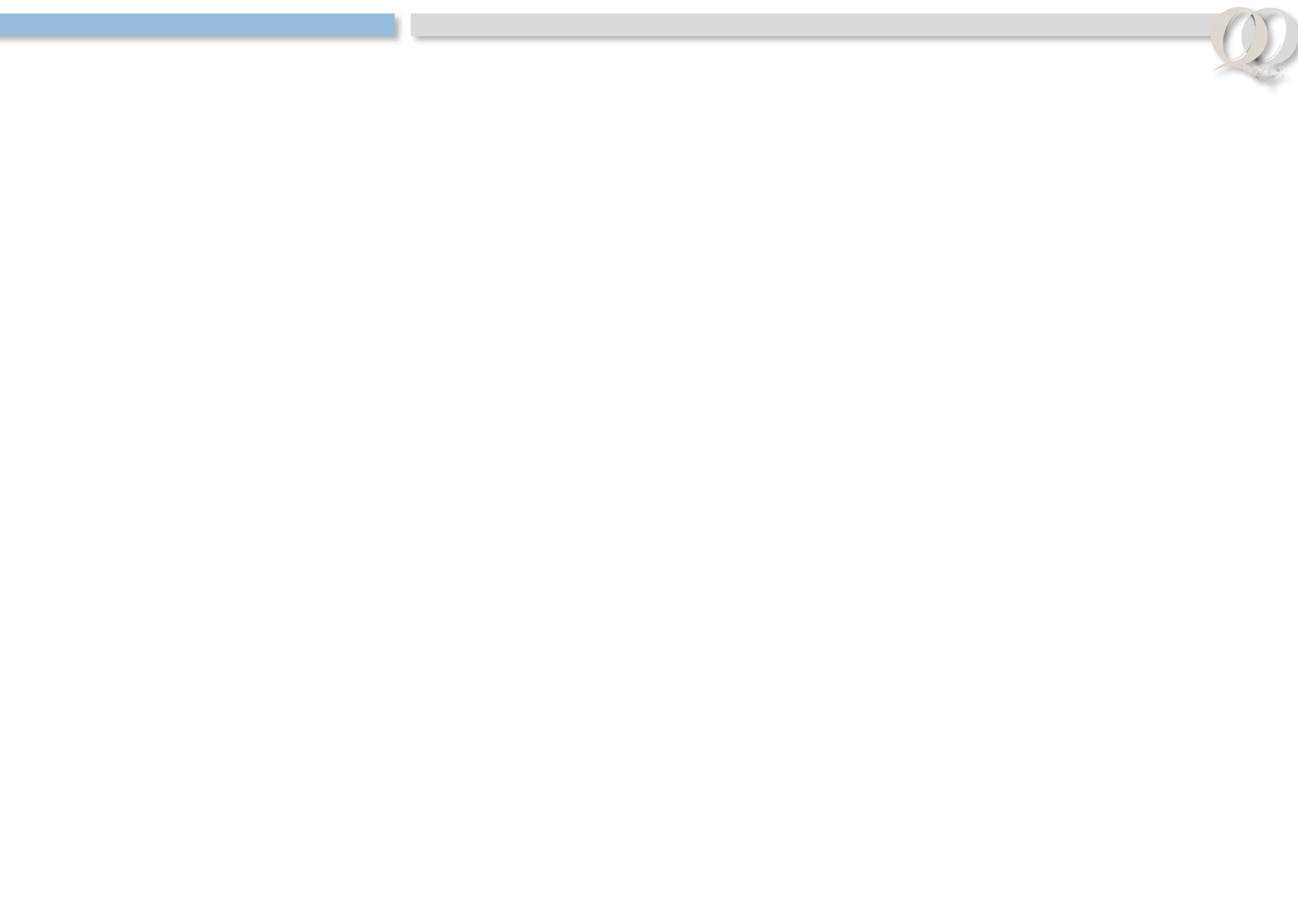
72
73
SPAZIO APERTO
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 48
LA LETTURA COME
FORMAZIONE
Bisogno di indagare, sistemare e
comprendere
Alessandra Merighi
dere coscienza delle ferite segrete che ci
portiamo dentro di noi
”, afferma Orhan
Pamuk nel suo“
La valigia di mio padre
”,
ferite così segrete che noi stessi ne sia-
mo a malapena consapevoli, esplorarle
pazientemente, studiarle, illuminarle, e
fare di queste ferite e di questi dolori
una parte della nostra scrittura e della
nostra identità”.
Un’inquietudine, quindi, un bisogno
di indagare, di sistemare e di compren-
dere, all’origine di ogni pagina scritta.
Un’esigenza forte, insopprimibile, non
sempre trasparente.
In “
Piangi pure
”, Lidia Ravera si pone
un obiettivo preciso: immergersi nella
vecchiaia e sconfiggerne la paura.
Il romanzo racconta la storia di una
donna anziana che si innamora dello
psicanalista del piano di sotto, e con il
quale beve il caffè da tre anni.
Il suo sarà un amore corrisposto e
gratificante, un grande ed inaspettato
regalo. Insieme a lei, la Ravera combatte
e demolisce lo stereotipo che identi-
fica la vecchiaia con una stagione di
progressiva perdita ed inaugura una
concezione più felice della maturità,
esperienza individuale, da costruire con
arte, capace di concedere, ancora, tante
emozioni.
Nei suoi romanzi, Niccolò Ammaniti
si tuffa nel pianeta adolescenza e ne
perlustra, di volta in volta, alcuni aspetti
significativi.
In “
Anna
”, il più recente, immagina
che un virus micidiale colpisca ed uc-
cida tutti gli adulti della Terra e risparmi
i ragazzini, che ne sono immuni.
Tra di loro, spiccano due fratellini
rimasti orfani, Anna, di tredici anni, e
Astor, più piccolo. Anna dovrà imparare
a pensare per due e a salvare entrambi,
seguendo le istruzioni per vivere che
la mamma ha lasciato in un quaderno.
Tra mille difficoltà ed incertezze, Anna
dovrà salvare il mondo, sostenuta dalla
potenza incontrollabile della vita, per-
ché, come scopre ad un certo punto,
“la vita non ci appartiene, ci attraversa”.
Eraldo Affinati è un caso complesso.
Nel suo “
La città dei ragazzi
”, racconta
la propria esperienza di insegnante in
una comunità fondata da un prete ir-
landese nell’immediato dopoguerra per
provvedere ai giovani rimasti soli, ed
ora destinata a bambini ed adolescenti
provenienti da tutto il mondo.
In un primo momento, sembra che il
combustibile della sua scrittura sia stato
il desiderio di scoprire che cosa abbia
spinto i suoi alunni a lasciare case, ge-
nitori e lingue, e a fuggire. Per scanda-
gliare meglio una realtà completamente
diversa dalla sua, parte con due di loro
per il Marocco, da dove erano partiti.
Quel viaggio, all’inseguimento delle
loro radici, diventa un’odissea personale
alla ricerca della figura del padre, ora
scomparso, figlio illegittimo, orfano e
privo di guida.
Osservando il comportamento dei
ragazzi, Affinati capisce che cosa signi-
fichi crescere senza una presenza tanto
importante, quali siano gli esiti di un’in-
fanzia privata della figura genitoriale,
quali le ripercussioni nel futuro adulto,
e riferisce queste scoperte a suo padre.
Finalmente inizia a comprenderlo, nella
comprensione lo ritrova e ne diventa il
padre stesso. Il groviglio originario che
lo aveva spinto a prendere la penna si
è, in parte, disciolto, e trasformato in
una nuova consapevolezza che aiuta.
Affinati arriva a quello che Pamuk
chiama il ‘centro’ del romanzo, un’intui-
zione, uno sguardo diverso, che ricom-
pone un’ansia e dona sollievo.
Il lettore si inserisce nella stessa dire-
zione, accetta la sfida lanciata dall’autore
e lo insegue, a caccia del ‘centro’che gli
è più congeniale e risponde alle sue esi-
genze. Entrando nella narrazione come
personaggio, adotta un nuovo punto
di vista, vive una vita ed un’esperienza
diverse, e ne coglie quanto gli serve, alla
luce dei propri bisogni.
Nessuno troverà messaggi espliciti,
né risposte concrete, l’autore non ne
offre, anzi, le rifugge.
Attraverso la scelta degli argomenti
e la modalità con cui li racconta, egli
lascia una traccia di sé e propone la sua
interpretazione della vita. Affida gli ideali
in cui crede ai suoi personaggi, al loro
modo di agire, di prendere decisioni e di
rapportarsi con gli altri, ma non impone
una direzione.
Il lettore fa suoi i valori che predilige,
se ne serve per costruirsi una morale
autonoma e regala una nuova identità
al testo, che rinasce con lui.
Leggendo, comprende se stesso e
il mondo; partendo da sé, riorganizza
la realtà.
Un adolescente può seguire questo
percorso solo se il libro che si trova tra
le mani è quello giusto. Un’esperienza
negativa rischia di compromettere il fu-
turo del giovane lettore e di allontanarlo
definitivamente dalla lettura.
LA LETTERATURA PER
RAGAZZI
Ai ragazzi deve essere rivolta una let-
teratura essenzialmente narrativa, da
‘ingurgitare’tutta d’un fiato, senza sovra-
strutture o risvolti metatestuali, almeno
nelle prime fasi di avvicinamento.
A loro piacciono le storie coinvolgen-
ti, burrascose, ricche di sentimenti ed
emozioni, trasferite sulla carta con un
linguaggio vivace, accattivante, poco
prevedibile. Storie che parlano di sé.
Le tematiche devono riguardare la
L’ORIGINE DELLA
SCRITTURA
“Giungere in una spiaggia dopo una
tempesta, vedere che cosa è stato ri-
sparmiato, raccoglierlo e metterlo in
ordine…”. C
on questa suggestiva ed
originale immagine, Roberto Cotroneo
spiega l’origine della scrittura.
Nel corso della vita, ognuno si misura
con le proprie tempeste, più o meno
profonde, più o meno feroci.
Si può soffrire per un tradimento, una
morte, una separazione, un’incompren-
sione, e per mille altri motivi. Comun-
que, alla fine, ci si sente spiazzati, esiliati,
congelati.
Poi, lentamente, si cerca di reagire, di
ri-collocarsi nel flusso e di ri-occupare
un posto nel mondo, con qualsiasi stra-
tegia, anche con la scrittura.
Non appena i toni si sono smorzati e
la bufera placata, si perlustra il paesag-
gio, si prende quanto rimasto, e con
quello si tenta di ritrovare un ordine e
un senso.
L’operazione incute una certa paura:
potrebbe essersi salvato poco, troppo
poco, e non essere sufficiente al recupe-
ro di un significato in grado di rimettere
in moto. Per proseguire ci vuole corag-
gio, ma il coraggio arriva perché il silen-
zio e il vuoto che non si esprimono sono
più dolorosi, in ultimo, insopportabili.
“
Per me, essere scrittori significa pren-