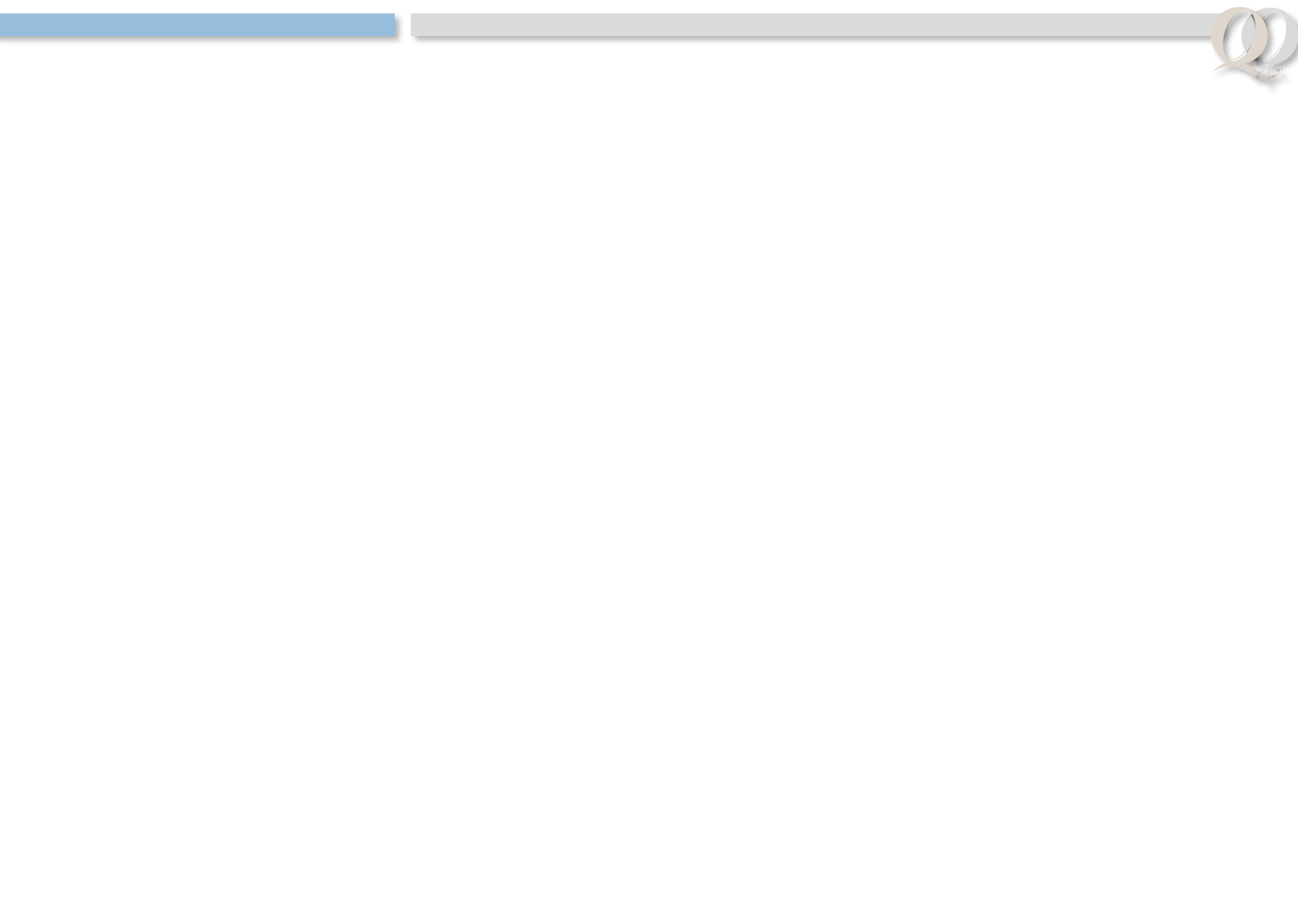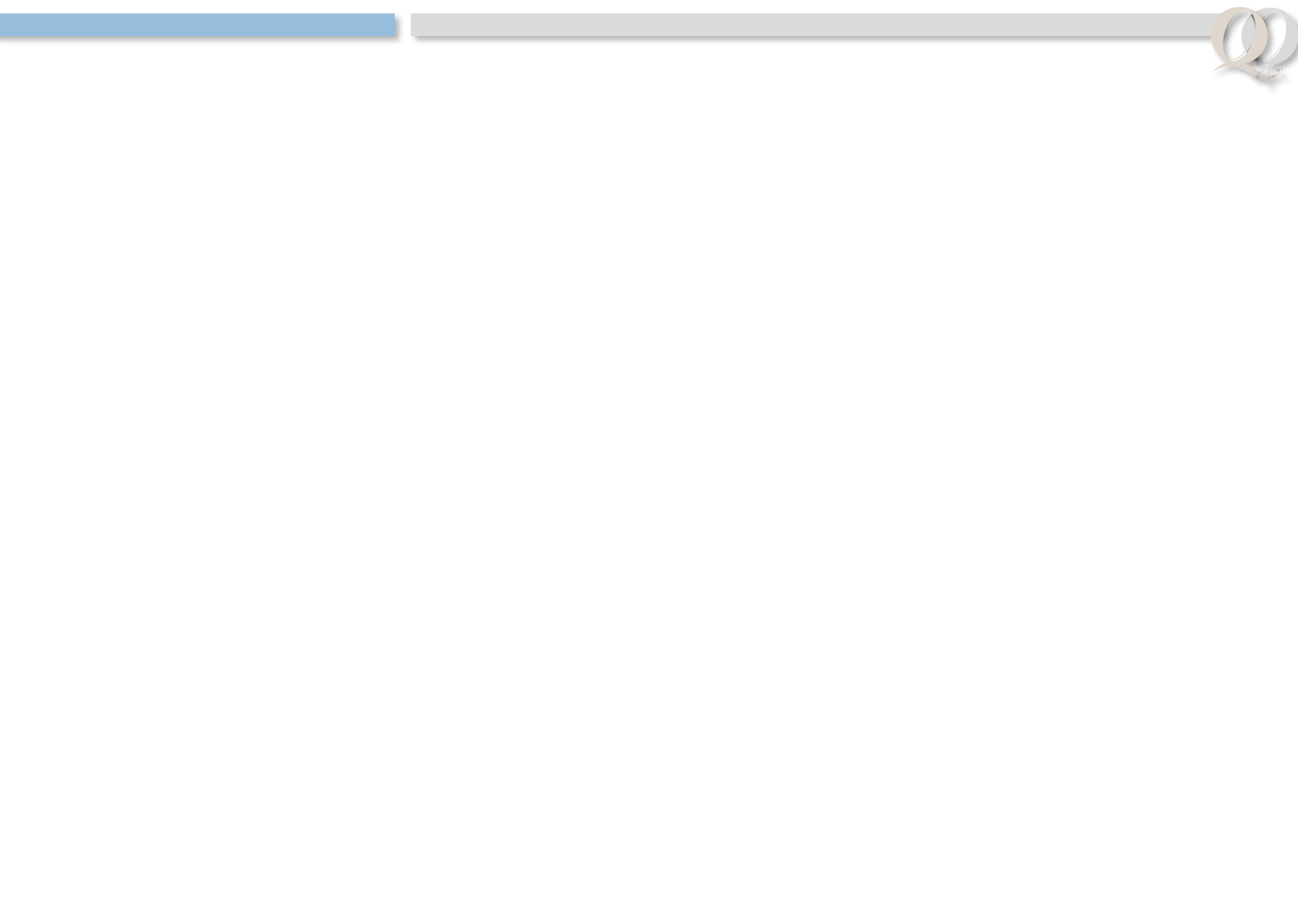
74
75
SPAZIO APERTO
QUADERNI DI
ORIENTAMENTO 48
loro quotidianità: amicizia, amore, mor-
te, rapporto con il corpo, paura, rabbia,
tradimento, piacere, attesa, sorpresa,
famiglia, violenza fisica e psicologica
sono le più fortunate.
Solo narrazioni di questo genere,
assolutamente prive di suggerimenti
morali o di giudizi impliciti, entrano nel
loro vissuto e lasciano qualcosa.
“
Le lacrime dell’assassino
”, di Marie
Aude Murail, è la storia di un ragazzino
che vive nell’America del Sud con due
genitori poco attenti e disponibili. Lui
cresce da solo, cacciando serpenti e
scorpioni.
Un giorno, arriva alla fattoria un uo-
mo, che uccide i due adulti e risparmia
il bambino, pensando che potrà esser-
gli utile.
Tra i due nascerà una relazione che,
col tempo, sfocerà nell’amicizia. Entram-
bi orfani, troveranno, uno nell’altro, la
possibilità di condividere e di provare
dell’affetto.
La vicenda, apparentemente mo-
struosa, pone immediatamente una
domanda-bomba: come può accadere
che un bambino diventi amico dell’as-
sassino dei suoi genitori?
Non esistono risposte. Chiuderebbero
una questione che, invece deve rima-
nere aperta, per consentire a chi legge
di trovarvi quel qualcosa che, prima o
poi, potrà essergli utile o, addirittura,
venire in suo soccorso, ad esempio l’idea
di non dare mai nulla per scontato e di
andare sempre a fondo nelle diverse
contingenze dell’esistenza.
La letteratura non deve insegnare,
può solo educare. Se insegnasse, e quin-
di trasmettesse competenze, tradireb-
be se stessa. Le è consentito educare,
letteralmente ‘condurre fuori’, dal noto,
dal banale, dallo scontato, dal chiuso,
spalancare, andare oltre.
Stanley Fish, uno dei più noti studiosi
statunitensi di teoria letteraria, nel suo
illuminante saggio dal titolo“
C’è un testo
in questa classe?
”, spiega che un libro
deve provocare un ‘evento’ nel lettore.
Usa proprio la parola ‘evento’, intenden-
do con essa, una modificazione della
percezione delle cose, passo necessario
nella formazione della persona.
Ma questo si verifica esclusivamente
nel momento in cui il libro risponde a
determinate esigenze: nella fase in cui
il ragazzo sta lavorando per costruirsi
la propria personalità, facendo molta
fatica, un testo che gli parli di sé, del suo
corpo, delle sue relazioni con il mondo
e con gli altri, può segnare un traguardo
e divenire una carica di energia.
“
Niente
”, di Janne Teller, racconta la
storia di un bambino che rifiuta tutto e
sale su di un albero perché si accorge
che niente ha senso.
I compagni di classe non capiscono,
non accettano, e iniziano ad innalzare,
ai piedi dell’albero, una pila, con tutti
gli oggetti che, secondo loro, danno un
senso alla vita. Dall’oggetto più sempli-
ce, si passa a quello più complesso, e si
giunge all’immateriale, fino al pegno più
alto, quello di una ragazza, che sacrifica
la sua verginità.
Anche in questo caso, ogni giudizio va
sospeso: la funzione del libro è mettere
in crisi il pensiero, stimolare la ricerca,
aprire un dialogo.
Tutto ciò accade solo se la narrazione
è verosimile, curata nel dettaglio, orga-
nizzata bene, senza stonature. Allora il
lettore sospende l’incredulità, abban-
dona ogni diffidenza, si identifica con il
personaggio, ne adotta il punto di vista
ed include nella propria coscienza nuovi
modi di essere.
Formativo, in questo senso, un ro-
manzo di Delphine De Vigan, “
Gli effetti
secondari dei sogni
”. Lou Bertignac è una
ragazzina di tredici anni, con un’intelli-
genza superiore alla media, schiacciata
dal peso di una famiglia trincerata nel
dolore, in seguito alla morte della sorel-
lina, appena nata e a lungo desiderata.
In una stazione dei treni, Lou incontra
No, un’adolescente con qualche anno
in più, fuggita da un passato difficile,
che ora si trascina come una randagia.
La loro amicizia cambierà le rispet-
tive vite.
Nel momento in cui i ragazzi ab-
bandonano il loro ego e ‘diventano’
No, mutano la percezione delle cose e
sconvolgono il significato di parole che
prima sembravano scontate. Casa, fami-
glia, affetto, dolore, distanza, speranza,
futuro… suonano in modo diverso; la
diffidenza nei confronti dei senza-tetto
sfuma in una concezione più sentita e
ragionata.
Un altro miracolo della letteratura è
quello di presentarci i personaggi nella
loro complessità, e non a partire da una
loro caratteristica, magari la più appari-
scente e negativa.
Nella realtà, questo non accade. Il
fatto di vivere per strada e di avere un
abbigliamento trascurato definisce la
persona, a prescindere da tutte le altre
componenti.
No indossa un maglione a buchi, una
sciarpa sfilacciata e ha le unghie nere.
A volte è diffidente e scontrosa, spesso
aspra, ma solo perché poco abituata
alle relazioni sociali. Eppure i ragazzi
ne vengono conquistati, seguono col
cuore la sua tormentata avventura e
scorgono, al di là dei tratti più vistosi,
una sensibilità particolare ed un intenso
bisogno d’affetto.
Conoscere il suo passato, li avvicina
a lei.
La lettura dei romanzi porta all’incon-
tro con altri individui, afferma Tzvetan
Todorov, in “
La letteratura in pericolo
”. “
I
romanzi non ci forniscono una forma
di sapere”,
prosegue
, “ma una nuova
capacità di comunicare con esseri di-
versi da noi; da questo punto di vista,
riguardano la morale, più che la scienza.
L’orizzonte ultimo di tale esperienza non
è la verità, ma l’amore, forma suprema
del rapporto umano
”.
E conclude dicendo:“
Al di là dall’esse-
re un semplice piacere, una distrazione
riservata alle persone colte, la lettera-
tura permette a ciascuno di rispondere
meglio alla propria vocazione di essere
umano
”.
Comprendere quale sia non è facile,
specie per gli adolescenti, ma la lettura
li può aiutare. Trovare nei personaggi
alcuni tratti di sé significa imparare a
conoscersi; riflettere e discutere delle
loro emozioni induce alla costituzione
di un vocabolario per l’analisi e la ver-
balizzazione delle proprie.
Essere consapevoli dei rispettivi stati
d’animo è molto importante, addirit-
tura necessario quando sono negativi
e quindi da eliminare. Solo compren-
dendo che cosa si nasconda dietro ad
un sentimento, si può iniziare a gestirlo.
L’auto-consapevolezza e l’autocon-
trollo sono le chiavi imprescindibili del
proprio benessere e portano ad evidenti
benefici sociali. Se un’offesa può scate-
nare una reazione violenta, capire che
cosa abbia spinto qualcuno a metterla
in atto è fondamentale, migliora le re-
lazioni e favorisce la tolleranza.
Un insegnante che si pone, tra gli altri,
anche l’obiettivo di aiutare gli studenti
a diventare ciò che sognano, restituisce
loro una motivazione in più nei con-
fronti della scuola. Smantella l’idea che
il professore stia in cattedra soprattutto
per giudicare, in base ad un profitto,
termine proveniente dal mondo eco-
nomico e doppiamente inadeguato, e
reintroduce quell’educazione ai senti-
menti che potrebbe riempire il vuoto
emotivo ed esistenziale di tanti ragazzi.
La scuola potrebbe riappropriarsi del
suo ruolo di agenzia educativa, essere
in grado di offrire un’esperienza a tutto
tondo, non solo in termini di successo
o insuccesso scolastico, ma come op-
portunità di socializzazione, di condivi-
sione, di promozione della persona. Se i
ragazzi vi trovassero anche questo, forse
sarebbero meno esposti ai tanti fattori
di rischio che, sempre di più, possono
minare i loro percorsi evolutivi.
Alessandra Merighi
Docente IIS “F. Flora”
Pordenone