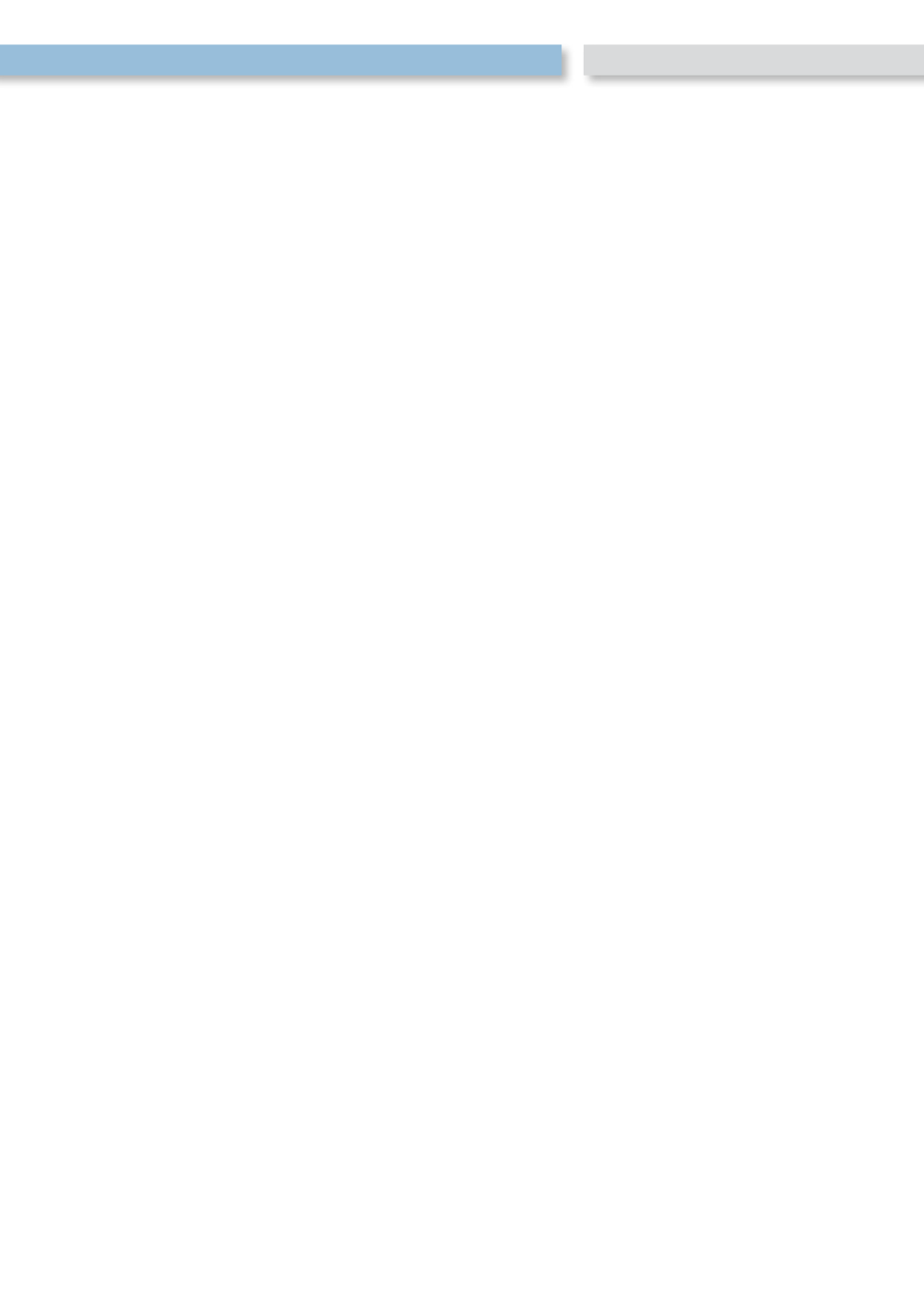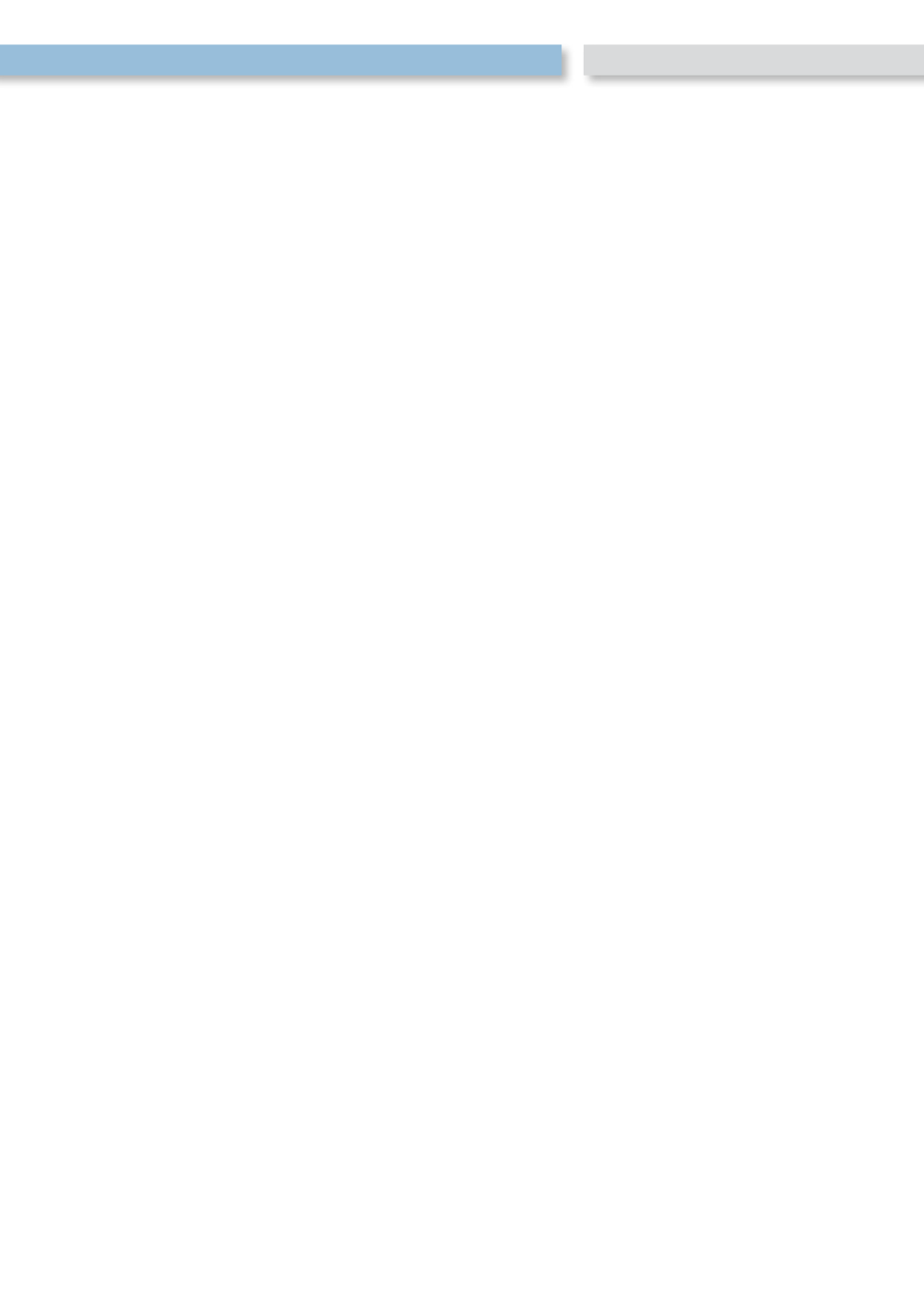
88
SPAZIO APERTO
del proprio essere sessuati ed è il risultato
di un complesso processo di costruzione
influenzato da aspetti biologici, educativi
e culturali. Essa si compone di:
l
sesso biologico, definito dai cromosomi
sessuali come maschile o femminile;
l
identità di genere, cioè il percepirsi e vi-
versi profondamente come maschio o
femmina. Esso è un tratto permanente
influenzato da elementi biologici e ap-
prendimento sociale;
l
ruolo di genere o ruolo sessuale, com-
prendente l’insieme di caratteristiche fi-
siche, di comportamento e di personalità
che la cultura di appartenenza dell’in-
dividuo convenzionalmente attribuisce
e quindi si aspetta dagli uomini e dalle
donne;
l
orientamento sessuale: attrazione fisica
ed affettiva per persone del sesso oppo-
sto al proprio (orientamento eteroses-
suale), dello stesso sesso (orientamento
omosessuale) o entrambi (orientamento
bisessuale). L’orientamento sessuale si
costruisce in fasi precoci della vita su
fattori bio-psico-sociali.
Se quindi la sessualità risulta essere fon-
damentale nello sviluppo della persona e
uno degli aspetti più importanti della vita
di un individuo, i deficit fisici omentali, pos-
sono ostacolare un percorso volto al rag-
giungimento dell’appagamento sessuale. È
qui opportuno sottolineare come anche il
termine disabilità sia giovane, arricchito in-
fatti nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità dell’elaborazione dell’ICF,
3
un
metodo per descrivere e misurare la salute
e la disabilità della popolazione, ricompren-
dendo nel termine disabilità sia l’handicap
che la menomazione, precedentemente
catalogati, che non prendevano in con-
siderazione gli aspetti sociali e personali.
Con questa nuova definizione di disabilità,
si prospetta il superamento del modello
medico che si fonda sulle conseguenze
della malattia e si pone al centro della va-
lutazione il modello sociale, inteso come
il risultato dell’interazione tra la persona e
l’ambiente. In questa prospettiva sociale
anche la sessualità, parte integrante della
persona dovrebbe essere presa in consi-
derazione.
A supporto delle considerazioni pre-
cedentemente esposte, nel 1993, nella
Conferenza di Vienna, l’Assemblea gene-
rale ONU ha approvato un documento nel
quale viene riconosciuto a tutti i portatori
di handicap“
il diritto di fare esperienza del-
la propria sessualità, di vivere all’interno di
una relazione, di essere genitori, di essere
sostenuti nell’educazione della prole da
tutti i servizi che la società prevede per i
normodotati, compreso il diritto di avere
un’adeguata educazione sessuale”
.
Con questo documento l’ONU auspica
che tutti gli Stati membri si rendano pro-
motori del superamento degli stereotipi
culturali che ostacolano il riconoscimento
di tali diritti alle persone disabili (Veglia,
2000). Attualmente la Convenzione dell’O-
NU, ratificata dal Parlamento Italiano con la
Legge 3 marzo 2009 n.18 art. 25 comma a,
sancisce i diritti delle persone con disabilità,
compreso l’accesso ai servizi sanitari, nella
sfera della salute sessuale e riproduttiva.
LE DIFFICOLTÀ DI
FAMIGLIE, OPERATORI,
ISTITUZIONI
Seppure non cessiamo di proclama-
re il diritto delle persone diversamente
abili di avere le stesse possibilità in ogni
settore, facciamo fatica a riconoscere
l’accompagnamento alla vita affettiva e
sessuale come un tema sociale. Eppure
non è possibile non vedere la sofferenza
delle persone diversamente abili rispetto
a queste tematiche. In effetti il dibatterne
solleva problemi di ordine etico e allo
stesso tempo tecnico, medico, giuridico
ed economico, ma soprattutto ci met-
te a confronto con i nostri tabù e con
le rappresentazioni che abbiamo delle
persone in situazione di handicap (Nuss,
2008; Nuss, 2011).
Nel contesto dei rapporti di coppia si
parla più frequentemente di relazioni tra